
Il 19 aprile si è concluso il più grande processo contro la solidarietà in mare, con le Ong impegnate in operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale sul banco degli imputati. Ventuno membri degli equipaggi di Jugend Rettet, Save the Children e Medici Senza Frontiere sono stati prosciolti dal giudice dell’udienza preliminare di Trapani, perché “il fatto non sussiste“.
Questa vittoria arriva dopo sette anni di calvario, costato milioni di euro di soldi pubblici, oltre quaranta comparizioni in aula e il deterioramento dell’imbarcazione Iuventa, sequestrata e lasciata in stato di abbandono nel porto di Trapani dal 2017.
Ma come è nata la criminalizzazione delle Ong e della solidarietà in mare? Perché salvare vite in mare è una pratica così osteggiata dalle autorità italiane ed europee?
Nel 2013, dopo l’indignazione e le proteste per la strage di Lampedusa del 3 ottobre, che vide 366 vittime accertate a causa del naufragio, lo stato italiano lancia l’operazione militare e umanitaria Mare Nostrum: un ingente impiego di mezzi e risorse statali (circa 9,5 milioni di euro mensili) per “garantire la salvaguardia della vita dei migranti in mare e assicurare alla giustizia coloro che lucrano sul traffico illegale di migranti”. In tre mesi di operazioni “sar” (search and rescue) in acque internazionali, anche oltre le trenta miglia dalle coste nazionali e fino in prossimità di quelle libiche, Mare Nostrum porta al salvataggio di 189.741 persone.
Pochi mesi prima, Franco Roberti aveva assunto il controllo della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Ai suoi occhi, il traffico di esseri umani rappresentava una forma di criminalità organizzata contro cui la Dnaa poteva riacquistare il prestigio e l’influenza ormai scemati a distanza di molti anni dalla sconfitta delle grandi famiglie mafiose italiane.
Con il lancio di Mare Nostrum, Roberti inizia una serie di incontri tra polizia, marina, guardia costiera e magistratura, che proseguono per quattro anni e coinvolgono in seguito rappresentanti di Frontex, Europol e persino delle autorità libiche. In questo modo, la Dnaa si ritaglia un ruolo guida nel controllo della frontiera marittima sud-europea, mettendo gli strumenti investigativi della lotta antimafia al servizio del contrasto dell’immigrazione irregolare in Europa.
L’idea era di indagare proprio durante le operazioni di salvataggio, interrogando i naufraghi appena soccorsi nel momento di massima vulnerabilità; considerare chiunque agisse come membro dell’equipaggio o inviasse una richiesta d’aiuto come complice dei trafficanti libici, arrestando così i “pesci piccoli” per risalire nella catena del traffico fino ai “grossi”.
Secondo i documenti ottenuti da Lorenzo D’Agostino e Zach Campbell, nell’ambito dell’inchiesta “Friends of the Traffickers“, pubblicata in italiano da Internazionale, la strategia era stata elaborata almeno una settimana prima dei naufragi di Lampedusa. L’operazione Mare Nostrum aveva creato l’occasione giusta per metterla in atto. L’inchiesta ha inoltre rivelato che i massicci arresti di quegli anni, spesso a seguito di indagini sommarie e precipitose, riguardavano per lo più persone migranti che avevano pagato per affrontare il viaggio, e che i procuratori ne erano perfettamente consapevoli.
Le successive operazioni europee nel Mar Mediterraneo abbandonano definitivamente l’aspirazione umanitaria, concentrandosi sui pattugliamenti marittimi e aerei entro le trenta miglia dalle coste europee con l’obiettivo principale di contrastare “il traffico illecito di esseri umani”.
Il vuoto lasciato dal mancato soccorso da parte delle autorità europee, di fronte al moltiplicarsi delle morti in mare, spinge la società civile europea ad attivarsi, portando alla formazione delle prime navi di ricerca e soccorso in mare da parte delle Ong. L’impossibilità di svolgere attività di polizia sulle imbarcazioni delle organizzazioni umanitarie blocca di fatto le indagini della Dnaa, che per questo fa sapere di ritenere necessario “disciplinare l’intervento delle navi Ong”.
È in questo contesto che nel 2017 si inserisce Marco Minniti, allora ministro degli interni del governo Gentiloni. Sono gli anni in cui Salvini, grazie allo spin doctor Morisi, diventa una star su Facebook, sostenendo l’hashtag #StopInvasione e partecipando a proteste fuori dai centri di accoglienza; gli anni in cui le bufale sul web, come i trenta euro al giorno regalati ai richiedenti asilo, i “taxi del mare” o “i migranti negli hotel di lusso mentre gli italiani per strada”, trovano sempre più spazio non solo sui social ma anche su rinomate testate di destra e popolari talk show del palinsesto Mediaset.
Da un lato, nasce la necessità di eliminare un osservatore neutrale scomodo in una zona di mare dove spesso vengono violati i più basilari diritti umani; dall’altro, la pressione dell’opinione pubblica sul tema migratorio spinge il Partito democratico a fare una scelta critica: piegarsi alla narrazione della destra sulla fantomatica invasione, cercando di bloccare i flussi migratori alla partenza. Da qui la celebre frase di Minniti: “I flussi epocali vanno governati, è a rischio la tenuta democratica dell’Italia“.
Si decide quindi di affrontare il fenomeno su due fronti principali: in Libia e in mare.
La Libia non è un paese qualsiasi. In Libia ci sono enormi giacimenti di petrolio e dall’inizio della guerra civile l’Italia e la Francia conducono una guerra per procura per contendersi queste risorse. Forte quindi della sua presenza sul territorio, Minniti elabora un piano per fermare i flussi all’origine, portando al contempo vantaggi al primo ministro Al-Serraj, leader della fazione della Tripolitania.
Questa strategia prevede l’istituzione di una zona Sar libica, l’addestramento della cosiddetta guardia costiera libica, anche in territorio italiano, nonché la fornitura di motovedette, attrezzature e il supporto logistico e di intelligence. Oltre ai respingimenti via mare, Minniti convoca alla Farnesina circa sessanta rappresentanti delle formazioni paramilitari e delle tribù del Fezzan per organizzare i respingimenti anche nel deserto.
Sul fronte marittimo, viene introdotto un codice di condotta per le Ong, che, oltre a interdire l’intervento delle stesse in zona “sar” libica, prevede l’inserimento di agenti di polizia a bordo per identificare e arrestare i conducenti delle imbarcazioni soccorse. Quasi tutte le Ong rifiutano di adeguarsi a un codice radicalmente in contrasto con i loro principi fondanti e con la loro missione. La conseguenza è uno scontro frontale con le autorità italiane.
La stagione della criminalizzazione delle Ong inizia ufficialmente il 2 agosto 2017, quando, dopo mesi di indagini e intercettazioni, Minniti sferra il primo colpo, sequestrando la nave da soccorso Iuventa. Quello che la stampa definisce “processo Iuventa” è diventato il simbolo della criminalizzazione della solidarietà in mare e delle campagne diffamatorie contro le Ong. Tre i principali punti di accusa: le Ong sarebbero il pull factor per le migrazioni nel Mediterraneo; sarebbero coinvolte in accordi con la mafia libica per facilitare l’ingresso non autorizzato di persone in Europa; guadagnerebbero denaro in collaborazione con la mafia libica attraverso il traffico di esseri umani. Infine, le Ong sarebbero anche le principali responsabili del cosiddetto “allarme immigrazione” in Italia, arrivando a ipotizzare a loro carico il risarcimento del costo di tutte le operazioni di pattugliamento e del danno d’immagine che lo stato italiano avrebbe subito a causa del fenomeno migratorio, oltre alla responsabilità di aver provocato allarme tra la popolazione.
Le udienze preliminari iniziano il 21 maggio 2022 a Trapani e procedono molto lentamente. Le accuse sono pesantissime, con pene che arrivano fino a venti anni di carcere e milioni di euro di sanzioni, circa 16 mila euro per ogni persona soccorsa, e la Iuventa ne ha salvate più di quattordicimila nel suo breve anno di attività. Agli imputati non viene neanche garantita una traduzione adeguata delle trentacinquemila pagine che l’accusa ha raccolto contro di loro. Durante gli interrogatori, vengono forniti interpreti non specializzati in ambito giuridico, come per esempio una guida turistica e un ex poliziotto in pensione. Tutto questo ha messo in luce un problema sistemico della giustizia italiana nei confronti di cittadini stranieri: chi non ha le risorse per avvalersi di traduttori privati e viene perseguito in processi meno mediatizzati, non ha accesso a una traduzione e interpretazione adeguata né negli interrogatori né nella fase processuale, pur avendone pieno diritto.
Le udienze preliminari raggiungono una fase cruciale lo scorso febbraio, quando l’enorme costruzione probatoria della procura viene smontata pezzo per pezzo. Le intercettazioni si rivelano inconsistenti, i testimoni inaffidabili, e persino con il governo Meloni il flusso di migrazioni nel Mediterraneo aumenta, smentendo una volta per tutte la teoria secondo cui le Ong sarebbero il fattore di attrazione delle migrazioni verso le coste europee. É la stessa procura a chiedere lo scorso 27 febbraio il non luogo a procedere e il 19 aprile il gup di Trapani mette la parola fine al processo perché “il fatto non sussiste”.
Quasi dieci anni di calunnie e teorie cospirative alimentate da politici, giornalisti e opinionisti sui media tradizionali e sui social hanno profondamente influenzato la percezione di molti cittadini europei, soprattutto italiani, riguardo alle migrazioni forzate e alla solidarietà in mare. Anche se questo processo potrebbe dimostrare, una volta per tutte, che si tratta solo di calunnie, non basterà per cambiare questa percezione radicata da anni di bombardamento mediatico.
L’esito del processo si erge tra le macerie di un paese dilaniato da anni di campagne razziste e non riporterà in vita le persone che hanno perso la vita in mare, quasi 10 mila dall’inizio del fermo a oggi. Non torneranno in vita nemmeno le persone che sono annegate quando, in uno degli episodi più oscuri della fase investigativa, le autorità italiane impedirono alla Iuventa di soccorrere circa un centinaio di persone, ordinando invece il ritorno a Lampedusa per installare delle microspie a bordo. Quelle persone ora giacciono in fondo al mare insieme a tante altre, ma per loro nessun tribunale chiederà giustizia. (nicoletta alessio / davide salvadori)


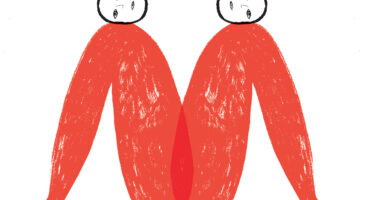


Leave a Reply