
Il 22 marzo 2023 circa quaranta persone di origine straniera vengono sgomberate senza preavviso dall’occupazione abitativa dell’ex stabilimento delle patatine San Carlo di via Siusi a Milano nel quale vivevano dall’ottobre 2020. Tra queste persone ci sono tre famiglie che lì avevano trovato ospitalità e un luogo dove crescere i figli, inserendosi, anche con il supporto della rete solidale Ci Siamo, nel sistema dei servizi educativi e sanitari del territorio.
In seguito allo sgombero, solo una delle tre famiglie accetta di trasferirsi in un centro di prima accoglienza, su proposta dell’assistente sociale del nucleo emergenza abitativa del Comune, mentre le altre due rifiutano. A tutte le altre persone – adulti, soli, lavoratori – non viene proposta alcuna soluzione abitativa.
Il nostro racconto si sofferma sulla famiglia che accetta la proposta del Comune perché riteniamo che attraverso la loro storia sia possibile mostrare le modalità ordinarie con le quali le istituzioni affrontano una situazione di emergenza abitativa causata dalla perdita improvvisa della casa (in seguito all’esecuzione di uno sfratto o di uno sgombero) e dove sono presenti soggetti fragili (in questo caso minori). Un ambito di intervento che in questi anni, a causa della persistente crisi abitativa, è stato oggetto di grande attenzione da parte dei comuni tanto da divenire un vero e proprio settore che precede, e in alcuni casi addirittura sostituisce, quello dell’edilizia residenziale pubblica, riscrivendo, in parte, la disciplina che finora ha regolato l’accesso agli alloggi sovvenzionati dello stato. Si tratta di pratiche che, come confermano alcune ricerche, sono comuni a diverse amministrazioni comunali di grandi e piccoli centri e che pur proponendo servizi di welfare abitativo disciplinati a livello regionale, operano secondo protocolli e standard definiti a livello comunale.
UNA FAMIGLIA
La storia di cui vi vogliamo parlare inizia il giorno dello sgombero, quando la famiglia composta da madre, padre e due figlie di dieci e cinque anni, di cui una con disabilità grave, viene trasferita in un centro che le assistenti sociali definiscono di “emergenza per l’emergenza”. Una struttura di primissima accoglienza destinata prevalentemente a persone senza dimora con problematiche sanitarie, dipendenze, fragilità psicologiche e disturbi mentali, nonché a famiglie con minori sfrattate. Alla famiglia viene assegnata una stanza singola all’interno di uno spazio dove ne soggiornano altre con le quali devono condividere il bagno. È assente la cucina perché il pasto viene fornito dal terzo settore a cui è affidata la gestione dello spazio, non è possibile lavare i propri vestiti né avere con sé le proprie cose. L’accesso all’edificio è controllato da un guardiano. La permanenza nella struttura viene stabilita in dieci giorni.
Fin da subito questa soluzione appare inadeguata alle esigenze del nucleo familiare, sia per la tipologia abitativa, sia perché si trova dall’altra parte della città, lontana dalle scuole e dalla rete sociale di riferimento. Alla inadeguatezza dello spazio – di cui il Comune è consapevole ma che sostiene essere l’unica risorsa disponibile alternativa alla strada – si somma il portato di emozioni e sentimenti che investe gli adulti e i bambini per la perdita improvvisa della propria abitazione, dei propri spazi, dei propri giochi, delle proprie routine ma anche dei propri riferimenti nel quartiere.
Fin dal giorno successivo allo sgombero, la famiglia si organizza per assicurare la frequenza scolastica delle bambine. Ora devono affrontare un’ora in più di viaggio all’andata e una al ritorno. Tentano di attivare, nel centro di riabilitazione vicino a dove abitavano prima, la terapia che era stata progettata per la bambina più piccola con disabilità. Trovano un modo per continuare a cucinare il pasto alla bambina che dal giorno dello sgombero non mangia più perché si nutre solo di quello che le prepara la madre. Cercano di trasferire gradualmente i loro beni più preziosi (oggetti, mobili, vestiti, giochi, elettrodomestici) accumulati nel tempo e che sperano un giorno gli possano di nuovo servire. Il papà continua a lavorare, nonostante le richieste per i numerosi colloqui con le assistenti sociali, il tempo in più necessario per portare le bambine a scuola, quello per le terapie, quello per il trasloco. La bambina più piccola, che ha un disturbo grave dello spettro autistico, aumenta lo stato di agitazione (lo certifica in una nota anamnestica la neuropsichiatra infantile che l’ha in cura), la più grande ha episodi di enuresi notturna, la madre viene ricoverata per accertamenti in ospedale per un’intera giornata perché accusa malori fisici dovuti probabilmente alle pressioni psicologiche dei giorni precedenti.
Al disagio legato allo sradicamento si aggiungono le preoccupazioni per il futuro. Le soluzioni alternative al Centro e disponibili nell’immediato sono un ostello per tutto il nucleo e un alloggio in condivisione con altre madri con i minori. Tra le due l’attenzione del Comune si sposta sulla seconda. Si tratta di una struttura appena inaugurata, pensata per rispondere alle numerose domande di emergenza abitativa. È organizzata in alloggi condivisi, dotati di stanze con il bagno privato e la cucina in comune. L’accesso è vietato ai padri e a qualsiasi estraneo, sia di giorno che di notte. Il tempo di permanenza nella struttura è limitato ma la durata non viene definita nei colloqui, lasciando intendere che dipenderà da quando saranno disponibili soluzioni alternative.
La proposta non tiene conto dei bisogni della famiglia che non vuole dividersi e nemmeno dei pareri specialistici che documentano la necessità per le bambine di rimanere con entrambi i genitori. Soluzioni alternative, sostengono le assistenti sociali, potrebbero arrivare solo dalla famiglia, se la stessa le saprà attivare con un loro piccolo contributo: 1.500 euro per nuovo contratto di locazione sul libero mercato o nell’housing sociale. Una cifra modesta se pensiamo agli affitti medi e alle richieste di garanzia e caparra. Sul fronte del Comune, invece, potrebbero rendersi disponibili altre soluzioni di breve-medio termine. Alloggi potenzialmente per tutta la famiglia ma per i quali non vengono condivisi i tempi di accesso (si parla di mesi), le date in cui si riuniscono le commissioni di valutazione delle domande e nemmeno l’informazione sull’effettiva disponibilità.
In questo limbo, dove anche la possibilità di vedersi assegnato un alloggio per tutta la famiglia per un periodo temporaneo appare come un miraggio, si susseguono innumerevoli colloqui e telefonate con le assistenti sociali che esigono da loro disponibilità assoluta e risposte in tempi brevi. In più si palesano in modo velato alcuni rischi. Viene lasciato intendere che prendere tempo per raccogliere elementi e pareri per valutare la sostenibilità della proposta del Comune, o decidere di rifiutarla, potrebbe implicare la perdita di ogni possibilità di essere aiutati a uscire da quella situazione. Oppure che una posizione di chiusura verso proposte che prevedono la divisione della famiglia possa essere letta come un atteggiamento “non collaborante e adattivo”. Un motivo sufficiente per chiedere all’autorità giudiziaria di accertare la presenza di situazioni di pregiudizio e procedere con una sostituzione del nucleo familiare inserendo le minori in comunità residenziali.
A questo punto la famiglia si trova di fronte a un dilemma: accettare di dividersi per un periodo indeterminato oppure rifiutare la proposta chiedendo alle assistenti sociali di rimanere in quella struttura finché non sarà disponibile una soluzione per tutto il nucleo. La famiglia sceglie la seconda strada con il solo obiettivo di difendere il nucleo e di tutelare le bambine, consapevoli che la forza per superare questa situazione è racchiusa nella loro unione. Ha il coraggio di farlo grazie anche alla presenza della rete di solidarietà Ci Siamo che in quei giorni li sostiene e li aiuta a districarsi nella burocrazia, a comprendere la situazione e a mobilitare altri pareri, nonché istituzioni come quella del Centro antidiscriminazione delle persone con disabilità e del Garante per i diritti dei minori che, in quei giorni, si esprimerà, anche pubblicamente, contro la pratica di dividere le famiglie.
In seguito a quella scelta, per qualche settimana, le assistenti sociali rimangono silenti. Nel frattempo la famiglia cerca in tutti i modi, senza successo, una soluzione in autonomia. Poi arriva una nuova proposta di colloquio per un bilocale a 550 euro al mese (spese incluse) posto in un comune dell’hinterland e gestito da una nota realtà del terzo settore che mette a disposizione anche un educatore di sostegno. La proposta fa sperare, anche se l’alloggio è un piccolo bilocale, ma a conti fatti si rivela insostenibile, le spese inciderebbero per il settanta per cento sul reddito disponibile.
È solo di qualche giorno fa la notizia del trasferimento di tutta la famiglia in un alloggio all’interno di una residenza sociale temporanea gestita da due realtà del terzo settore abitativo. Una struttura convenzionata con il Comune, posta nell’hinterland milanese e nella quale potranno rimanere al massimo per diciotto mesi.
TURN OVER
La storia raccontata riguarda un numero crescente di persone e famiglie sfrattate perché non sono più in grado di pagare il mutuo o l’affitto, o sgomberate dalle occupazioni in cui abitano. Le amministrazioni comunali tendono a classificare queste situazioni come “emergenza abitativa” ma, come suggeriva Antonio Tosi, per la strutturalità sia delle cause che le generano sia delle politiche pubbliche messe in campo per affrontarle, si dovrebbe estendere il concetto a quello di povertà abitativa. Le cause della povertà abitativa riguardano tanto il divario tra l’evoluzione dei redditi, secondo alcune stime in calo, secondo altre in debole incremento, e l’aumento dei prezzi delle abitazioni, quanto, sul lato dell’offerta, la carenza strutturale di abitazioni a basso costo, un sistema di politiche abitative pubbliche debole e un mercato dell’affitto che si è progressivamente contratto orientandosi, soprattutto nei centri più attrattivi, su fasce di popolazione in grado di portare più utili (turisti e studenti).
Di fronte all’impossibilità di trattare queste situazioni attraverso le politiche ordinarie (l’assegnazione di una casa popolare), i servizi sociali, costretti dalla normativa vigente (L.328/2000) a prendere in carico le situazioni con fragilità (minori, adulti o anziani non autosufficienti o con disabilità) e non altre (adulti soli privi di mezzi e risorse), hanno individuato risorse nel settore sociale e in quello rivolto alla grave emarginazione sociale e abitativa. Quest’ultimo, pur occupandosi di problemi legati alla mancanza di casa, è un ambito di intervento contraddistinto dall’utilizzo di misure speciali (generalmente di bassa qualità) concepite al di fuori dal corpus principale delle politiche abitative, che si sono sempre, invece, orientate verso i bisogni dei ceti medi e medio-bassi non risolvendo mai, di fatto, il problema dei più poveri.
I tratti comuni a questi due settori di intervento sono: la responsabilità, che è in capo ai servizi sociali; la tipologia delle soluzioni “quasi-abitative” (non alloggi ma dormitori, stanze, spazi condivisi, alberghi, comunità alloggio, comunità per madri, ecc.); fanno eccezione le esperienze più innovative di housing first, la gestione delle strutture spesso affidata al terzo settore che a volte ne è anche il proprietario e, infine, la presenza di un alto livello di intensità assistenziale. A questi due settori si aggiunge quello della casa, che mette a disposizione alloggi di proprietà pubblica ma gestiti al di fuori della disciplina regionale.
Il modo in cui le istituzioni hanno utilizzato queste risorse sembra avere alcuni obiettivi specifici: aumentare l’offerta da destinare alle situazioni di emergenza e, contemporaneamente, disciplinare l’accesso affinché attraverso una serie di misure si generi in automatico un turn-over di famiglie in grado di “far bastare” le poche soluzioni per tutte le domande in arrivo. Un dispositivo che presuppone che chi accetta di aderire a questo sistema non si ritroverà sulla strada, ma rischierà di trovarsi in una condizione peggiore rispetto a quella dalla quale proviene, e non è detto che uscirà dalla condizione di emergenza. Non dovrà quindi essere messo nelle condizioni di pretendere “agevolazioni, contributi consistenti e/o addirittura l’assegnazione di un alloggio”.
Gli elementi che caratterizzano questo dispositivo sono quelli che emergono dalla storia narrata e che proviamo a riprendere di seguito facendo riferimento al caso di Milano.
Il primo riguarda la temporaneità. Un elemento che non rappresenta in assoluto una menomazione delle risposte ma che, tuttavia, in questo ambito, viene utilizzato con obiettivi e risultati ambigui. Nella storia si apprende che c’è una prima fase dove l’amministrazione, in assenza di una casa, offre una soluzione di primissima accoglienza per un periodo di dieci giorni, alla quale poi sarebbero dovute seguire: una seconda fase all’interno di una nuova struttura (solo per la madre e le minori) per un periodo di massimo diciotto mesi (sono le RST o gli alloggi AUTE), una terza all’interno di un alloggio transitorio (per tutto il nucleo) per un periodo fino a cinque anni (i SAT) e, infine, un’ultima fase con il passaggio verso un alloggio definitivo (nell’edilizia pubblica, nell’housing sociale o nel libero mercato).
Si intravede, all’opera, una filiera di servizi abitativi ma la stessa non è palese e, in quanto tale, non viene presentata alla famiglia nella sua chiara sequenza, come percorso necessario per accedere a un alloggio definitivo per tutti.
L’efficacia delle soluzioni è altresì messa in dubbio da due aspetti. Da una parte, dal rischio concreto che, in assenza di risorse alternative in numero sufficiente e sostenibili per le famiglie, le soluzioni temporanee diventino delle trappole dalle quali diventa difficile uscire. Il passaggio da una fase all’altra, da una struttura all’altra, è incerto, perché legato alla disponibilità di risorse che si renderanno disponibili. Inoltre, la transizione verso il libero mercato, con l’auspicata emancipazione del nucleo dall’aiuto pubblico come obiettivo finale, anche in presenza di un servizio di accompagnamento, non si realizza quasi mai perché si ripresentano le condizioni strutturali che avevano espulso o escluso la famiglia da quel sistema. Dall’altra parte, queste soluzioni comportano un prezzo importante da pagare, di tipo emotivo oltre che materiale, provocato dai continui spostamenti, dall’esperienza dello sradicamento, soprattutto per i bambini e le bambine e le persone molto fragili.
Poiché quindi la temporaneità, per i motivi esposti, rischia di non verificarsi con la sola definizione di un limite temporale di permanenza dentro le strutture, si aggiungono altri escamotage per renderla effettiva.
Il secondo elemento è connesso sia con la bassa qualità delle soluzioni proposte sia con la loro localizzazione nella città. Le strutture di prima accoglienza, almeno nella prima e nella seconda fase, sono in contrasto con gli standard minimi di abitabilità definiti dalla normativa regionale sulla casa, che classifica tali soluzioni come sovraffollate e inidonee alle caratteristiche del nucleo familiare. Non è di per sé un aspetto dequalificante delle proposte, lo è però il messaggio trasmesso: devono essere “scomode”, sia per le condizioni abitative sia per la loro localizzazione ai margini della città o addirittura al di fuori dei suoi confini, e non possedere un valore abitativo, perché la paura delle istituzioni è che vi sia un progressivo adagiarsi delle famiglie, un’inerzia ad attivarsi per trovare una soluzione in autonomia, facendo venire meno quella risorsa per un’altra famiglia bisognosa. Inoltre, non essendo contemplato uno spostamento all’interno di strutture poste in uno stesso quartiere, l’esperienza di sradicamento va a coinvolgere tanto lo spazio domestico quanto l’ambiente circostante. Si perde la casa e, insieme, la possibilità di coltivare e utilizzare il capitale di relazioni, riferimenti, servizi che intorno a essa si erano costruiti. Si perde la possibilità di continuare ad andare nella stessa scuola.
Il terzo elemento riguarda la pratica di dividere la famiglia, di offrire soluzioni solo per la madre e i figli anche in assenza di disfunzioni. Una scelta che non è volta a tutelare o a difendere i minori e la madre ma che è intenzionalmente escogitata per creare qualche ulteriore difficoltà alla famiglia, che si presuppone, si attiverà presto per trovare una soluzione alternativa e in autonomia, lasciando libero quel posto. Una decisione, quella della separazione, che ha delle implicazioni dirette e indirette sulla qualità della vita dei minori e sul loro benessere. Un approccio che non sembra guardare alla famiglia come una risorsa importante, da rafforzare nell’esercizio della genitorialità per uscire positivamente da quella situazione, ma da mettere in crisi e indebolire.
Un quarto elemento, trasversale a tutti gli altri, ha a che fare con un approccio da parte delle istituzioni che ha come effetto di mettere l’interlocutore in una condizione di soggezione e dipendenza, anziché riconoscergli una condizione di oggettiva difficoltà legata alla mancanza di mezzi e risorse. Non è contemplata la possibilità di partecipare alla costruzione di un percorso dove sono chiari diritti e doveri e dove è possibile mettere in gioco le proprie risorse e competenze. Soggezione e dipendenza sono l’esito dei meccanismi già richiamati (sradicamento, incertezza verso il futuro, paura di essere divisi) e di forme più o meno implicite di ricatto operate attraverso alcuni messaggi come: l’ingratitudine verso le soluzioni proposte dalle istituzioni; i giudizi sull’irresponsabilità genitoriale per aver occupato illegalmente; la colpevolizzazione della condizione di povertà e della scelta di venire in un altro paese e pretendere dei diritti. Un approccio che produce appunto sottomissione e condiscendenza nei confronti delle istituzioni o, al contrario, alimenta la voglia di uscire da quella particolare relazione. La presa in carico, dunque, implica una limitazione delle libertà, chiede di de-responsabilizzarsi a favore di un’adesione totale a un ipotetico protocollo (dove non sono chiari diritti e doveri) pensato dalle istituzioni per le persone secondo un approccio amministrativo e standardizzante.
Infine, un ultimo elemento caratteristico è legato ai soggetti esterni che il Comune coinvolge nella gestione di questo servizio. In questi anni le amministrazioni hanno fatto sempre più ricorso al terzo settore, affidando a queste realtà la gestione di strutture comunali, accreditando alloggi o posti letto di loro proprietà e attivando, insieme all’assegnazione di un posto letto a famiglie in emergenza, servizi di accompagnamento volti ad aiutare le famiglie a uscire da quella condizione. Nella maggior parte dei casi, i protocolli di accesso a queste risorse sono stati definiti attraverso regolamenti comunali. Il risultato di queste operazioni appare di scarso successo. Al terzo settore è assegnata la responsabilità di far funzionare il dispositivo (la temporaneità, il turn-over, la gestione di nuclei divisi), garantendo al Comune (e alla famiglia), attraverso il proprio servizio di accompagnamento, l’uscita da una condizione di emergenza abitativa. La possibilità però di attivare un reddito che consenta di sostenere un affitto di mercato, dipende da fattori strutturali del mercato e delle politiche e non solo dalla volontà o capacità del terzo settore e delle famiglie, che operano tra l’altro con poche risorse a disposizione. Si intravede quindi il rischio che attraverso questa scelta il Comune scarichi sul terzo settore il successo del servizio senza intervenire sulle reali cause dell’esclusione dei nuclei familiari da un’abitazione di mercato. In questo modo il terzo settore perde la sua terzietà, diventando strumento dell’amministrazione e della sua politica e rinunciando a promuovere, com’è nella sua natura, servizi fondati su una lettura dal basso dei bisogni in grado di sensibilizzare le istituzioni e di portare innovazione nel servizio pubblico.
LE POLITICHE
Finora abbiamo mostrato le modalità con le quali le istituzioni locali intervengono per rispondere alle sempre più numerose situazioni di famiglie che si trovano in condizione di povertà abitativa. Alla base di queste modalità di operare, si rileva la volontà di arginare una domanda definita emergenziale, contenendo il più possibile la spesa pubblica e basandosi sulle “risorse disponibili”, cui sono subordinate l’efficacia e l’appropriatezza delle risposte. Ma queste ”risorse” sono effettivamente in grado di tutelare il benessere dei soggetti fragili verso cui sono indirizzate? Dal nostro osservatorio, la questione porta con sé numerose criticità. Innanzitutto, le risorse sono rivolte quasi esclusivamente a soggetti “per i quali l’obbligo di intervento, sussistendo le condizioni di minore età ovvero di non autosufficienza, è immanente alla stessa esistenza del servizio sociale”. Agli adulti soli, privi di mezzi per accedere in autonomia a una abitazione, non vengono quasi mai offerte soluzioni abitative.
In secondo luogo, nonostante venga operato un restringimento della platea dei destinatari, le risorse risultano comunque insufficienti a coprire tutte le domande. Come confermano i fatti di cronaca di questi giorni, non è escluso che anche le famiglie con soggetti fragili si trovino sulla strada.
In terzo luogo, sono risorse spese per soluzioni che contengono numerose criticità legate al loro funzionamento e che abbiamo esposto nei paragrafi precedenti.
Nonostante l’esistenza di gravi situazioni di disagio abitativo e di difficoltà di risposta da parte degli enti pubblici, se si guarda alle politiche per la casa proposte o attuate negli ultimi due decenni, permane di una sorta di reticenza, forse data dalle difficoltà di consenso politico, nel definire la questione della casa dei poveri come un problema da porre all’attenzione di specifiche politiche pubbliche.
Uno stato di cose che non sembra modificarsi se si rivolge l’attenzione al periodo più recente, alle iniziative sorte intorno al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), al Piano casa della regione Lombardia o, infine, all’ampio dibattito che si è creato, proprio nei giorni dello sgombero, sulle politiche pubbliche per la casa del comune di Milano, tutte orientate sulla questione dell’accesso alla casa dei lavoratori e dei ceti medi.
Non si rileva purtroppo neppure un’azione istituzionale e sociale attenta ai bisogni di chi, come i bambini e le persone con disabilità, vive in condizioni di estrema fragilità. La retorica delle risorse soppianta qualsiasi principio fondamentale di tutela del diritto di queste persone a una vita normale e a una loro protezione. È un sistema inattaccabile, perché opera secondo la legge, secondo i protocolli, e che non si sente in alcun modo sollecitato a interrogarsi sulle proprie responsabilità. Ma a essere in gioco non è solo il diritto a un abitare dignitoso bensì, in senso lato, le possibilità di sviluppo dell’intera società nelle sue varie espressioni. (alice boni / salvatore porcaro)


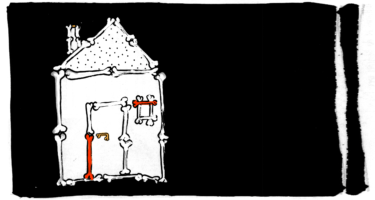
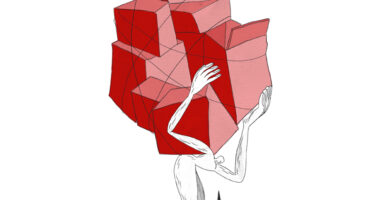

Leave a Reply