
L’Organizzazione mondiale della sanità ha nuovamente lanciato un “allarme salute mentale”: la pandemia sta già determinando e accrescerà sempre più ansia, depressione, abuso di sostanze, dipendenze, esposizione alla violenza, separazioni affettive e lutti, rischio suicidi. Non è il primo richiamo dell’Oms né l’unico sul tema, si stanno succedendo infatti studi, ricerche, comunicazioni sulle conseguenze psichiche della quarantena. Mario Maj, direttore del dipartimento di psichiatria dell’università della Campania “Luigi Vanvitelli”, ha dichiarato all’Ansa: «Le autorità devono essere consapevoli di questa nuova emergenza che si sta profilando, e considerarla nei programmi per affrontare la fase 2 della pandemia. Da segnalare sono i quadri gravi di depressione, con vissuto di insopportabile preoccupazione per il futuro […]. Ascoltare queste persone non è sufficiente, bisogna intervenire con gli strumenti propri delle professioni della salute mentale per ridurre il disagio ma anche promuovere la resilienza».
Potrebbero sembrare dichiarazioni di buon senso, tra l’altro ampiamente condivise da tanti. Eppure, pare necessario porre delle questioni. Non tanto perché Maj è stato tra i maggiori propugnatori di un paradigma biologistico della psichiatria, e artefice, con tanti altri, dell’espulsione dal sistema di formazione universitario delle questioni poste dal movimento basagliano e dal processo di deistituzionalizzazione realizzato in Italia. Ci chiediamo, soprattutto, se non esista, in questo quadro, il rischio di quelli che, con Illich, abbiamo imparato a definire processi di medicalizzazione iatrogena di “una società morbosa nella quale il controllo sociale della popolazione da parte del sistema medico diventa un’attività economica fondamentale”.
Se è certamente reale la sofferenza psichica determinata da questa pandemia, tuttavia, il rischio concreto è quello di psichiatrizzarne tanto le conseguenze quanto le risposte messe in campo. La sofferenza psichica si determina, innanzitutto, come riflesso delle condizioni di vita della persona, ancor di più in questo periodo a fronte di deprivazioni, povertà, isolamento. Se quindi è necessario un programma integrato (sociale, economico, sanitario) di interventi a sostegno delle persone, sarebbe invece grave delegare ai “saperi psi” l’individuazione e la denominazione di nuove (ma sempre identiche nella loro definizione organicistica) forme di sofferenza, rischiando ulteriori etichettamenti, da inserire tra i disturbi dei manuali diagnostici e dei prontuari medici da prescrizione. Ancora più grave sarebbe affidare, ancora una volta, alla psichiatria il mandato di una risposta disciplinare volta a sedare i sintomi (farmacologicamente e meccanicamente) e contenere le manifestazioni più eclatanti di sofferenza. È questo il ruolo che storicamente ha svolto la medicina mentale asilare, ruolo che è stato messo in discussione dal movimento basagliano e dal processo di superamento dei manicomi, ma che ancora torna a ripresentarsi attraverso il “il fascino indiscreto dell’internamento”, nonché in molte prassi e logiche adottate nei servizi territoriali. Come troppo spesso accadeva già prima del Covid, anche nel corso di questa pandemia sono stati denunciati casi di trattamenti sanitari obbligatori (Tso) utilizzati fuori dal perimetro normativo, quindi commettendo abusi, con i servizi ospedalieri psichiatrici ridotti a contenitori di devianza in cui le persone vengono sedate e legate.
In Sicilia, a Ravanusa, un ragazzo è stato sottoposto a un Tso su cui è intervenuto anche il Garante nazionale per i diritti delle persone detenute, definendolo «quantomeno irrituale» e chiedendo informazioni sia sulle modalità d’attuazione, sia sul successivo ricovero ospedaliero. Se sull’esecuzione del Tso, anche a seguito della pubblicazione di alcuni video, molto si è scritto e si dovrà attendere l’esito di tutti i riscontri in corso, ci pare importante soffermarci su quanto accaduto nel reparto di psichiatria, dove sembra riproporsi una triste routine di questi luoghi. Dopo cinque giorni dal ricovero, raggiunto telefonicamente, il ragazzo, con la bocca impastata dai farmaci, è riuscito a dire: «Sono chiuso nelle mani e nelle braccia e non mi posso muovere». Perché in quel Sevizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc) l’avevano contenuto, fisicamente e farmacologicamente, come affermato, il giorno precedente, dallo stesso responsabile del reparto, interpellato telefonicamente dal fratello/avvocato del ragazzo (la registrazione è stata diffusa dallo stesso legale): «Con suo fratello per ora non può parlarci perché dorme. Ci parlavo io una mezz’oretta fa e già andiamo meglio, siamo rimasti che se lui oggi è collaborante, tranquillo, da domani già rimuoviamo la contenzione». Quindi il fratello chiede: «La contenzione vuol dire che è legato?». Lo psichiatra risponde: «Si, perché si strappava il catetere, si strappava la flebo, praticamente si faceva male. Quindi lo stiamo tutelando da sé stesso […], per ora non può parlare con lui perché tanto sta dormendo e non abbiamo un cordless. Però domani già si potrà… Per ora dorme». Allora il fratello insiste: «Ma quindi dorme ventiquattro ore su ventiquattro? Perché anche ieri ho chiamato…». Il medico replica: «No assolutamente, anzi, anzi magari […]. No, in realtà lui dorme poco, cioè, se io, se lei avessimo la terapia che ha lui dormiremmo quarantotto ore di seguito».
Contenzione fisica e farmacologica, porte chiuse, diniego dei diritti della persona sofferente pure sanciti dalla legge, abusi, istituzionalizzazione della sofferenza, interventi volti esclusivamente a silenziare i sintomi, sono purtroppo routine di tanti servizi che ripropongono prassi e logiche “asilari”. Pure a fronte di queste realtà, allora, anche la richiesta pressante di finanziamenti da destinare a una salute mentale messa in ginocchio dai tagli di questi anni, non può essere accolta a prescindere dagli obiettivi, dagli strumenti, dalle scelte teoriche e operazionali che si intendono mettere in campo. Un richiamo importante, in questo senso, viene dalla Conferenza nazionale salute mentale che, il 30 maggio, terrà un’assemblea pubblica telematica per discutere delle “condizionalità” per l’erogazione dei fondi. Tra queste: costruire una salute mentale di comunità impegnando i servizi in un sistema di rete territoriale, lavorare alla deistituzionalizzazione, intesa come superamento della residenzialità e promozione dell’autonomia, riconoscere e promuovere i diritti all’abitare, al lavoro, alla socialità, contrastare le forme di nuova segregazione e violenza istituzionale.
Celebrare la legge 180, promulgata il 13 maggio 1978, la grande riforma che ha chiuso i manicomi, ancora di più in questo momento, significa demolire sepolcri imbiancati e false retoriche, restituire centralità politica alla salute mentale e superare lo specialismo psichiatrico in cui hanno costretto questi temi. Soprattutto, questo anniversario richiama la necessità della lotta, della partecipazione, dell’impegno per la salute, per i diritti, per la libertà. La 180, ce lo ricorda Basaglia, è nata così. «Questa Legge, questa nuova situazione, viene da una volontà di base […], la riforma sanitaria in Italia non è venuta perché i medici hanno voluto fare la riforma sanitaria, ma perché c’è una spinta di base che ha [agito sugli] organi politici». Domanda: «Perché i medici non l’avrebbero mai fatta?», Basaglia: «Ne dubito». (antonio esposito)

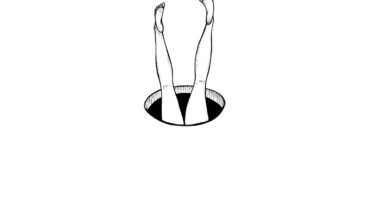



1 Comment