
Tra le pieghe di questo “tempo infetto”, a essere sospesa non è solo la dimensione relazionale che, grazie alle nuove tecnologie, seppure menomata della corporeità, si riesce ancora a sostenere (benché non per tutti), ma soprattutto quella sociale, scarnificata e sospesa in nome delle ragioni sanitarie.
Eppure, sforzandoci di immaginare il momento successivo al grande isolamento, è forse proprio dalla dimensione sociale, dal suo significato e valore, che dovremo ripartire. Dovremo farlo anche e soprattutto in campo medico, e se non saremo così miopi da ricominciare tutto come se nulla fosse accaduto, il portato “sociale” della legge 180 potrebbe rappresentare un importante strumento di rivalutazione e trasformazione dell’impianto del sistema sanitario e, più complessivamente, delle politiche e delle prassi di cura.
L’azione di deistituzionalizzazione realizzata con la chiusura dei manicomi parte proprio dalla capacità di recuperare “il sociale” all’interno dell’intervento medico. Basaglia, durante l’incontro del 21 novembre 1979 a Belo Horizonte, nel corso delle Conferenze brasiliane, lo esprime con chiarezza: «Prevenire la malattia vuol dire operare per mantenere la salute. Ma noi medici, che siamo istruiti nelle università per curare le malattie, non sappiamo cos’è la salute, sappiamo solo cos’è la malattia. Se vogliamo cambiare veramente le cose dobbiamo incominciare a imparare all’università cosa vuol dire il sociale nella medicina, perché l’uomo non è fatto di corpo – è fatto anche di corpo – ma è fatto di sociale, e nel momento in cui il sociale entra nella medicina il medico non capisce più niente, perché è abituato a pensare che il suo malato sia un corpo malato, un tumore, un fegato malato, una testa malata. Non gli viene mai in mente che questa persona, che questa malattia, che questa situazione possano essere conseguenza della vita. Allora, evidentemente, prevenzione della malattia o mantenimento della salute non vuol dire fare diagnosi precoci ma vedere nei posti di lavoro, nei luoghi della vita, quali sono le situazioni che determinano la malattia».
Se, nell’ambito prettamente psichiatrico, questa dimensione sociale diventa una lotta alle condizioni che generano la sofferenza psichica (ancora nel corso delle Conferenze brasiliane lo psichiatra veneziano dirà: «Credo che una delle principali prevenzioni della follia e della malattia mentale sia la lotta contro la miseria»), è al più complessivo sistema sanitario che pensa Basaglia, riflettendo sul portato che avrebbe potuto assumere non solo la legge 180 ma anche la 194.
Durante la trasmissione Acquario di Maurizio Costanzo, il 15 gennaio 1979, confrontandosi con Bruno Orsini, il padre della 180 afferma: «Nella medicina, oggi, c’è il sociale per due leggi: per l’aborto e per la legge sulla psichiatria. Queste due leggi sono i momenti trainanti della riforma sanitaria. […] Questa è la cosa importante: storificare il malato, e un malato otorinolaringoiatra o un malato mentale deve essere un malato che ha una storia, non un malato con una storia clinica, ma una storia di vita propria. […] Devo prendere la persona per quello che è, cioè una persona che soffre, che vive con la sua storia. […] Non dico che la legge sulla psichiatria modifica la medicina, dico che la legge sulla psichiatria porta nella medicina un fatto estremamente importante, che è il fatto sociale, il fatto storico dell’uomo».
In quegli stessi anni, in Italia, si sono sviluppate significative realtà di medicina sociale, capaci anche di superare il gap esistente tra il nord e il sud del paese. Non a caso, per esempio, tra le più importanti vi è quella che si è realizzata a Giugliano di Napoli. Con alcuni psichiatri “triestini” (a partire da Luciano Carrino) e soprattutto grazie all’opera di medici come Pietro Cerato e Teresa Pini, e la collaborazione di attivisti, forze politiche e sociali (dagli operatori della Mensa proletaria al circolo territoriale di Lotta Continua, insieme a sindacalisti, operai, studenti), si diede vita al Centro di medicina sociale che ha rappresentato, in settori come la psichiatria, la medicina sul lavoro, la materno-infantile, la salute della donna, un’esperienza straordinaria, soprattutto dal punto di vista della prevenzione, a cui, purtroppo, non si è voluto e saputo dare continuità.
Smantellare secondo logiche economicistiche il sistema sanitario nazionale, come definito dalla legge 833/1978, è stato un “crimine di pace”, e ne stiamo pagando oggi le conseguenze. In questi anni, anche attraverso l’impoverimento della medicina territoriale, si è realizzata una desertificazione dell’elemento sociale dalla sanità, perseguendo un paradigma di clinicizzazione dell’intervento medico, diventato, in realtà come quella lombarda, con il concorso (e l’enorme profitto) di grandi operatori privati, sempre più asettico, spersonalizzato e ospedalizzato/istituzionalizzato. Ci chiediamo, allora, se, quando il periodo emergenziale allenterà la sua morsa, perché non si ripresenti ancora con la stessa violenza, oltre che attrezzare centinaia di nuove rianimazioni, non sarà necessario rovesciare questo paradigma sanitario, tornare alla dimensione sociale della medicina, investire con forza sui medici di base, sulla medicina del lavoro e su quella ambientale, su una nuova dimensione territoriale della sanità, capace di superare le forme più retrive di internamento/ricovero residenziale, ma anche di ripensare l’ospedale come una parte, certamente importante, ma non più totemica, delle politiche e degli investimenti sanitari.
Il 26 giugno 1977, sulle colonne de l’Unità, commentando il film Matti da slegare di Bellocchio e Agosti, Basaglia scrive: “La malattia si costituisce nel sociale come processi di sanzioni, di restrizioni, di scambi, di resistenze accumulate – che rafforzano il ‘germe’”. Averlo presente, forse, ci avrebbe aiutato anche ad affrontare meglio questa crisi. Oggi, però, avvertiamo soprattutto la necessità, ancora con Basaglia, di opporre al pessimismo della ragione l’ottimismo della prassi: “Per quanti sono costretti, dalla pratica del lavoro quotidiano, a un impegno attento a cogliere le domande, i bisogni, le contraddizioni che emergono, il ‘pessimismo della ragione’ non si traduce in ‘pessimismo della pratica’. È, al contrario, stimolo a una rifondazione costante del proprio ambito e del proprio ruolo per riconoscere, nella concretezza del presente, il nuovo livello di contraddizione, lo spazio per una critica pratica, per la distruzione, ancora, dell’ideologia nella lotta”. Ecco, forse è proprio questa una delle sfide più grandi che ci attende. (antonio esposito)

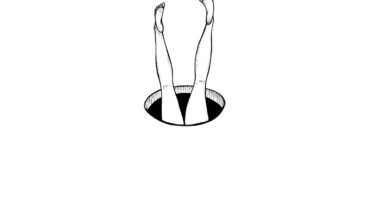



Leave a Reply