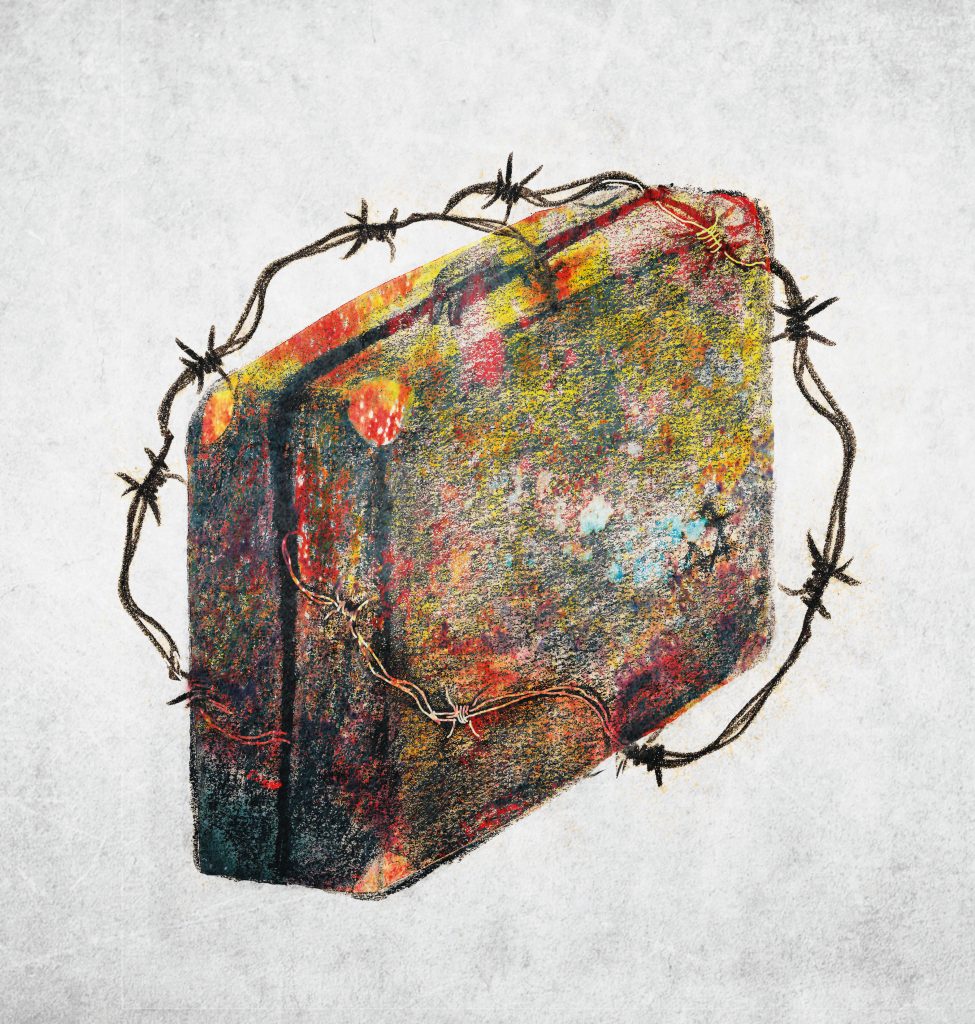
Esce in questi giorni l’edizione 2016 del Rapporto sulle migrazioni interne in Italia. Si intitola Fare spazio ed è un volume edito da Donzelli, a cura di Michele Colucci e Stefano Gallo. Il volume verrà presentato a Napoli martedì 13 dicembre alle 16,30 al Cnr, via G. Sanfelice, 8.
Di seguito proponiamo un estratto da Tempo di cambiare. Rapporto 2015 sulle migrazioni interne in Italia (Donzelli 2015). Si tratta di una lunga intervista che lo scrittore Marco Balzano ha rilasciato ai curatori del progetto. Balzano è autore del romanzo L’ultimo arrivato (Sellerio 2014, Premio Campiello)
* * *
Marco Balzano, insegnante di liceo, è uno scrittore giunto al suo terzo romanzo. Con L’ultimo arrivato ha raccontato la vita di un bambino, Ninetto Giacalone, che nel 1959 parte da solo a nove anni da un paese siciliano alla volta di Milano. La biografia di Ninetto, il suo rapporto con la città di Milano e le sue trasformazioni, l’esperienza della migrazione sono raccontate da Balzano in una lunga dimensione temporale, che lo porta fino ai giorni nostri. Abbiamo incontrato Marzo Balzano a Milano il 14 marzo 2015 e abbiamo registrato questa intervista.
Il tuo libro ci è sembrato una bella anomalia rispetto a molta produzione narrativa sulle migrazioni. Come ti è venuto in mente di scriverlo e quale metodo hai usato per prepararlo?
L’emigrazione era una tematica centrale anche nei miei due precedenti romanzi e quindi si è creata una sostanziale familiarità con l’argomento. Io stesso provengo da una famiglia che emigrò dalla Puglia per trasferirsi a Milano e mio nonno da contadino la seguì, così da poter aiutare i figli a cercare lavoro. Loro sono stati in molti dei luoghi di arrivo descritti nel romanzo, che rappresentano comunque un percorso abbastanza tipico.
Nel primo romanzo, Il figlio del figlio (Avagliano, 2010), infatti, racconto di un nonno, un padre e un figlio che tornano in Puglia per vendere la vecchia casa di famiglia, abbandonata dopo il trasferimento a Milano negli anni del «boom» economico. C’erano quindi tre memorie che si raffrontavano su quella casa, che assumeva per tutti i protagonisti un ruolo fortemente simbolico. Per il nonno era memoria di una comunità contadina, forte e legata all’identificazione politica nelle sezioni di partito, per il padre il ricordo dell’adolescenza, con il conseguente dolore per lo sradicamento in anni cruciali, e per me più semplicemente quello delle estati al mare coi nonni, i cugini, gli amici, i primi amori… Quindi un po’ questa storia ce l’ho dentro. Anche nel secondo libro (Pronti a tutte le partenze, Sellerio 2013) parlo di emigrazione: quella dei precari di oggi. Un’emigrazione più intellettuale, lo sradicamento di una generazione che non riesce a trasformare in moneta spendibile titoli e studi, che non riesce a utilizzare il proprio sapere per costruirsi una vita.
Ne L’ultimo arrivato, invece, l’idea era quella di raccontare un tema in cui mi sono imbattuto quasi per caso: l’emigrazione infantile. Il primo libro sull’argomento che mi è capitato tra le mani è stato quello di Goffredo Fofi sull’emigrazione meridionale a Torino: un vecchio saggio del 1964 piuttosto tecnico che però, insieme a un’illustrazione di dati, propone interviste a operai che lavoravano nelle aziende. Al tema dell’emigrazione dei bambini, in verità, il saggio dedica poche righe, ma sono bastate per far scattare un interesse. Ho cercato poi di recuperare la letteratura scientifica sull’argomento e la questione che è emersa sempre di più è che tra il 1959 e il 1962 vi è stata un’ultima, forte, ondata migratoria di bambini di età compresa tra i nove e i tredici anni.
Che tipo di composizione aveva questa emigrazione?
I più fortunati erano quelli che partivano con le famiglie, ma soprattutto in Calabria e nella Sicilia dell’entroterra si trattava di persone che non potevano permettersi di emigrare all’unisono; nei casi mediamente fortunati i bambini venivano lasciati a un familiare, mentre in quelli più sfortunati partivano con un compaesano o un conoscente. Volendo nel libro si potevano calcare i toni ma ho scelto una storia tutto sommato mediana perché tante volte la realtà è superiore alla fantasia. Si parla anche di piccole bande di bambini che partivano senza biglietto, di gente che scappava proprio dalla fame, in Calabria e in Basilicata particolarmente, ma anche in zone come Enna, il catanese e nella parte più vulcanica, diciamo.
Nonostante mi fossi documentato ancora non avevo la certezza di poter scrivere questa storia. L’ho avuta solo quando ho compreso che queste persone oggi hanno circa settanta anni e quindi sono andato a intervistarli. Ne conoscevo uno, il padre di un amico, emigrato a nove anni proprio qui a Milano, dalla Calabria, che poi è il luogo da cui proviene la moglie del protagonista (Spezzano della Sila). Dopo averlo intervistato mi ha facilmente rimandato a suoi ex compagni di fabbrica, pure loro emigrati durante l’infanzia o l’adolescenza: ne ho intervistati una quindicina, dieci a Milano, tre a Torino e due a Genova, a cui sono arrivato per continui rimandi uno all’altro.
Ho iniziato a buttare giù i primi abbozzi quando ho riscontrato dei fortissimi punti in comune tra tutte queste vite: la partenza più o meno forzata e il taglio netto col luogo natio, dovuto alla fame, alla mancanza di sussistenza oppure al fatto di dover sostenere un lavoro troppo duro rispetto all’incognita di emigrare. Al posto che zappare dieci ore al giorno, ma anche di più, si preferiva partire. Una volta arrivati, iniziava una vita di espedienti in città o nelle cinture periferiche, in zone che oggi sono interessanti da studiare: a Torino, per esempio, il fulcro degli immigrati si stanziava a Porta Palazzo, che oggi è una zona quasi modaiola, fresca, giovane. Qui a Milano erano i Navigli, Cernusco e comuni come Baranzate che è diventato il terzo in tutta Europa per immigrazione: oggi in alcuni punti si registra quasi l’80 % di immigrati. Tutti palazzoni che sono fioriti nel mentre stesso che fiorivano le industrie.
Questi bambini arrivano poi a compiere quindici anni, anno in cui c’è la svolta della vita, perché hanno raggiunto l’età per entrare in fabbrica. Appena possibile, appena la legge lo consentiva, visto che problemi di assunzione non ce n’erano, venivano assunti con contratti a tempo indeterminato. A quel punto restava da compensare l’unico elemento ancora fratturato, quello affettivo: quindi si sposavano, a sedici anni circa. Spesso alla mia età, a trentasei anni, diventavano nonni. Alcuni ti raccontano dei loro nipoti più grandi di me. (michele colucci e stefano gallo / continua a leggere…)




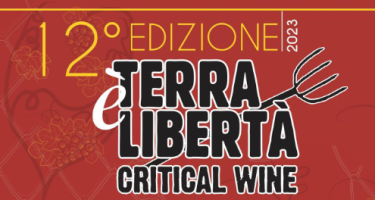
Leave a Reply