Quest’estate nei terreni inariditi dalla calura giacciono ortaggi e frutta non raccolti, marciscono assumendo forme contorte, annerendosi tra sterpi e insetti. Le grandi estensioni di terra coltivata in Campania, alle periferie dei comuni, nelle pianure che costeggiano i fiumi maggiori e sui declivi del Vesuvio, sono quasi prive di presenza umana, nonostante agosto sia il mese più laborioso. Come se ci fosse stata un moria di contadini o una fuga di lavoranti, e i pochi anziani sui trattori intenti a innaffiare il tabacco, insieme ai gruppetti di immigrati che raccolgono stancamente pomodori, non riescono a soffocare il senso di abbandono in cui versa la campagna.
Il settore è in crisi, ma questa volta le bolle finanziarie non c’entrano. Sono ormai diversi anni che lo stato comatoso dell’agricoltura italiana, e meridionale in particolare, passa inosservato. Le associazioni di categoria e i sindacati di agricoltori e allevatori continuano a denunciare il depauperamento del loro lavoro, inascoltati. Il crollo progressivo dei prezzi pagati ai produttori viene fatto risalire, dai diretti interessati, al regime di quasi monopolio dei gruppi della grande distribuzione. Quelli che acquistano, smistano e fanno arrivare la merce agli impianti di trasformazione e nei reparti “carni e verdure” degli ipermercati. Il commercio all’ingrosso e al dettaglio è ormai nelle mani di sette gruppi della grande distribuzione che si spartiscono il novantotto per cento del mercato italiano. Con il loro peso economico controllano la leva dei prezzi e decidono le condizioni a cui gli agricoltori devono sottostare. Mentre i costi di produzione aumentano, questo oligopolio si interpone tra l’azienda agricola e il consumatore, facendo lievitare a oltre un euro i prodotti acquistati dai contadini per una manciata di centesimi.
Nelle campagne lo sanno tutti, coltivare non conviene più. Manco a dirlo, in Campania si registrano le criticità maggiori. Diversi fattori, tra cui la concorrenza dei prodotti importati e la tendenza verso la centralizzazione, cozzano con la realtà altamente frammentata dell’agricoltura campana, fatta di piccole aziende spesso a conduzione familiare. Secondo i dati Istat nel corso degli anni la SAU in Campania (la superficie agricola utilizzata) non ha fatto che diminuire: dai cinquantaquattromila ettari del 1982 siamo arrivati agli odierni trentacinquemila. Molti piccoli produttori sono falliti e le terre che non sono state accorpate ad altre aziende più grandi o non sono diventate terreno edificabile, sono finite semplicemente abbandonate. Il numero degli occupati in agricoltura e allevamento nella nostra regione è ormai ridotto al sei per cento del totale, un trend discendente intensificatosi negli ultimi anni, e i proprietari rimasti sono in massima parte oltre i sessant’anni di età. Se attraverso la vendita non si coprono i costi di produzione, coltivare diventa quasi un gesto romantico, e talvolta si è costretti a non raccogliere i prodotti maturi. A guadagnare sul lavoro della terra sono rimasti gli intermediari, gli stakeholder che fanno viaggiare le merci dai poli agricoli intensivi, perlopiù fuori regione, ai centri di trasferimento, con rincari ad ogni passaggio. Dai tempi d’oro dell’agricoltura in Campania, negli anni Settanta e Ottanta, quando era la prima regione italiana esportatrice in Europa di pomodoro da industria, patate, tabacco e prodotti ortofrutticoli pregiati, siamo piombati nella lotta per la sopravvivenza del settore. Resistono punte di eccellenza nell’area beneventana, in Irpinia e negli allevamenti di bufale sul litorale domitio, orientate sul prodotto di qualità (DOC e IGP), ma essendo inserite in un contesto di abbandono e scarsità di risorse rischiano di condividere presto il destino di un’agricoltura sempre più abbandonata a sé stessa.
È arduo raccapezzarsi tra le problematiche vecchie e nuove della produzione e del commercio agricolo in Campania. Anche fuori dalle grandi città, nei paesi che storicamente hanno dipeso dal lavoro nei campi per la loro sopravvivenza, paesi in cui fino agli anni Cinquanta la quasi totalità della popolazione era impegnata in agricoltura, l’indifferenza per le campagne è pressoché unanime. Ed è effettivamente nel silenzio e nel disinteresse generale che molti contadini mollano, finendo a vendere i terreni al miglior offerente, convertendosi anche loro allo stile di consumo “maggioritario” dei figli e dei nipoti. Si va così perdendo un patrimonio culturale e ambientale di cui ci portiamo ancora i segni addosso, proprio quando, ironicamente, i programmi di sviluppo rurale dell’Unione Europea spingono e finanziano la produzione agricola a evoluzione lenta e a consumo locale, per la preservazione del paesaggio e delle tecniche di coltivazione tradizionali. Delle cause del tracollo regionale, dal punto di vista della competitività economica in agricoltura, ne ho parlato con un agronomo di mezza età nato e cresciuto in provincia di Napoli, A. S., da venticinque anni coinvolto in questo settore in Campania e nel Meridione, prima in una cooperativa agricola e poi come agente di varie aziende sementiere.
«I problemi strutturali nascono dal tipo di sistema della proprietà fondiaria. Ovvero la proprietà fondiaria in Italia si è andata polverizzando nel corso dell’ultimo secolo. Un’azienda agricola per poter essere economicamente valida deve avere una certa superficie, per avere un’autorizzazione aziendale, per poter stare sul mercato, quindi al di sotto di certe superfici diventa difficile avere un’azienda che sia efficiente. Se parliamo di orticoltura e frutticoltura, che rappresentano le fonti più importanti di reddito da agricoltura in Italia, le superfici devono avere una minima consistenza. Nel Sud, Campania, Calabria e in parte Puglia e Sicilia, la polverizzazione aziendale è dovuta al sistema di asse ereditario. Mentre in altre nazioni si è cercato di fare in maniera tale che nel trasferimento agli eredi delle aziende agricole non si scendesse al di sotto di certe superfici, per salvaguardare l’efficienza agricola ed economica, nel Sud questo non accade, per cui le aziende di generazione in generazione sono andate sempre più frazionandosi. Abbiamo poi esempi qui in Campania di aziende che, anche se hanno superfici complessivamente adeguate, sono poi dopo dal punto di vista dell’efficienza messe male perché queste superfici sono suddivise in più appezzamenti distribuiti sul territorio, e quindi diventa complicato fare investimenti, meccanizzare in maniera opportuna, perché se vai a meccanizzare c’è bisogno di aziende con una certa estensione. L’altra problematica è che a differenza degli altri paesi europei dove gli agricoltori sono associati a livello politico in una, massimo due organizzazioni sindacali, in Italia invece, sempre rispecchiando la partitocrazia, abbiamo una moltitudine di organizzazioni sindacali che rappresentano gli agricoltori, e questo impedisce di avere un mondo agricolo unito che si interroga insieme e che insieme va a fare domande al mondo politico, esponendo le proprie esigenze e facendo proposte per sviluppare l’agricoltura. Anche a livello politico sindacale il problema è la divisione».
«Prima dell’avvento della grande distribuzione il mercato era fatto con tantissimi acquirenti e tantissimi venditori, per cui la nostra agricoltura riusciva a sopravvivere per il fatto che essendoci molti acquirenti si aveva la possibilità di offrire la merce a tanti, quindi il prezzo riusciva ad essere remunerativo per l’agricoltore. Il prezzo nasce sempre dalla domanda e dall’offerta, domanda frazionata offerta frazionata, il prezzo era sufficientemente equo. Negli ultimi vent’anni invece, con l’avvento della grande distribuzione è cambiato tutto. La grande distribuzione è fatta da tre, quattro marchi in particolare, che dal punto di vista legale dovrebbero farsi concorrenza, in realtà – si dice ma nessuno è mai riuscito e determinarlo – fanno cartello, cioè si mettono d’accordo per determinare il prezzo di acquisto, che è vietato dalla legge, e questo ha mandato in grande crisi la nostra agricoltura, specialmente l’orticoltura del Sud. Il problema oggi è che non c’è prodotto agricolo che non venga prodotto in quantità di molto superiori a quello che è la reale domanda, allora la grande distribuzione va a comprare dove più gli conviene, per cui oggi i pomodori li compra in Sicilia, domani li compra in Spagna, oppure se li fa venire dal Marocco. Fino a sette anni fa noi come italiani avevamo il mercato europeo delle mele in mano, eravamo i più forti produttori ed esportatori di mele, perché l’Italia per come è fatta, per le condizione meteo climatiche è il meglio per la quantità e per la qualità delle produzione. Ebbene, oggi i migliori affari per quanto riguarda le mele li fanno i cinesi, perché essendo le mele un prodotto a lunga conservazione possono essere tranquillamente prodotte in Cina, messe in container e mandate in Europa. Prodotti di pregio come gli asparagi, che vengono pagati molto bene, basta farli produrre in Costarica e con l’aereo mandarle qua. I meloni la stessa cosa, eravamo tra i primi produttori in Europa, ma ora li fanno produrre in Egitto, in Sudamerica e poi li fai arrivare qua. E anche gli imprenditori italiani a un certo punto per battere la concorrenza sono andati a produrre all’estero. È una legge economica, la grande distribuzione orienta la produzione in quei luoghi dove conviene di più. Un prodotto agricolo ha un fattore limitante, a differenza di ogni altro prodotto industriale ha una deperibilità, cioè tu quando arrivi al prodotto hai poco tempo per poterlo commercializzare, e hai delle finestre, ovvero il mercato è interessante da questo periodo a quest’altro periodo, nel tempo queste finestre interessanti dove i prezzi sono remunerativi sono andate sempre più restringendosi, contemporaneamente i costi per gli agricoltori, i costi per i concimi, per il carburante, per le macchine, per la manodopera, negli ultimi vent’anni sono più che raddoppiati e i prezzi sono rimasti al livello di venti anni fa. Per questo l’agricoltura è in crisi. Quando la domanda è concentrata in poche mani, loro possono determinare il prezzo e andare a prendere ciò che gli interessa dove vogliono».
«Quando ero ragazzo, da Acerra partivano durante il periodo delle patate centinaia di vagoni con destinazione nord Europa, Germania e Francia, oggi questo è sparito. Quell’attività non era solo degli agricoltori, aveva un impatto sull’economia dell’agro nolano acerrano, in cui se erano tremila quattromila le famiglie dell’azienda agricola che vivevano di questa posizione, c’erano diecimila famiglie che vivevano del lavoro intorno a questa produzione: lavorazione, confezionamento, trasporto, l’agricoltura aveva un indotto grandissimo. Finisce una produzione salta tutto l’indotto. È stato un dissanguamento lento e continuo di energie, di persone, di intelligenze che sono uscite fuori dal circuito e ci hanno consegnato questo territorio. Adesso, che questo sia stato progettato o no, non lo so. La scelta dell’Alfa Romeo, la scelta della Montefibre, poi il Cis di Nola, tutte le varie aree industriali, hanno praticamente distrutto un territorio che era particolarmente adatto per l’agricoltura. Probabilmente, trenta, quaranta anni fa qualcuno o un gruppo di persone ha fatto delle scelte. Di questo territorio che cosa ne vogliamo fare? E le scelte che sono state fatte hanno cercato di copiare dei modelli dal nord Italia, di un certo tipo di piccola e media industria, ma senza creare cultura, senza creare organizzazione, senza creare infrastrutture, e hanno sventrato quella che era un’attività che si reggeva sulle proprie gambe, che dava lavoro non solo a chi stava in campagna ma a decine di migliaia di altre persone che erano legate a questo».
«In Campania i presupposti per lo sviluppo rurale ci sono. Se noi riuscissimo a sviluppare anche un’agricoltura legata alla tradizione e al territorio potremmo inserirci in questo circolo virtuoso. Ma il problema è lo stesso di trenta, venti, dieci anni fa: esiste oggi un progetto che inserisca globalmente la questione agricoltura al centro della questione economica regionale o provinciale? Perché se non esiste non accadrà nulla. La grande distribuzione e lo sviluppo rurale possono andare insieme, non sono antitetiche. Ma ci vogliono, quando ci si mette a contrattare a un tavolo, pari dignità e pari opportunità per entrambi gli interlocutori. Oggi non esiste questo, perché al tavolo della contrattazione non c’è nessuno. La politica non lo fa, tranne sporadici interventi. Se riesci a fare un prodotto di qualità è un discorso di filiera, e lì entra in gioco un disegno politico organizzativo. Oggi in agricoltura è importante la filiera, cioè il percorso che c’è tra dove viene prodotto il bene fino al consumatore. All’interno di questa filiera ci devono essere delle regole stabilite, dei controlli, una credibilità che si deve acquisire, in maniera tale che il consumatore sa che se il prodotto ha attraversato questa filiera, è buono, fa bene, non ci sono imbrogli. Qui il discorso di filiera è solo da qualche anno che si sta facendo, intendendo anche il discorso intorno ai passaggi, cioè quanti passaggi parassitari ci sono ancora? Per quale motivo un pomodoro costa al produttore sette centesimi al chilo e arriva al consumatore a un euro e mezzo? Oggi di qualunque prodotto agricolo, specialmente quello orticolo, del prezzo che è pagato dal consumatore, all’agricoltore va massimo fra l’otto e il quindici per cento. Questo dato è spaventoso. E l’agricoltore è quello che si è assunto tutti i rischi, quello che ha seminato, che ci ha messo la terra, che ci ha messo il lavoro, che ha evitato se gli è andata bene le gelate, gli allagamenti, la siccità, le malattie. Non esiste in nessun tipo di produzione una percentuale di guadagno così bassa per chi si è assunto tutto questo rischio. Allora vuol dire che nella filiera ci sono una serie di passaggi che sono solo speculativi. Bisogna individuare questi passaggi e tagliarli, così da consentire una giusta ed equa remunerazione a chi produce». (salvatore de rosa)

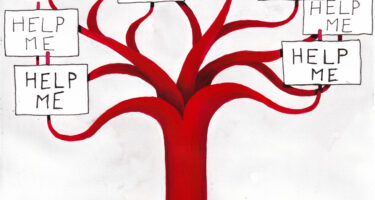



Leave a Reply