Nell’estate del 1963 il Dipartimento di Affari Indiani dello stato dell’Ontario (Canada) iniziò il trasferimento della comunità di Grassy Narrows in una nuova riserva. Grassy Narrows era una “banda” di nativi Ojibwa che da secoli abitava le sponde settentrionali del Lago Superiore. Fino agli anni Sessanta questo gruppo viveva ancora di caccia e raccolta, e manteneva più o meno vive le forme di vita tradizionali, le pratiche magiche e spirituali native, e la visione del mondo indigena. Secoli di guerre contro i bianchi, decenni di “scuole residenziali” con cui il governo canadese cercava di de-culturare i nativi, avevano certamente ridotto la loro autonomia, sancita da un trattato di resa firmato nel 1873, ma fino al trasferimento la comunità aveva continuato a vivere relativamente in pace, sia pure all’interno di un territorio limitato. Un’epidemia di influenza nel 1919 aveva causato morte e panico nella banda (così si chiamano le comunità native in Canada), ma nessuna catastrofe era riuscita a distruggere così profondamente la comunità come il trasferimento del 1963.
Quando l’antropologa Anastastia M. Shkilnyk andò a lavorare nella nuova riserva, nel 1976, trovò un vero e proprio inferno. La maggior parte delle famiglie indiane vivevano di sussidi, e a ogni pagamento quasi tutti i soldi finivano in alcool. Uomini e donne bevevano per interi fine settimana, fino a cadere incoscienti a terra, e trascurando completamente i loro figli e figlie, lasciate a se stesse, a volte a morire di fame o di freddo. La violenza interna alla comunità era spaventosa: stupri di gruppo, assassini, autolesionismo, suicidi, una grande quantità di bambini nati con sindromi legate all’alcool. Altri bambini erano lasciati apposta nella neve, o buttati nel fuoco: tra il ’74 e il ’79, in una comunità di duecentocinquanta persone, otto bambini erano morti per soffocamento e quattro abbandonati a se stessi.
Era difficile trovare dati precisi sull’entità della tragedia, perché per il governo canadese è proibita la raccolta di dati statistici su base etnica: ma era chiaro che dal 1963 in poi l’intera società Ojibwa di Grassy Narrows era precipitata in un incubo. “Mi sentivo gettata in un vuoto, in un posto grigio e senza tempo dove la scintilla vitale era estinta. Non era solo la povertà del posto, l’isolamento o la mancanza di un letto decente: avevo visto più deprivazione materiale quando lavoravo nei quartieri informali di Santiago del Cile, e avevo vissuto in un ambiente peggiore nella città di Ismailia devastata dalla guerra, lavorando in un progetto per la ricostruzione del canale di Suez. Ma quello che mi colpì di Grassy Narrows fu l’insensibilità dello spirito umano. C’era un’indifferenza, una spossatezza, una passività totale, che non potevo né comprendere, né fare nulla per cambiare”.
Nel suo libro A poison stronger than love, pubblicato nel 1985, descrive in dettaglio la tragedia della vita della comunità nella nuova riserva. Il titolo del libro riprende un commento di uno dei nativi sull’alcool che stava devastando la riserva. Lo definisce “un veleno più forte dell’amore per i propri figli”: “Non te lo posso spiegare, perché non lo capisco neanche io. È un veleno, e noi siamo gente perduta. Soffriamo così tanto dentro, che ci comprendiamo a vicenda”. I nativi sembravano rassegnati alle continue tragedie. Un uomo di sessantotto anni, pestato a sangue da una banda di ragazzini senza alcuna ragione apparente, diceva di non biasimarli più di tanto, né di volerli denunciare, perché “questo non sarebbe mai successo nella vecchia riserva. I ragazzi hanno bevuto, e quando la gente beve non è più se stessa”. La violenza, anche quella estrema, veniva perdonata, compresa, perché considerata un sintomo della catastrofe sociale provocata dal trasferimento.
Nel libro è riportato un lungo brano di un’intervista a Maggie Land, nata nel 1916, che racconta la vita prima del trasferimento. “I miei nonni dicevano che gli anziani già sapevano che tutto sarebbe cambiato. Non so come conoscessero il futuro, non avevano libri, non sapevano leggere, non avevano la Bibbia. Ma avevano i loro modi per sapere quello che sarebbe successo. Dicevano che i bianchi avrebbero preso la terra, e questo sta succedendo. Dicevano che ci sarebbero stati molti morti nella riserva. Quando sono cominciate tutte queste morti, all’improvviso mi sono ricordato di quello che mi dicevano”. Nella vecchia riserva, dove aveva vissuto per i primi cinquant’anni della sua vita, le famiglie vivevano in spazi ampi, avevano grandi estensioni di terreno per cacciare, e pur non avendo proprietà privata sapevano quali erano i limiti delle zone di ognuno. Periodicamente si ritrovavano in uno stesso luogo, per feste o celebrazioni, ma ogni famiglia era più o meno indipendente dalle altre. I bambini avevano dei compiti ben precisi, collaboravano alla caccia e alla raccolta, ma mangiavano quando c’era da mangiare e dormivano quando avevano sonno. Questa stessa indipendenza delle famiglie tra loro, e dei bambini rispetto agli adulti, dopo il trasferimento è diventata completa noncuranza: nello spazio insieme affollato e desolato della nuova riserva, tutte le regole del passato non hanno più senso, ma le regole, le abitudini e la legge dei bianchi ne hanno ancora meno.
La colonizzazione dell’America iniziata il 12 ottobre 1492 non è cosa del passato. È un processo che va avanti, che continua a produrre morte e sofferenza anche oggi, sebbene in nuove forme. Esse sono senza dubbio diverse dalla conquista delle grandi praterie che vediamo al cinema. I nativi americani sono conquistati ancora oggi, giorno dopo giorno, con l’imposizione di leggi che per loro non hanno senso, con la diffusione di sostanze tossiche che non sono in grado di gestire, con la disinformazione che li rappresenta come essenzialmente incapaci, con forme residenziali che rendono loro impossibile vivere come erano abituati a vivere, in alcuni casi con l’assassinio e l’arresto mirato di attivisti o sindacalisti. È naturalmente il caso di Leonard Peltier, in prigione dal 1977. “Se solo ci avessero lasciati in pace”, dice Maggie Land nel libro. “Ma è troppo tardi ora, non possiamo far tornare indietro il passato. Non c’è più scelta. I giovani cercano di diventare come i bianchi, e quelli che stanno in mezzo non sanno più come fare. Forse dobbiamo integrarci nella società dei bianchi. Ma io non mi voglio integrare”. (stefano portelli)

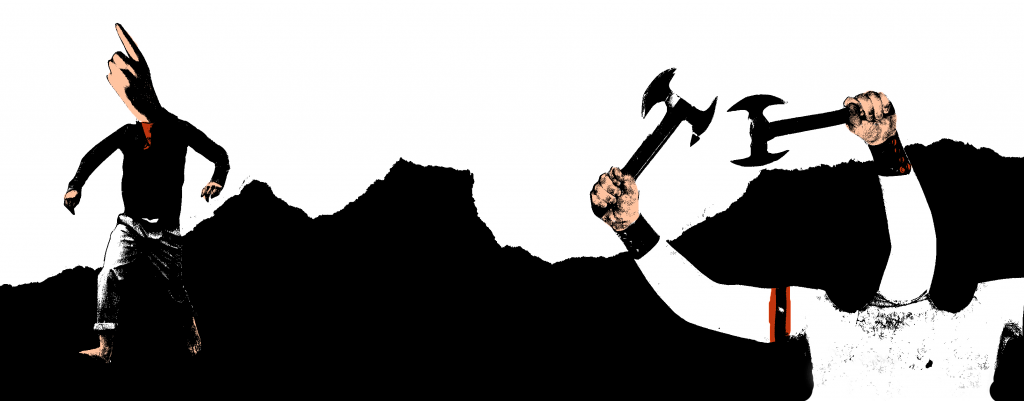

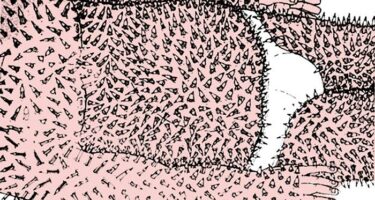


Leave a Reply