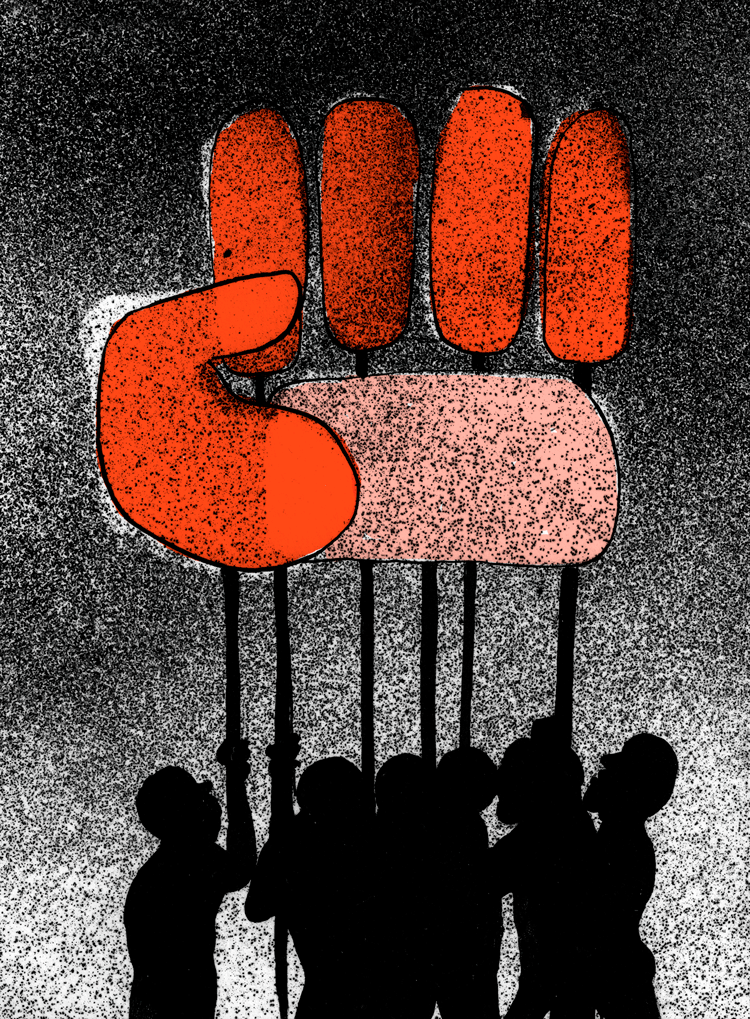
Il piccolo corteo di compagni e familiari si muove sull’asfalto al bivio tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri. Tra le mani una corona di fiori. Supera il ciglio della strada, fino alla terra, lì dove, due anni prima, un camion che trasportava pomodori, sbandando, ha travolto un furgone sul quale viaggiavano otto braccianti che tornavano dal lavoro nei campi. Quattro di loro, Aladjie Ceesay, Amadou Balde, Alì Dembele e Moussa Kande, sono morti in quel groviglio di lamiere e cassoni rovesciati sulla statale. Il grigio si era tinto di rosso, sul manto stradale scarpe e berretti a raccontare vite prima vessate, poi spezzate da un sistema di raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli fondato sullo sfruttamento degli esseri umani, sulla loro stessa vita. Due giorni dopo, il 6 agosto 2018, un’altra tragedia, sempre nel foggiano, in località Ripalta, a Lesina: un furgone bianco si scontrava frontalmente con un tir che trasportava farinacei. Dentro, stipati, quattordici braccianti, sono morti in dodici: Lhassan Goultaine, Anane Kwase, Moussa Toure, Lahcen Haddouch, Joseph Avuku, Ebere Ujunwa, Baofudi Cammara, Alagie Ceesay, Alasanna Darboe, Eric Kwarteng, Romanus Mbeke, Djoumana Djire.
Quell’anno e il successivo, i braccianti, al grido “schiavi mai”, hanno scioperato, sono scesi in strada, “la marcia dei berretti rossi”, l’hanno chiamata i giornali. Con loro Aboubakar Soumahoro. Quest’anno, a fronte delle normative anti-covid, non è stato possibile organizzare una nuova marcia, ma si è voluto comunque ricordare quella strage. «Non dimenticheremo mai i nostri compagni e tutte le lavoratrici e i lavoratori che continuano a morire sul lavoro», ha detto Sumahoro, che nel frattempo ha lasciato l’Usb, l’Unione sindacale di base, proseguendo il cammino di organizzazione e di lotta con le comunità dei braccianti che si sono riuniti agli Stati Popolari del 5 luglio scorso a Roma. «Le condizioni dei braccianti non sono cambiate, anzi per certi versi sono pure peggiorate. Per questo la nostra lotta va avanti». Un cammino che prosegue da queste terre del foggiano, da questa corona di fiori a cui fanno da sfondo enormi pale eoliche, una prospettiva che si fa metafora di una lotta in cui Dulcinea ha il volto dei diritti negati: da un lato le più povere e diseredate tra le genti, dall’altro una filiera agroalimentare che, dal caporalato alla grande distribuzione, schiaccia braccianti, piccoli agricoltori, trasportatori e terziario alimentare in nome del profitto di pochi e del consumo di tanti. Una filiera fondata sui ghetti.
TORRETTA ANTONACCI
Dopo la commemorazione ci dirigiamo verso Torretta Antonacci. Il “gran ghetto di Rignano”, così è conosciuto e raccontato nei tanti servizi che, negli anni, lo hanno descritto, filmato, fotografato, tra sgomberi, incendi, morti, una comunità di oltre mille e cinquecento persone che vivono tra baracche, container, dimore di fortuna. Ci arriviamo dopo due giorni di pioggia, gli oltre dieci chilometri di strade di campagna che la distanziano da Foggia sono invase da buche e acquitrini, in cui puoi solo sperare che l’auto non sprofondi. Incrociamo biciclette e altre auto che fungono da taxi: a fronte dell’emergenza pandemica e dello stato delle strade, da mesi, l’unica linea di autobus che portava in prossimità del campo è sospesa. Per andare a lavorare alle luci dell’alba e tornare dopo dieci o dodici ore di fatica, i braccianti devono arrangiarsi. Il cartello con l’indicazione “Torretta Antonacci”, ci spiegano, è recente, l’hanno voluto i braccianti, diventa segno di identità e resistenza: in quel luogo non ci sono i fantasmi di un ghetto, abitano uomini che formano una comunità.
Una comunità che vive nella contraddizione racchiusa dalla coesistenza tra l’enorme tendone che riporta la scritta “Ministero dell’Interno – Soccorso pubblico”, e le centinaia di baracche, di legno e lamiere, che diventano alloggi e piccole botteghe, soprattutto di generi alimentari. «Ora il campo è pieno di persone – ci spiega Alfa –. Alle sei del mattino, invece, è già vuoto, siamo già tutti a lavoro». Attraversiamo il campo sprofondando le scarpe nel fango: la pioggia di queste ore dà indizi su come si trasformerà quel luogo dopo l’estate, quando per riscaldarsi si dovranno nuovamente accendere stufe a gas e falò inevitabilmente pericolosi, come lo sono pure i precari collegamenti elettrici: l’incendio del 3 dicembre scorso ha distrutto le dimore di oltre trecento braccianti, mandando in cenere il loro unico riparo e le poche cose che avevano, compresi i documenti. A gennaio, era stato allestito un centro di accoglienza con tende e container, a febbraio il maltempo ha spazzato via la tendopoli. I braccianti, man mano, hanno realizzato nuovi alloggi nei quali trovare riparo. Eppure, da queste e altre sventure, da quel fango, dai rifiuti, dalle difficoltà e criticità che si accumulano a fronte delle negligenze istituzionali e della condizione di marginalità, è cresciuta negli anni, nel campo, un’identità sociale che supera provenienze geografiche e differenze culturali e linguistiche, iniziando a farsi coscienza di classe. Un percorso che si incarna in quelle schiene che restano piegate, in quell’andatura che rimane sempre sbilenca dopo ore, giorni, anni di fatica. Perché c’è chi vive in questo luogo da vent’anni, rivendicandolo ora come casa propria, e come tale chiede di poterlo gestire, collettivamente, di avere una residenza per accedere ai più elementari diritti.
Un processo di autodeterminazione cresciuto in questi ultimi anni di lotte che Aboubakar Suhamoro sta accompagnando: «In questo luogo di miseria, nel fango, abbiamo deciso di portare la parola dignità – afferma nell’incontro che facciamo in quella che da baracca è diventata sede assembleare –. Il cibo che tutti noi mangiamo, viene da qui, si nutre di questo fango». Nel frattempo, nell’ambito del progetto “Su.pr.eme. – Italia”, finanziato con fondi Fami, la Regione aveva emesso un avviso pubblico (andato deserto) per la gestione temporanea di Torretta Antonacci da affidare ad associazioni di volontariato e di promozione sociale, trasformando il campo in una sorta di centro di accoglienza; progetto cui la comunità di braccianti si oppone, rivendicando la propria soggettività politica, stanca di farsi gestire da regole e affari di terzi che innestano processi di ghettizzazione.
BORGO MEZZANONE
Lasciamo Torretta per raggiungere l’altro grande agglomerato di dimore di braccianti, a Borgo Mezzanone. Nato in un ex aeroporto della Nato, è conosciuto come “la pista”. Sembra infatti di essere atterrati in un’eterotopia dello spazio e del tempo, dove la vita scorre irruenta tra dimore in lamiera e mattoni, chiesette, rifiuti, auto e loro carcasse, bazar, una sorta di emporio che vende cucine, bombole di gas e taniche per l’acqua portando l’insegna “Il mercante dei sogni”. In questi mesi ci vivono più di quattromila persone, nel resto dell’anno è stanziale una popolazione di oltre mille e cinquecento persone. Molti venivano accolti qui dopo essere stati espulsi dal Cara che sorge a poche centinaia di metri, chiuso a maggio e dall’incerto futuro. La maggior parte fatica nei campi, alcuni anche nelle aziende di trasformazione. Per tutti lavoro nero, sfruttamento e caporalato. Anche su questo posto esistono centinaia di articoli e reportage, spesso tesi a raccontarlo esclusivamente come luogo di malaffare e illegalità, trasfigurando storie, vite, persone per suscitare un indistinto magma di indignazione e scandalo. Eppure, anche qui, pure nella miseria e tra le lacerazioni che abitano Borgo Mezzanone, abbiamo partecipato a un’assemblea dei rappresentati della comunità che ha sollevato temi e questioni dirimenti, rivendicando il percorso realizzato, mostrando la maturazione politica di una comunità intenzionata «a lottare, unita, con cuore e intelligenza» ha detto Sadio. «Siamo venuti qui per lavorare: pomodori, asparagi, frutta che tutti mangiano sono il frutto della fatica della nostra schiena, delle nostre braccia. Ancora oggi lavoriamo trenta giorni e ne troviamo cinque in busta paga, non abbiamo contributi, non abbiamo ferie o giorni festivi, non abbiamo la residenza, non accediamo agli aiuti del governo, se capitano incidenti sul lavoro non ci portano in ospedale». Per le persone di Borgo la sanatoria governativa è rimasta un miraggio, come le promesse di ministri, parlamentari e politici le cui visite al campo sono spesso passerelle per la stampa. «Ciò che abbiamo ottenuto – ci dicono –, a partire dall’acqua, è solo il frutto della nostra lotta».
Alla fine dell’assemblea, abbiamo raggiunto un quadrato di terra dove sono sepolte alcune spoglie di Mohamed Ben Ali, musicista e artigiano, richiedente asilo, che viveva a Napoli e come tanti si spostava nel foggiano per lavorare da bracciante stagionale. È morto all’alba del 12 giugno scorso, nell’ennesimo incendio divampato all’interno del campo. Il corpo giace ancora nell’ospedale della zona in attesa di poter essere sepolto nel suo paese d’origine, ma parte dei suoi resti, rimasti carbonizzati sulla terra, sono stati seppelliti a Borgo Mezzanone dai suoi compagni.
Attorno a questa straziante sepoltura le persone si sono strette in preghiera prima di salutarci. «Vi abbiamo accolto a casa nostra perché siete venuti, con noi, a sporcarvi le scarpe nel nostro fango», ribadisce Alfa, e ci invita a fare rete, a lottare insieme. Qualcosa si sta già mettendo in campo.
L’11 agosto, giorno della nascita di Giuseppe Di Vittorio, cui viene dedicata “La casa dei diritti e della dignità” proprio a Borgo Mezzanone, Aboubakar Soumahoro ha lanciato un nuovo soggetto, la Lega dei Braccianti con l’intento di associare tutti i braccianti della penisola. Si definiscono possibili collaborazioni, tra gli altri anche con le realtà sociali che nel casertano gestiscono terreni confiscati alla camorra, come la cooperativa Al di là dei sogni che con Simmaco Perillo ha accompagnato questo nostro viaggio.
La strada è ancora lunga, complessa, faticosa. L’estate, in certi luoghi, è una stagione crudele, ma ho imparato che camminando si apre il cammino. Sono tornato in nottata da Foggia, ho una casa, qualcuno che mi aspetta, ho sfilato le scarpe, le ho guardate, il fango era ancora lì, l’impasto di via del campo, impasto umano che forgia dignità. (antonio esposito)

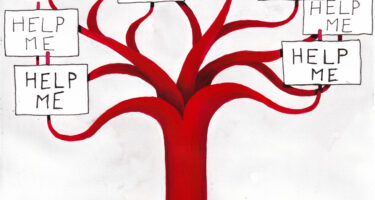



Leave a Reply