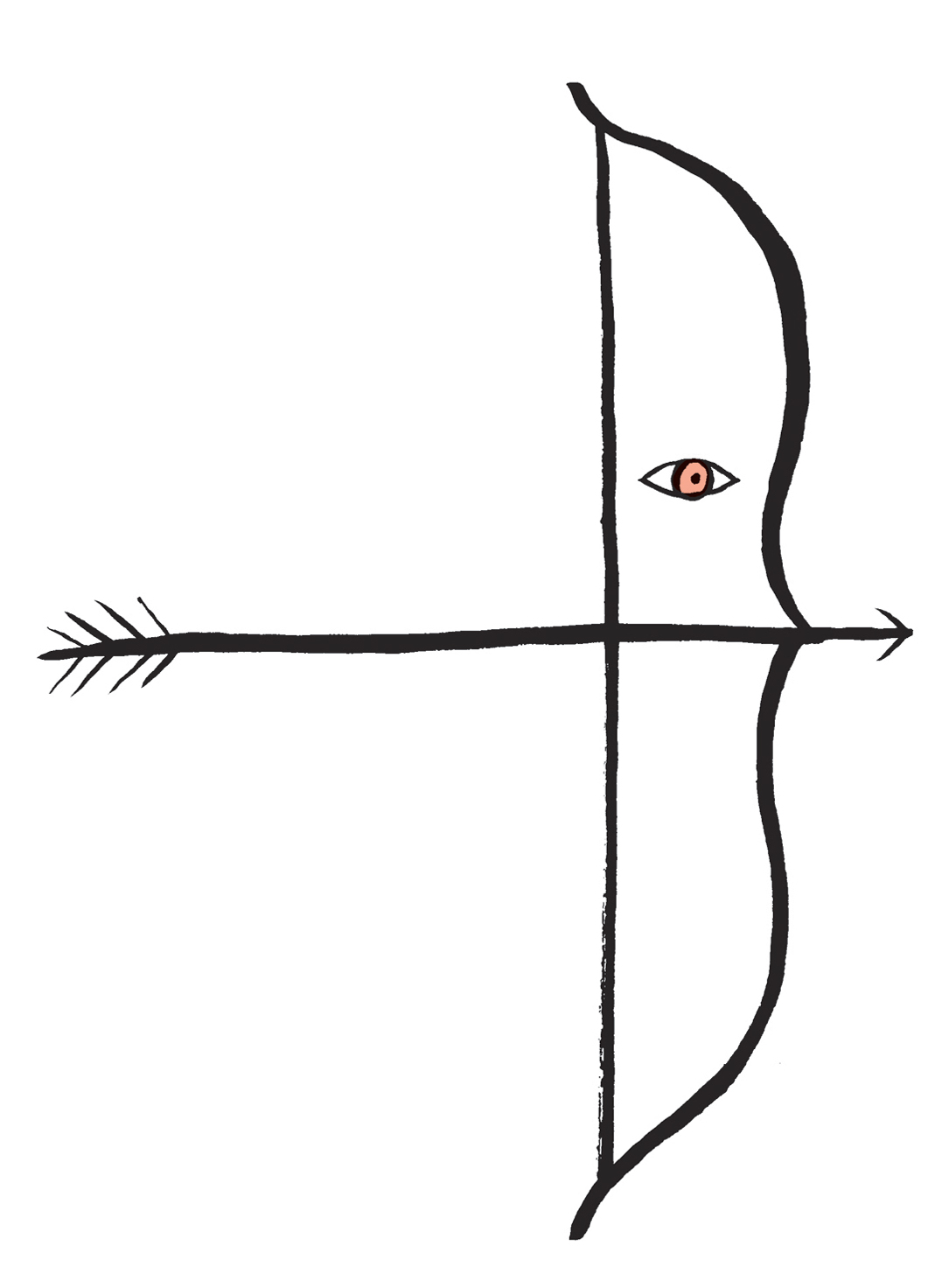
Verso la fine della mia ricerca di dottorato sulla comunità migrante bengalese di Torpignattara a Roma ho incrociato la vicenda tragica del suicidio di Suman, un ragazzo bengalese trovato impiccato a un albero del Parco degli Acquedotti. La vicenda, avvenuta a fine gennaio 2024, ha proiettato un’ombra sulla comunità bengalese, e mi si è dispiegata davanti come un microcosmo dei sogni spezzati che incombono su molti giovani migranti in cerca di un riparo nel cuore dell’Europa. Non avevo mai incontrato il ragazzo, ma la sua storia risuonava dentro di me con una familiarità inquietante, intrecciandosi alle storie raccontate da molte delle persone che ho intervistato. Il suo corpo senza vita, che penzolava nel parco intorno alla grande chiesa di San Policarpo sulla Tuscolana, evoca la dissonanza insostenibile tra le promesse dorate della propaganda di stato bengalese e le misere vite dei giovani come lui all’interno della comunità migrante.
L’Italia, posizionata strategicamente come porta d’ingresso per i migranti economici che raggiungono l’Europa, presenta in realtà un paesaggio paradossale. Sebbene per alcuni mantenga le sue promesse di prosperità, per molti altri riserva le complessità scivolose dell’assimilazione, dello sfruttamento e della marginalizzazione. Il suicidio di Suman è una rappresentazione del contrasto tra le narrative romantiche della migrazione e la realtà che subisce chi sceglie di intraprendere questa strada insidiosa.
Al cuore di queste narrative c’è il ruolo nefasto svolto dallo stato del Bangladesh, che fomenta un sistema retto sullo sfruttamento dei suoi cittadini, per alimentare le rimesse. I giovani migranti sognatori sono chiamati “guerrieri delle rimesse” (remittance warriors), un eufemismo orwelliano che cerca di occultare la ricerca sfrenata di introiti monetari da parte dello stato. Il viaggio in Europa, spesso presentato con glamour dalle agenzie statali, è facilitato anche da una rete oscura di mediatori, chiamati dalal. Questi intermediari chiedono agli emigrati tariffe esorbitanti, dai diecimila ai ventimila euro, manipolando le aspirazioni dei giovani che si imbarcano in un viaggio insidioso senza una vera preparazione o comprensione delle sfide che troveranno, spinti dalla propaganda statale e ipnotizzati dai video patinati di chi ce l’ha fatta.
All’arrivo a Roma questi migranti si trovano scaraventati in una comunità traboccante di sfruttamento e di conflitti di classe interni. L’immagine pittoresca dei quartieri descritti dalle narrative di stato si infrange rapidamente, mentre si dispiega la realtà delle loro condizioni di vita. I migranti, tra cui molti giovani come Suman, si consumano in lavori servili in una serie di esercizi commerciali – ristoranti, alimentari, parrucchieri, agenzie di trasferimento denaro, negozi di vestiti – spesso di proprietà di bengalesi di classe alta. E così, la visione romantica del bidesh (la terra straniera) si dissolve di fronte alla cruda verità: le condizioni lavorative di queste persone sono esempi da manuale di sfruttamento da parte dei loro compaesani. Obbligati a resistere per sette giorni a settimana, con turni che arrivano fino a dieci o dodici ore al giorno, si trovano alla mercé di datori di lavoro senza scrupoli che li pagano cifre ridicole – a volte addirittura tre euro l’ora –, molto al di sotto dello stipendio minimo legale.
Questa miseria permette loro di sopravvivere appena, appesantiti anche dal peso dei debiti con cui hanno finanziato la loro migrazione. Gli striminziti guadagni non coprono neanche le spese di base, e a volte li spingono ancora di più nel debito. Vivono in appartamenti sovraffollati dove abitano dieci o dodici uomini soli, un ambiente insano sia fisicamente che mentalmente. Le implacabili ore di lavoro lasciano poco tempo per acquisire abilità linguistiche o per sviluppare qualunque capacità da spendere sul mercato. Intervistando questi giovani uomini, ho sentito emergere una narrativa contrastante: Roma, la terra straniera, non possiede il fascino esotico associato al termine bidesh. Nei loro racconti disillusi ripetevano spesso l’espressione “questa non è bidesh”. La loro vita quotidiana si sviluppa in quartieri maleodoranti, trascurati dalle autorità, che li riportano sempre a immaginare una presunta vita migliore in Bangladesh, dove almeno la presenza della famiglia offrirebbe loro un minimo di conforto.
Il peso che portano questi migranti va molto oltre i problemi economici. Le loro menti sono catturate dalla paura di ritornare a casa, per quanto possano desiderarlo. La vergogna e il timore della pressione sociale fa ombra sulle loro vite, condizionando le loro narrazioni in modi complessi. Partiti dalla loro terra con sogni di una vita migliore, si ritrovano catturati in una rete di aspettative e percezioni associate all’etichetta di probashi (migranti), che nella società bengalese conferisce un importante prestigio sociale a chi la porta: un aumento di status che le loro famiglie si aspettano con largo anticipo. Ma queste lodi si trasformano in un peso insostenibile quando incontrano la dura realtà della vita all’estero. Tornare a casa è percepito come un fallimento, e significherebbe gestire non solo la propria delusione, ma anche il giudizio di una società che considera la narrativa del migrante come simbolo del successo. La stessa idea di essere un “guerriero delle rimesse”, diffusa dalle retoriche di stato, aggiunge pressione, poiché i guadagni realizzati all’estero dovrebbero compensare i loro sacrifici. La paura associata a un ritorno privo di successo diventa allora una forza palpabile, e crea una barriera silenziosa che dissuade molti anche solo dal considerare tale possibilità.
L’immagine commovente di Suman che circolava nei giorni dopo il suo suicidio, presumibilmente tratta dal suo profilo sui social media, lo rappresenta davanti al cancello chiuso di una qualche villa privata. Dietro quella barriera ci sono abitazioni di lusso, incorniciate da uno straordinario paesaggio naturale. Un dettaglio evidente aggiunge uno strato di simbolismo: il grande lucchetto che chiude la catena stretta intorno al cancello. Questo elemento, per quanto banale, è una potente metafora della posizione imbarazzante di Suman in Italia. Il cancello chiuso non rappresenta solo l’esclusione fisica, ma anche tutte le barriere e le limitazioni imposte a persone come lui nel territorio straniero che sognavano di conquistare. La porta chiusa indica l’inaccessibilità delle opportunità e delle aspirazioni che da lontano apparivano così promettenti. Invece della prosperità e della sicurezza implicite nel giardino della villa privata, Suman e i suoi compaesani si sono ritrovati chiusi fuori dalla ricchezza che evocava il loro sogno europeo. Ma il lucchetto non sono solo le leggi sull’immigrazione dello stato italiano; sono anche le politiche dello stato bengalese, e lo sfruttamento interno delle comunità migranti. (punny kabir / traduzione di stefano portelli)





Leave a Reply