
Negli ultimi anni gli studi sulla globalizzazione hanno alimentato un dibattito da cui è emersa non solo una definizione dei meccanismi di accumulazione della ricchezza nell’economia globale, ma anche un’interpretazione di come questi incidono sulle condizioni di vita delle persone. In estrema sintesi, due prospettive contrapposte si sono sviluppate nel tempo: la prima si concentra sulla varietà dei sistemi istituzionali a livello nazionale, la seconda sull’impresa organizzata “a rete” e il suo ruolo sociale al tempo della “disintegrazione della produzione e l’integrazione del commercio”.
In questa seconda prospettiva s’inserisce lo studio delle catene globali del valore o reti di produzione, un approccio che pone al centro dell’analisi la natura stessa del capitalismo contemporaneo. A partire da questo impianto teorico Vando Borghi, Lisa Dorigatti e Lidia Greco affrontano in un recente libro il rapporto tra lavoro e globalizzazione (Il lavoro e le catene globali del valore, Ediesse, 12 euro, 216 pagine), mettendo al centro le implicazioni che le reti produttive globali hanno sul Lavoro.
Quello delle catene del valore è un filone che ha fornito una cornice analitica utile a spiegare la frammentazione su scala globale dei processi economici e l’organizzazione reticolare della produzione. Non si riuscirebbe a comprendere a fondo, per esempio, il modello organizzativo di Amazon, di Maersk, della filiera agroalimentare, del tessile, dell’automobile o di altri settori economici senza osservare da vicino le caratteristiche strutturali di queste catene. Allo stesso modo non si riuscirebbero a comprendere a fondo le forme di sfruttamento e i conflitti in atto all’interno di queste filiere, o il processo inverso di smantellamento di interi settori produttivi.
Gli studiosi delle catene del valore vedono la mobilità geografica del capitale e il processo di accumulazione della ricchezza come il risultato dell’attività di una rete di imprese legalmente autonome e territorialmente dislocate, che cooperano nella produzione di beni o servizi. Tutto questo configura una divisione internazionale del lavoro, incidendo sulle dinamiche di subordinazione e sfruttamento della forza lavoro. La mappatura di questa catena serve a capire in quali circostanze si muovono le imprese, analizzandone la struttura organizzativa, la distribuzione delle risorse e i meccanismi di appropriazione del valore.
Il passaggio da strutture produttive verticalmente integrate a reti di imprese interconnesse ma autonome ha creato maggiore pressione sulle condizioni di lavoro nei livelli più periferici della catena del valore. L’esternalizzazione ha prodotto situazioni di dipendenza nelle relazioni fra imprese, cambiando la natura stessa delle relazioni di lavoro. Non è più possibile interpretare queste ultime come una relazione bilaterale fra lavoratori e datori di lavoro, poiché i datori sono loro stessi parte di reti gerarchiche di relazioni.
Gli autori sostengono che in questo nuovo scenario la riproduzione globale del capitale non persegue una logica astratta di razionalità economica, ma si basa ampiamente su variabili culturali, sociali e politiche. In molti casi, questi processi su scala globale hanno favorito una gara al ribasso e una competizione tra imprese e territori che si è risolta in una sfida alla compressione dei costi e alla deregolamentazione. Ciononostante, le strategie delle imprese non coincidono esclusivamente con la ricerca di forza lavoro a basso salario. Oltre a valutazioni di costo, la nuova organizzazione della produzione mondiale sembrerebbe mirare all’inclusione di una forza lavoro eterogenea dotata di specifiche caratteristiche, come il genere, la razza, l’etnia – dalle donne impiegate nel tessile ai filippini sulle portacontainer, passando per i camionisti bulgari, la forza lavoro migrante nelle piattaforme logistiche, e così via.
Le catene del valore identificano la natura asimmetrica delle relazioni che caratterizzano l’economia globale, e diventa sempre più rilevante investigare le relazioni sociali al cuore di queste catene, riflettendo sulle capacità di agire dei lavoratori, sulle condizioni in cui avviene l’incorporamento nelle reti produttive globali e sul potenziale di emancipazione per quanti vi sono coinvolti. La ricerca sociale deve quindi “analizzare la nuova fase di riorganizzazione delle forze produttive, che attraverso la valorizzazione della dimensione spaziale riescono a superare i vincoli sociali e a mettere a valore anche le relazioni sociali non economiche”.
Emergono due riflessioni in particolare, che riguardano da vicino chi da anni fa ricerca nel tentativo di fornire una lettura del presente, dentro e fuori l’università, con o senza risorse, qui come altrove. Ancor di più se si considera il (più o meno) recente dibattito sul rapporto tra sociologia e società e sul mestiere del sociologo in Italia. Primo: se le catene del valore forniscono uno strumentario concettuale per analizzare il rapporto tra globalizzazione e lavoro, è importante considerare gli aspetti critici di questo approccio. Deve far riflettere l’appropriazione di una tale teoria da parte di Fondo Monetario Internazionale, Organizzazione per lo Sviluppo Economico e Banca Mondiale. Sono queste istituzioni neoliberiste a parlare di disuguaglianza – sostenute dalla ricerca scientifica e dalle università –, a stimolare programmi e politiche nazionali orientate all’ingresso in queste catene, attraverso retoriche di apertura ai commerci e ai principi dell’economia globalizzata. Secondo: che la globalizzazione economica stia modificando i sistemi di regolazione nazionale lo dimostrano alcune trasformazioni in atto sotto ai nostri occhi. Gli stati che non si adoperano per inserirsi all’interno delle catene del valore resteranno tagliati fuori. Pur di essere incluse nelle reti produttive delle imprese transnazionali, i governi – e le istituzioni europee – hanno iniziato una corsa alla competizione regolativa, favorendo per esempio il proliferare di aree a regime economico speciale, nelle quali si applicano alle imprese agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative. È il caso delle Zone Economiche Speciali nelle aree del sud (ZES) previste nel decreto per il Mezzogiorno varato la scorsa estate. Le prime ZES riguardano proprio Napoli, un perimetro che dovrebbe comprendere il demanio portuale e le aree retroportuali a vocazione industriale della periferia orientale, gli interporti di Nola e Marcianise. Sarebbe opportuno indagare le attività economiche, le condizioni e i regimi di lavoro all’interno di queste “zone”. Il volume di Borghi, Dorigatti e Greco ha il merito di fornire uno strumentario analitico e di mettere in relazione i principi odierni di accumulazione della ricchezza con le dinamiche di lavoro, ma tutto ciò rischia di ridursi a una mera valutazione delle pratiche di resistenza o potenziale emancipazione se non si fa dialogare questo ragionamento teorico con il piano del reale. Il valore della ricerca sociale, il suo porsi a servizio della società, consisterebbe in ultima istanza nel dovere di fare inchiesta “per afferrare l’interdipendenza fra uomo e società, biografia e storia, individuo e mondo”, come scriveva Wright C. Mills. Se le catene globali del valore identificano la natura asimmetrica dell’economia globale, e se diventa rilevante investigare come questi meccanismi incidono sulle condizioni di vita delle persone, il ruolo della ricerca sociale diventa un problema politico su cui vale la pena riflettere. (andrea bottalico)

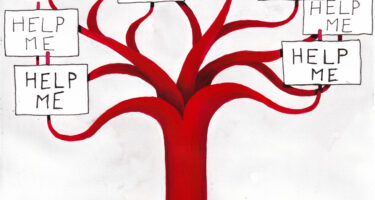



Leave a Reply