
«Ma allora, mi dica dove ho sbagliato». «Lei non ha sbagliato nulla. Non c’è errore nel suo agire. È una persona professionale, capace. Anzi, sono certo che farà strada», diceva il direttore, mentre si lasciava andare con la schiena sulla poltrona. Poi proseguì, accarezzandosi la barba, bianca e ordinata: «Cerchi di capirmi: io devo fare una squadra, ho bisogno che ci sia feeling con gli altri del gruppo». Ancor prima che potessi dire altro, concluse: «Certo, anche se non ci siamo visti molto, io certe cose le sento, ecco. Le percepisco, mi rendo conto se c’è feeling o no. A me dispiace non poterla portare avanti, ma qui ci sono altre esigenze, lei capisce… Proprio ieri ho dovuto lasciare a casa due professioniste, e mi è dispiaciuto molto, ma devo attendere a delle necessità…». Il giorno prima non era stato rinnovato il contratto a due collaboratrici del museo del Duomo, scegliendo di fare a meno di due storiche dell’arte, che ivi lavoravano da sette anni. Mentre nella sala del consiglio i membri dell’amministrazione, il direttore, i dipendenti si scambiavano gli auguri per l’imminente Pasqua, le ho viste piangere davanti a tutti.
La Fabbrica del Duomo è l’ente che Gian Galeazzo Visconti fondò nel 1387 per costruire una cattedrale che gareggiasse con le grandi capitali d’Europa. Il Duomo sarebbe stato completato negli anni Sessanta del secolo scorso, con la porta all’estrema destra. Da allora, e anzi, anche prima, ha avuto bisogno di continui restauri. Lo stato italiano, ereditando questa antica istituzione, la regolò giuridicamente come una onlus parziale, un ente di diritto ecclesiastico ma de facto composto solo da laici. L’ente ha la proprietà della cattedrale, dell’archivio storico e del museo del Duomo, riaperto lo scorso novembre al pubblico dopo una lunga chiusura per rinnovo. La Fabbrica è proprietaria anche delle cave di Candoglia, avute in concessione gratuita da Mussolini, dalle quali estrae il marmo per restaurare il monumento. Di recente ha anche acquisito, in comodato gratuito dal comune, la chiesa di San Gottardo, interna al Palazzo Reale, che versa in uno stato di grande degrado. Il progetto è di restaurarla entro Expo 2015.
Il consiglio di amministrazione è composto da sette persone. Due le nomina l’arcivescovo, cinque il ministero degli interni. Proprio il ministero assicura la rendita più consistente alla Fabbrica: fino al 2008 l’ente riceveva dieci milioni di euro, scesi a cinque in seguito. Per l’Expo, ai cinque previsti si sono aggiunti altri sette milioni di euro per la “programmazione straordinaria”. Tuttavia è previsto che questa cifra tenda a scendere, in virtù dei tagli che il governo sta applicando. Oltre all’introito pubblico vi sono le entrate del museo, delle terrazze (il principale incasso della Fabbrica), l’affitto delle sale per eventi, la raccolta fondi, che ha raggiunto circa cinque milioni di euro, ma spera di arrivare a quattordici nel 2015.
Per mettere insieme i cinque milioni di euro del ministero degli interni, dobbiamo sommare decine di monumenti italiani gestiti dal ministero dei beni culturali. La Reggia di Caserta, per esempio, riceverà un milione di euro come “intervento straordinario” voluto dal nuovo ministro Franceschini, che andranno a sommarsi ai centomila circa che riceve annualmente.
La posizione giuridica dell’ente lo avvantaggia nell’immissione del personale, che vi entra non per concorso pubblico ma per selezione. Di recente, con la nomina del nuovo direttore in vista di Expo, l’area della valorizzazione della Fabbrica si è arricchita di nuovi lavoratori, quasi tutti sotto i trenta anni, che lavorano duramente per ciò che concerne informazione, affitto di sale, organizzazione eventi, concerti, gestione del museo, pubblicistica. Su tredici ragazzi, sei sono stagisti. Da maggio 2013 a oggi, a quanto pare, sono passate per la Fabbrica una decina di persone, tra stagisti e dipendenti. Un ricambio continuo facilitato dai master universitari e privati con cui l’ente è in contatto, spesso inserendo nel proprio quadro personale non strettamente necessario ma comunque a costi molto ridotti. Il lavoro è frenetico in vista di Expo, e ci sono molte cose da ultimare, tra cui il museo e soprattutto i restauri, che interessano l’esterno e l’interno della cattedrale.
Non solo centro geografico, il Duomo è centro politico e sociale milanese. Qui s’incontrano Stato e Chiesa, si organizzano gli eventi culturali e religiosi sotto lo sguardo delle migliaia di statue marmoree. È la solida base sulla quale poggia l’Expo.
«Bisogna smetterla di lamentarsi, e dobbiamo essere grati di poter lavorare, è un nostro dovere! Anche se malpagati, anche se non ci piace, anche sfruttati, ma è l’unico modo per uscire dalla crisi. Se non facciamo così, le cose non cambieranno!» quasi urla Ferdinando, mentre mi dice queste cose. È più alto di me, mi sovrasta con la voce e il corpo, e agita l’indice per rinforzare le parole. Negli occhi fermissimi c’è una convinzione granitica, ma anche molta rabbia, come chi ha a lungo meditato queste cose, e ora finalmente può dirle. Ferdinando è dell’agro nocerino. Dopo la laurea in Bocconi, lavora per la Pricewaterhouse Coopers, azienda che si occupa di revisione di bilanci e che ha una sede a Milano. Di Milano è molto contento, Ferdinando. Dice che è “importante”, ma non sa dirmi perché. E non è la prima persona che incontro a dirmi che Milano è “importante”, senza sapermi dire perché.
L’ho conosciuto a Marano qualche mese fa, durante un convegno in cui si parlava dei problemi della gestione dei beni culturali in Italia, tra sprechi e disservizi. Intervenne sul finire, criticando chi si lamentava troppo e non era capace di fare impresa. Ci si lamenta, dico io, per una stato assente in un settore di servizi, che non ha, nella sua definizione giuridica, scopo di lucro. Ma non riesce a dare un senso a Pompei se non genera denaro, anche – e soprattutto – a scapito di una corretta informazione e gestione del sito.
Teorie liberiste che a Milano hanno la loro incubatrice. La città sembra una macchina pensata per spendere soldi a ogni angolo. Dall’ufficio dove lavoro posso vedere il Palazzo Reale, che ospita ininterrottamente tre o quattro mostre: alle 18.30 si crea, a partire dal giovedì e per il fine settimana, una lunga fila all’ingresso, come un rituale. Ogni mostra produce più o meno la stessa fila, salvo rare variazioni: si tratta di decine di mostre l’anno, perlopiù format comprati dall’estero che fanno girare sempre gli stessi artisti. Il venerdì invece ci si riversa in Brera o Navigli per l’aperitivo, mentre al sabato la città si addormenta verso mezzanotte, in pieno centro, quando tutti i locali cominciano a chiudere. Qualcuno resta aperto in zona Navigli, ma non oltre l’una di notte. Usciti dal centro cittadino, nei quartieri circostanti, i bar hanno già chiuso alle sette del sabato, e resteranno chiusi tutta la domenica. «Sono qui da trentasei anni», mi spiega un ristoratore calabrese di Bande Nere, quartiere ovest di Milano. «Negli ultimi dieci questo quartiere si è trasformato: sono spariti i pochi locali notturni e i bar si sono diradati. Oggi non c’è nessuno per strada», mi dice nel suo locale vuoto, mentre mi prepara quella che sarà, probabilmente, l’unica pizza della giornata.
Il week end si divide tra parco e lago, con cadenza precisa. Si avverte l’esigenza di “dover fare”, solo perché ve n’è l’occasione. Come se la moltitudine di opportunità non generasse la possibilità di scegliere, ma il dover scegliere a ogni costo.
Francesco mi accompagna per il centro della città, accanto a piazza Fontana: «Vedi questo negozio della Rifle? Fino a poco tempo fa c’era un bar storico di Milano, di quasi cent’anni. Le tasse lo hanno messo alle strette: ha chiesto aiuto al comune e ai cittadini, senza riceverne, e ha dovuto chiudere», mi spiega. «Era uno dei pochi punti aggregativi qui in centro». Francesco è del pavese, ma ha studiato e lavora a Milano. Poco distante c’è la rosticceria Luini, che alle otto ha già chiuso. I milanesi si lamentano di come, in pochi anni, abbia speculato sui suoi prodotti dimezzandone le dimensioni.
Frattanto la fibrillazione per l’Expo, previsto fra meno di un anno, cresce. E con essa i prezzi degli affitti: «Vivo qui a Milano da sei anni», racconta Viviana, studentessa di medicina. «Fino a un anno fa avrei detto che mi trovavo bene qui. Ora che devo cambiare casa mi sono resa conto che i costi sono raddoppiati, ma la città non ti dà nulla più di qualche anno fa. Sta diventando sempre più difficile viverci».
Milano è la città italiana in cui la gentrificazione ha conosciuto maggior sviluppo. I quartieri popolari che si trovavano in centro sono spariti con le edificazioni iniziate negli anni Sessanta. Pian piano, l’alta borghesia si è impossessata di ogni quartiere compreso tra le quattro antiche porte cittadine, respingendo le classi meno agiate verso l’esterno. Oggi le si ritrova a Baggio e a Quarto Oggiaro, dove immigrati meridionali, sudamericani, nordafricani e cinesi condividono gli stessi spazi. Piccola enclave estranea alla movida del centro è Loreto, quartiere di immigrati ma a ridosso di corso Buenos Aires: è un territorio evitato dalla borghesia meneghina. La presenza di stranieri ha fatto scendere di molto i costi degli affitti, e hanno cominciato ad approfittarne gli studenti. Gentrificazione anche al contrario: pizzerie e ristoranti italiani sono ormai nelle mani dei cinesi, come mercerie, lavanderie, ferramenta. La città sembra spaccarsi in due: un centro fatto solo di vetrine e luci, abitato da milanesi che, però, non lo vivono; una periferia in cui sono stipati i non-lombardi (ma sarebbe errato parlare di minoranze). Si crea una città a camere non comunicanti, quartieri isolati tra loro che finiscono per essere enormi dormitori.
Il silenzio delle vie milanesi è interrotto solo dagli happening, gli eventi comandati come la Fiera del Mobile o la Settimana della Moda: in queste occasioni fiumane si riversano in strada, per poi sparire di colpo alla fine dell’evento, come se a guidare ogni bisogno di socialità debba esserci uno schema prestabilito: quello del divertentismo ostinato, la fabbrica dei piaceri imposti e costosi.
La città è gestita da una solida borghesia cattolica, che attua un controllo sociale sottile non permettendo forme di autorganizzazione nel cuore della città. Qualcuna si comincia a trovare in periferia e, in maniera più diffusa, in provincia, dove si riversano molti ragazzi per una birra a buon prezzo e musica gratuita.
Frattanto, il “quadrilatero della moda” luccica di insegne e negozi, mette in piazza tutta l’apparenza che ha. Sfilano le persone. Moltissime di queste non possono permettersi quegli acquisti, ma ne partecipano solo vedendoli, e si sentono parte di una élite che ha nell’immagine lo scettro del comando. È la Milano “importante” di cui molti faticano a dare una definizione. (alessandro cocorullo)

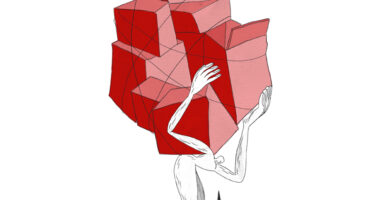



Leave a Reply