
Il 24 febbraio scorso è venuto a mancare Joseph Ponthus. Come redattore di Article 11, una rivista indipendente francese, lo invitammo a Napoli nel marzo 2011 in occasione della prima edizione della rassegna Chi racconta la città – Ascoltare, osservare, ricordare. Nel 2019 Joseph ha scritto À la ligne. Feuillets d’usine (La table ronde), un libro che speriamo di vedere presto tradotto anche in Italia. In suo ricordo, la redazione di un’altra rivista francese a noi cara, CQFD, ha pubblicato l’intervista realizzata a Joseph da Émilien Bernard sul numero cartaceo del settembre 2020, in cui si affrontano le questioni più rilevanti del suo libro – l’alienazione, l’impossibilità di distinguere tra tempi della vita e tempi del lavoro, la vita in fabbrica, l’immersione in un ambiente diverso dal proprio ceto di appartenenza, il linguaggio adatto per raccontare il lavoro, eccetera.
Anche noi vogliamo omaggiare Joseph Ponthus attraverso la traduzione in italiano della sua intervista.
* * *
L’amico Joseph Ponthus, detto Ubi per gli intimi di allora, io l’ho conosciuto qualche anno fa all’epoca di Article 11, rivista cugina di CQFD in cui Joseph scriveva cronache nella rubrica “Sévice social”. Con penna sensibile ha raccontato la sua vita quotidiana di educatore in un quartiere di Nanterre: i ragazzi che scherzano con gentilezza, la giustizia implacabile, gli orizzonti rovinati. Alla fine ha prodotto un libro altamente raccomandabile, scritto in collaborazione con quattro dei ragazzini che seguiva quotidianamente: Nous, la Cité (Zones, 2012). Da allora ci siamo un po’ persi di vista, così è la vita. Io mi sono trasferito a Marsiglia, lui a Lorient, non esattamente la porta accanto.
In Bretagna, Joseph si è reso rapidamente conto che le sue abilità letterarie e sociali non lo avrebbero aiutato a sbarcare il lunario. Un classico. Senza un soldo, si è rivolto all’agenzia interinale. Così sono iniziati tre anni di lavoro particolarmente duro: uno nelle industrie conserviere del pesce, due nei macelli. Una quotidianità consumata dalla fabbrica, che ha descritto in À la ligne – feuillets d’usine (La Table Ronde, 2019), un libro in forma così “sperimentale” – versi liberi, senza la minima punteggiatura – che sembrava condannato a vegetare sugli scaffali delle librerie. E invece no: il libro è stato un successo, tradotto ovunque, e Ubi ha potuto dire addio alla dannata fabbrica. Va detto che è riuscito, da buon alchimista letterario, a rendere quel mondo, che generalmente si limita a visioni sanguinose di carcasse e corpi squartati, particolarmente vivo e commovente. Senza miserabilismo ma con coraggio, ha offerto una testimonianza che vuole essere universale, un’ode al coraggio dei suoi colleghi e un’accusa implacabile contro questo mangiatore di vita che può essere il salariato, soprattutto la sua versione interinale. Quel che segue è il testo quasi fedele di un’intervista telefonica con Ubi, intervallata da alcune citazioni dal suo libro.
«Tutto è iniziato in modo molto classico: io e la mia compagna non avevamo più soldi, dovevo trovare un lavoro, sapendo che in questa zona i lavori per un educatore quarantenne non sono tantissimi. Avevo solo un’opzione: il lavoro interinale. Tuttavia in Bretagna, ciò che offrono è generalmente legato all’industria agroalimentare. È la regione più grande d’Europa per questo settore, un’eredità del 1945, quando il territorio fu devastato e le lobby e i datori di lavoro locali fecero di tutto per incoraggiare questa filiera indirizzandosi così ai politici: “Voi ci fate delle belle strade e noi vi forniremo tutto ciò che desiderate mangiare, dal pesce alla carne”. La loro argomentazione: avevano una riserva di uomini duri, di quelli che uccidono i maiali nella fattoria. Insomma, è diventato un marchio di fabbrica. Oggi, un terzo della popolazione bretone vive direttamente o indirettamente di agroalimentare.
«L’immersione è stata quasi immediata: “Si inizia domani alle sei del mattino”. E lì mi sono ritrovato in un altro mondo. L’unico paragone che mi viene in mente è Tempi moderni di Charlie Chaplin e il suo ritratto del lavoro nella catena di montaggio che intorpidisce la mente. Ti danno un lavoro, ti fanno vedere, poi ti dicono: “Ci vediamo tra otto ore”. Ecco.
«All’inizio non mi aspettavo di restarci a lungo. Ho visto il lavoro interinale come un male temporaneo, dicendomi che avrei trovato qualcos’altro. Ma non funziona così. La fabbrica mangia il tuo tempo, il tuo corpo e la tua mente. Quando torni a casa hai un solo desiderio: dormire. Puoi anche aver letto tutti i libri possibili sul proletariato, non capisci cosa ti sta succedendo. Questo è ciò che dice Robert Linhart ne L’Établi [1], quando spiega che nonostante avesse lavorato su Marx per vent’anni, dovette aspettare il suo primo giorno in fabbrica per capire quale fosse il concetto di plus valore».
“È il fine settimana / Dovrei ricostituire la mia forza lavoro / Vale a dire / Riposare / Dormire / Vivere / Altrove che in fabbrica / Ma lei mi mangia”.
«Non appena metti piede lì, la fabbrica è ovunque. Ti mangia il quotidiano. Mi ricorda il modo in cui i minatori si riferivano alla miniera, dicendo che era un “mangiatore di uomini”. La fabbrica è lo stesso. Gli uomini e le donne che ci lavorano pensano solo a questo: l’ora in cui ti sveglierai, l’ora della pausa, il prossimo arrivo. È una lotta perpetua contro il tempo. A questo proposito, non è trascurabile che il documentario in quattro episodi di Stan Neumann, recentemente andato in onda su Arte, si intitoli Le Temps des Ouvriers [2]. Andando alle radici del capitalismo, dimostra perfettamente che dal diciottesimo secolo tutto è stato fatto per abbassare i salari e aumentare la produttività. Rubare il tempo ai lavoratori. Un sistema implacabile, che si è imposto integralmente. A questo bisogna aggiungere la condizione di interinale, che all’inizio comporta una forma di nonnismo. Ti offrono alcuni giorni qui e altri giorni altrove. Ti cambiano gli orari. Ti cambiano fabbrica. E tu sai che se lo contesti e protesti, allora hai finito: non avrai più un lavoro nell’intera area di occupazione. Devi incassare e stare zitto. Dopo un po’ ti vengono assegnate missioni più lunghe. La mia prima sono stati i bulot, tonnellate di frutti di mare da spalare ogni giorno per cucinarli. Il terzo giorno ho posto una domanda che mi sembrava elementare: “Non sarebbe più facile con una macchina?”. La risposta del capo: “Assumere lavoratori temporanei costa meno”. Se domani non ci sarai, niente di più semplice che trovare qualcun altro».
“La ripetizione dei dolori / La vanità dell’affare / Tutto questo per dei bulot che non si fermeranno mai”.
«Questo è il colpo di genio del padronato: sono riusciti ad atomizzare la coscienza della classe operaia. Oggi non ti definisci più come un lavoratore, o come un dipendente di una determinata azienda, ma in relazione alla tua postazione di lavoro, dove c’è concorrenza. Questo porta alla conclusione: non è più possibile alcuna lotta collettiva. Inoltre, con questa specificità bretone: a differenza dei vecchi bacini operai, come quello della siderurgia in Lorena, l’habitat è estremamente disperso, con persone che vengono a lavorare da diverse decine di chilometri di distanza. Di conseguenza non c’è posto per socializzare, per incontrarsi altrove che in fabbrica. È il trionfo del capitalismo nella sua forma più violenta. E poi, lavorando nell’agroalimentare, non hai l’orgoglio della produzione. In una fabbrica “normale” si parte da zero e si finisce con un prodotto finito. Nell’agroalimentare è il contrario, è decostruzione: prendi un prodotto intero, per esempio una mucca, e ti ritrovi con una bistecca. È impossibile essere orgogliosi di dare la morte. Si tratta solo di svolgere la tua mansione nel miglior modo possibile, nel modo più nobile e meno doloroso possibile».
“I vitelli non mi guardano più con i loro occhi morti e freddi”.
«Sono stato invitato a dare una testimonianza in un documentario che trovo piuttosto riuscito, Les damnés des ouvriers en abattoir [3]. Il suo approccio ribalta la visione abituale di questo lavoro: sono testimonianze molto potenti di lavoratori che raccontano la loro vita quotidiana. Ma, per non rimandarli a queste immagini del mattatoio, del sangue, delle budella, sono filmati in una foresta. Si tratta di non limitarli a un ambiente umiliante, svalorizzante. E io ho voluto fare lo stesso: un oggetto letterario, aperto e sgangherato. Se tu racconti soltanto l’orrore quando torni a casa la sera, non ci ritorni l’indomani.
«Dalla mia prima settimana di lavoro ho iniziato a scrivere dei passaggi quando tornavo a casa, di pomeriggio o la sera, a seconda dei miei orari, quando non ero troppo stordito. Il mio obiettivo era scrivere in un modo simile a come funzionavano i miei pensieri quando ero al lavoro. In fabbrica ti trovi di fronte al problema della cadenza, cioè la produzione imposta dalla fabbrica stessa. Hai un minuto per svolgere l’attività che ti viene chiesta. Per esempio, stringere venti bulloni. All’inizio non conosci il gesto e sei goffo, quindi fai solo quindici bulloni al minuto. È l’amico dietro che deve recuperare i cinque mancanti. Perché la catena avanza in modo ineluttabile. Ma una volta che impari a effettuare il gesto per bene, a diventare tutt’uno con lo strumento o la macchina, diciamo che puoi farlo in quarantacinque secondi. Hai più o meno quindici secondi di “libertà”. Qui è dove hai tempo per pensare. E io pensavo ai libri, alle poesie, alle frasi che avrei scritto la sera quando sarei tornato a casa».
“Qui il tempo non finisce”.
«È qui che è nata e si è imposta la questione del ritmo letterario. Perché io volevo scrivere su questi quindici secondi di libertà. Se avessi scelto di adattarmi al ritmo regolare della fabbrica, un compito al minuto, allora avrei scritto in versi regolari, di tipo alessandrino. Ma il mio ritmo era diverso, poiché io lottavo contro la cadenza, con delle irregolarità, a volte cinque secondi, a volte dieci o quindici. Quindi potevo scrivere solo in versi liberi.
«La fabbrica è la protagonista principale del mio libro. Un po’ come Ivo Andric ha raccontato la storia della Bosnia attraverso il suo Ponte sulla Drina (1945). Ma per questo devi essere astuto, prendere il tuo soggetto da un angolo. A questa massa d’acciaio, di morte, di sofferenza, bisogna avvicinarsi con mezzi subdoli: i colleghi, gli attimi rubati, le pause strappate, le forme di micro-solidarietà, i piccoli recuperi. Perché è impossibile descrivere davvero un mondo in cui vieni divorato, le sue sfumature di paura, di merda, di metallo. Se la fabbrica è viva, è solo per gli operai che ci lavorano all’interno ogni giorno».
“La fabbrica mi ha preso / ne parlo solo dicendo / La mia fabbrica”
«Sono stato licenziato dal mattatoio il giorno in cui ho inviato le copie del libro all’agenzia interinale e alla direzione del mattatoio. Eppure non ho scritto un atto d’accusa. Avrei potuto descrivere gli imbrogli, certi scandali che avrebbero fatto scorrere l’inchiostro. Se non l’ho fatto era per paura che i miei amici si sarebbero trovati disoccupati, con i loro debiti da pagare e il mondo che gli crollava addosso. Quello che volevo era che fossero orgogliosi del libro, che si identificassero con esso. Perché è estremamente difficile raccontare quel quotidiano. Quando dici “lavoro in un macello”, la discussione è sempre distorta, le persone ti guardano in un altro modo. Ma in realtà questa condizione accomuna molte altre esperienze professionali, anche al di fuori di quel contesto. Da quando ho presentato il libro in vari luoghi della Francia, mi sono confrontato con persone che non ne possono più della loro vita professionale. Dipendenti di case per anziani che ti dicono: “Per me è lo stesso, faccio cose orribili perché non mi danno il tempo di fare un buon lavoro”. Infermiere che sbuffano: “Chiediamo dei letti da quindici anni”. Cassieri che si lasciano andare: “Dato che le pause sono proibite veniamo a lavorare con i pannolini”. Siamo a questo. Devi immaginare l’angoscia di questo ragazzo che va alla farmacia del paese a comprarsi i pannolini, che li nasconde in macchina e se li infila negli spogliatoi. L’umiliazione assoluta.
«Di fronte a questo campo di rovine, se il mio libro dà un po’ di nobiltà al lavoro operaio, allora è già enorme. Per questo sono felice che stia succedendo qualcosa intorno al libro, con vendite inaspettate, premi letterari e traduzioni in molti paesi. Era tutt’altro che scontato: raccontare l’agroalimentare bretone in versi liberi? Difficile vendere di meno. Eppure la cosa funziona. Perché parla semplicemente di cosa significa dover incassare, lavorare. I cinquantenni precari piegati sotto le carcasse. Il corpo che si lascia andare. La produzione che domina su tutto. È universale.
«Quando sono entrato in questo argomento per la prima volta, non era affatto il mio mondo. Ero un educatore, con studi di letteratura alle spalle. È stata una vera esperienza di declassamento, che mi ha insegnato molte cose. Da un giorno all’altro mi sono ritrovato con ragazzi che mi hanno insegnato il mestiere, a prendersi cura delle mie mani, a non farmi male, a non uccidermi. Tutto sommato, al netto delle differenze, lo paragono alla letteratura sulla guerra del 1914, quando personaggi come Blaise Cendrars, Guillaume Apollinaire o Maurice Genevoix si trovarono di fronte a qualcosa per cui non erano affatto preparati, con la gente comune, il fango, la morte. Dopo di che, non potevano scrivere allo stesso modo, impossibile».
“Quando torni a casa / Alla dissolutezza / tiri avanti / in stato comatoso / Stai già pensando all’ora di svegliarti / Non importa a che ora / Sarà sempre troppo presto”.
«Nel documentario sui lavoratori dei mattatoi dico che ogni fine settimana dovevo “reimparare a parlare la lingua dei vivi”. Perché devi capire che con i colleghi non parli durante la settimana. Prima di tutto perché indossi tappi per le orecchie, cuffie. E poi per dire cosa? Gli unici scambi sono ordini, invettive. Per una settimana sei formattato in una non-lingua, in modalità performativa: quante ore ti rimangono per sparare, stai zitto, spingi più forte… Non parli. Durante la pausa fumi la tua sigaretta, bevi il tuo caffè e nient’altro. Dato che sei nell’industria della morte, di notte ti divora, hai gli incubi. Pensi solo a una cosa: il prossimo fine settimana. Ma questo momento viene raggiunto anche dalla fabbrica.
«È tutto molto difficile da spiegare. Cosa vuoi dire alla gente? Del sangue in piena faccia? I fegati che ti esplodono addosso? Le tue otto ore a spazzare sterco di vacca? In fabbrica sei in purgatorio. Lavori con la morte. Si sente la morte. Partecipi a quello. Sei un boia a modo tuo, ma vuoi credere di non esserlo. Immagina: settecento teste di vacca al giorno, mille quattrocento occhi di vacche agonizzanti. E dici a te stesso: i colleghi resistono da quarant’anni, perché io no? Una cosa è certa: musi tagliati, mammelle affettate, queste cose non si possono raccontare nella lingua dei vivi, perché nessuno può capire. La lingua si ferma. Questa vita quotidiana passa attraverso gli occhi, le espressioni facciali del lavoratore, una mano che batte sulla spalla, ma non attraverso la voce. C’è solo la scrittura che può farlo.
«La sento ancora questa esperienza: ho incubi ogni settimana. Sarà sempre lì. L’esperienza più bella e più difficile della mia vita. Lì ho vissuto cose che non avrei mai immaginato, ho incontrato compagni che lo saranno sempre. In fondo al sordido si annida anche la più grande nobiltà. Sono persone che non la riportano indietro, che non mostrano la loro condizione nella pubblica piazza, ma che comunque fanno mangiare la Francia. Ecco perché volevo che apprezzassero il libro. Dopo aver buttato il sangue al loro fianco per tutto questo tempo, mi ha particolarmente commosso vedere che hanno insistito perché mettessi i loro veri nomi e dicessero di essersi riconosciuti in certi passaggi. Erano i primi a cui l’avevo letto, come era avvenuto con i ragazzi di Nanterre, per Nous, la cité. Solo che a Nanterre ero in grado di sapere. Quando sono arrivato in fabbrica è stato il contrario: sono loro che mi hanno insegnato tutto su questo universo». (intervista di émilien bernard / traduzione di andrea bottalico)
[1] Opera pubblicata nel 1978, simbolo dei maoisti che avevano scelto di andare a lavorare nelle fabbriche per fomentare la rivoluzione tra le “masse lavoratrici”.
[2] Joseph Ponthus interviene in diverse occasioni in questo documentario.
[3] Documentario di Anne-Sophie Reinhardt


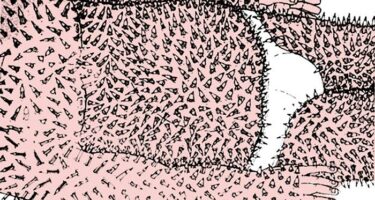


2 Comments