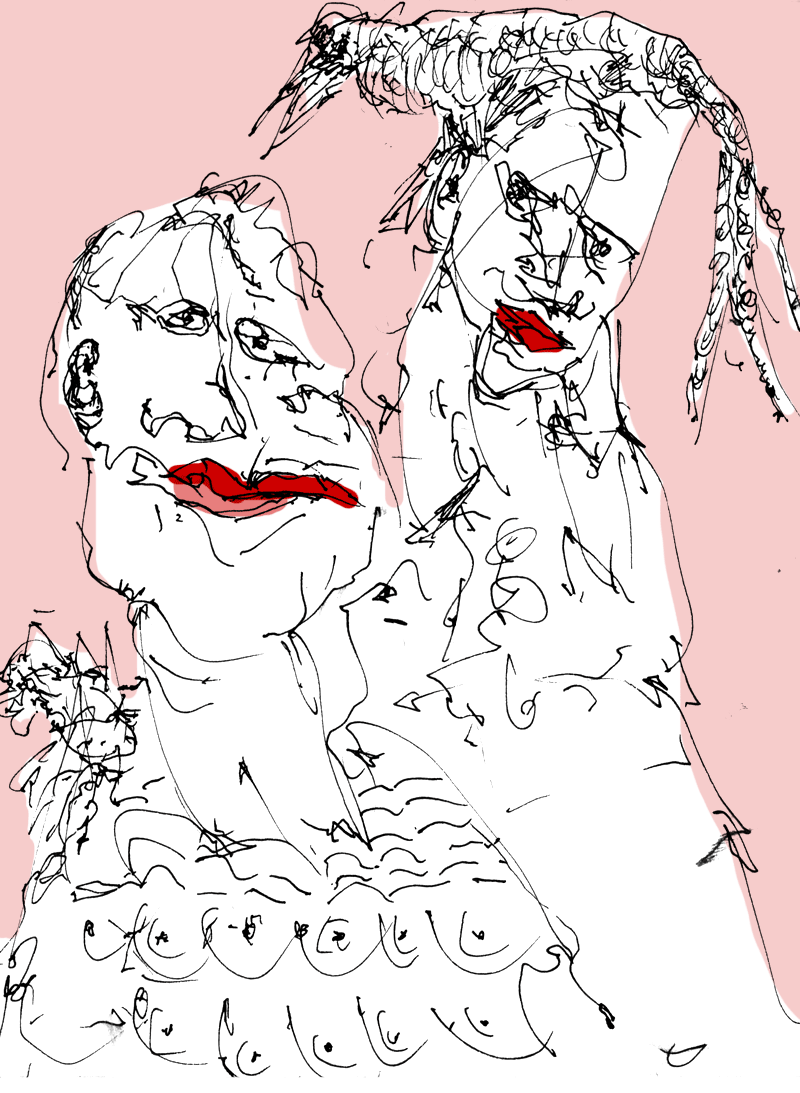
Nel 1976 Michel Foucault tenne in Italia due conferenze (poi pubblicate in Microfisica del potere) in cui sosteneva che il potere è una guerra silenziosa che ri-scrive il conflitto nelle istituzioni, come nelle disuguaglianze economiche, nel linguaggio e persino nei campi degli uni e degli altri.
La prima cosa che viene in mente leggendo Storia dell’Italia Mafiosa. Perché le mafie hanno successo di Isaia Sales (Rubettino, 2015, pp. 444), è questo pensiero del filosofo francese che fu tra i primi a indagare la genesi e gli effetti del potere criminale all’interno della nostra struttura sociale.
Questa nuova analisi dello storico delle mafie sulla criminalità organizzata nel Mezzogiorno – i suoi primi saggi sulla camorra risalgono agli anni Ottanta – si configura, infatti, come una sistematica, foucaultiana ricerca sulle strutture elementari del potere di Camorra, Cosa nostra e ‘Ndrangheta; associazioni criminali che, pur nella loro diversità, hanno un segno che li accomuna: si distinguono da altri fenomeni malavitosi perché traggono la loro forza, il loro potere, prima che dalla violenza – che adoperano in modo strategico e selettivo – da un sistema di relazioni con altri poteri dello stato. Senza questa legittimazione da parte delle istituzioni, oggi non staremmo ancora a parlare dell’irradiazione del potere criminale dal sud al nord del paese, e le mafie sarebbero state sconfitte, come sono state sconfitte tutte quelle forme di violenza criminale – dal brigantaggio al banditismo – che hanno combattuto dall’esterno il potere politico; anche il terrorismo subì uguale sorte, non solo perché fu politicamente isolato dalla classe operaia di cui intendeva rappresentare il malessere, ma perché si caratterizzò come una cellula isolata dal corpo istituzionale. Nel caso delle mafie ciò non è avvenuto, perché – insiste Sales – esse nascono, proliferano e si alimentano dentro lo stato. La difficoltà a contrastarle scaturisce anzi dal legame collusivo tra mondo del crimine, politica e istituzioni; una commistione che è inscritta nella nostra storia dal tempo dei Borbone, e che nello stato unitario trova uno spazio insperato e una forte accelerazione, anche per le nuove opportunità economiche che si presentano agli inizi del Novecento nei processi di modernizzazione del tessuto economico e produttivo meridionale.
Esempi eclatanti di questo intreccio mafioso-istituzionale – che, carsicamente, ritorna nella vicenda meridionale – si possono considerare: l’arruolamento a Napoli della criminalità nella polizia borbonica da parte del prefetto Liborio Romano; l’entrata di Garibaldi a Napoli col favore della camorra; l’utilizzo da parte della Dc, in funzione anticomunista, di Salvatore Giuliano, autore della strage di Portella della Ginestra; i magistrati “ammazzasentenze” che (non solo in Sicilia) hanno considerato la mafia un valido aiuto per il controllo della delinquenza comune. E la trattativa stato-mafia di cui tanto si parla – aggiungiamo noi – non rappresenta forse, emblematicamente, il momento più inquietante di un sistema collusivo che scrive e riscrive la vicenda storica dell’Italia?
L’amara verità è che per tutto il Novecento e oltre, nel cuore delle istituzioni, è prevalsa l’idea – lo ricorda molto bene l’autore – delle mafie come “crimine d’ordine” necessario al funzionamento dello stato: tema, quest’ultimo, già all’attenzione sia dell’inchiesta di Paolo Ricci sulla camorra alla fine degli anni Cinquanta (La Gran Mamma, 1959), sia dell’indagine di Amato Lamberti risalente agli anni Ottanta.
Di fronte alla gravità di ciò che è avvenuto, la storia dell’Italia, secondo l’autore, andrebbe radicalmente riscritta; e, invece, nella ricerca storica, vi sono poche tracce di quel rapporto tra una politica meridionale corrotta legata alle mafie e la formazione di quella classe dirigente che ha governato per tutto il Novecento il paese. Non meno grave è la sottovalutazione degli economisti, che non hanno compreso come “mafia ed economia sono due fenomeni assolutamente interconnessi”.
Nasce probabilmente da questa lacuna nell’analisi storico-politica, la scelta di Sales di utilizzare nel suo studio fonti diverse: dalla poesia alla letteratura, dal teatro al cinema; fonti che spesso – a partire dal verismo e dal realismo d’autori come Verga, Mastriani, Capuana, Russo, Bracco, Viviani, Sciascia, Eduardo De Filippo – ci permettono di comprendere l’ideologia della mafia, i comportamenti di camorristi, mafiosi e ndranghetisti e il loro intreccio con il potere politico in modo più chiaro di qualsiasi saggio sociologico sull’argomento.
Un aspetto particolarmente interessante di questa “storia delle mafie come storia del potere”, sta nel fatto che l’autore sgombra il campo da qualsiasi lettura “culturalista” del fenomeno criminale; vale a dire da quelle “interpretazioni che scaricano sulla cultura, sui costumi, sulle abitudini delle popolazioni interessate dalla violenza privata la causa del successo delle mafie”. La più ricorrente di queste spiegazioni è quella del sociologo Edward C. Banfield che introdusse – senza mostrare uno straccio di dati scientifici credibili – la cosiddetta teoria del “familismo amorale”, una tesi che attribuiva alla mentalità e all’inestricabile relazione tra struttura familiare nucleare e arretratezza economica del sud lo sviluppo della criminalità mafiosa, scartando qualsiasi ipotesi che queste forme associative violente potessero essere determinate in gran parte dalla miseria e dalla povertà. Con la stessa efficacia, l’autore destruttura lo stereotipo sull’omertà, ancora oggi considerata tipica espressione di una mentalità arretrata o come “ipertrofia dell’io”, e non invece come una scelta razionale di fronte all’inquinamento e alle collusioni di organi nevralgici dello stato come polizia e magistratura.
A questo disvelamento del meccanismo criminale nel sud d’Italia, occorre solo aggiungere che, perlomeno dagli anni Settanta – e molto prima degli assassini di Falcone e Borsellino –, è cresciuto in molte zone del mezzogiorno un movimento che si è battuto contro ogni forma di criminalità organizzata; difficile dimenticare la marcia da Pomigliano a Ottaviano contro la camorra di Raffaele Cutolo – una vera sfida all’egemonia territoriale della Nuova camorra organizzata – che si tenne agli inizi degli anni Ottanta e vide la partecipazione unitaria di migliaia di operai, studenti e disoccupati dell’intero comprensorio vesuviano. Solo che questi movimenti di resistenza sono stati lasciati nel più assoluto isolamento istituzionale.
Con un lavoro oscuro nel sociale, tantissimi giovani cercano oggi di ridare speranze in realtà deindustrializzate e desertificate da governi che, dagli anni Ottanta del Novecento, hanno scelto di aggravare – con metodo scientifico – le condizioni produttive e sociali del meridione; maestri di strada, volontari, associazioni di diverso orientamento religioso e politico, provano a sottrarre spazio alle mafie rifondando comunità in periferie invisibili – dentro e fuori le città – dove sono negati i più elementari diritti di civiltà: dalla scuola ai servizi sociali, dal lavoro alla salute. L’assenza dello stato è tutta qui, non certo nella mancanza di azioni repressive nei confronti delle future leve della criminalità organizzata. E la foucaultiana narrazione di Sales sul potere delle mafie, più che all’ottimismo della volontà, ci induce al pessimismo della ragione. (antonio grieco)





Leave a Reply