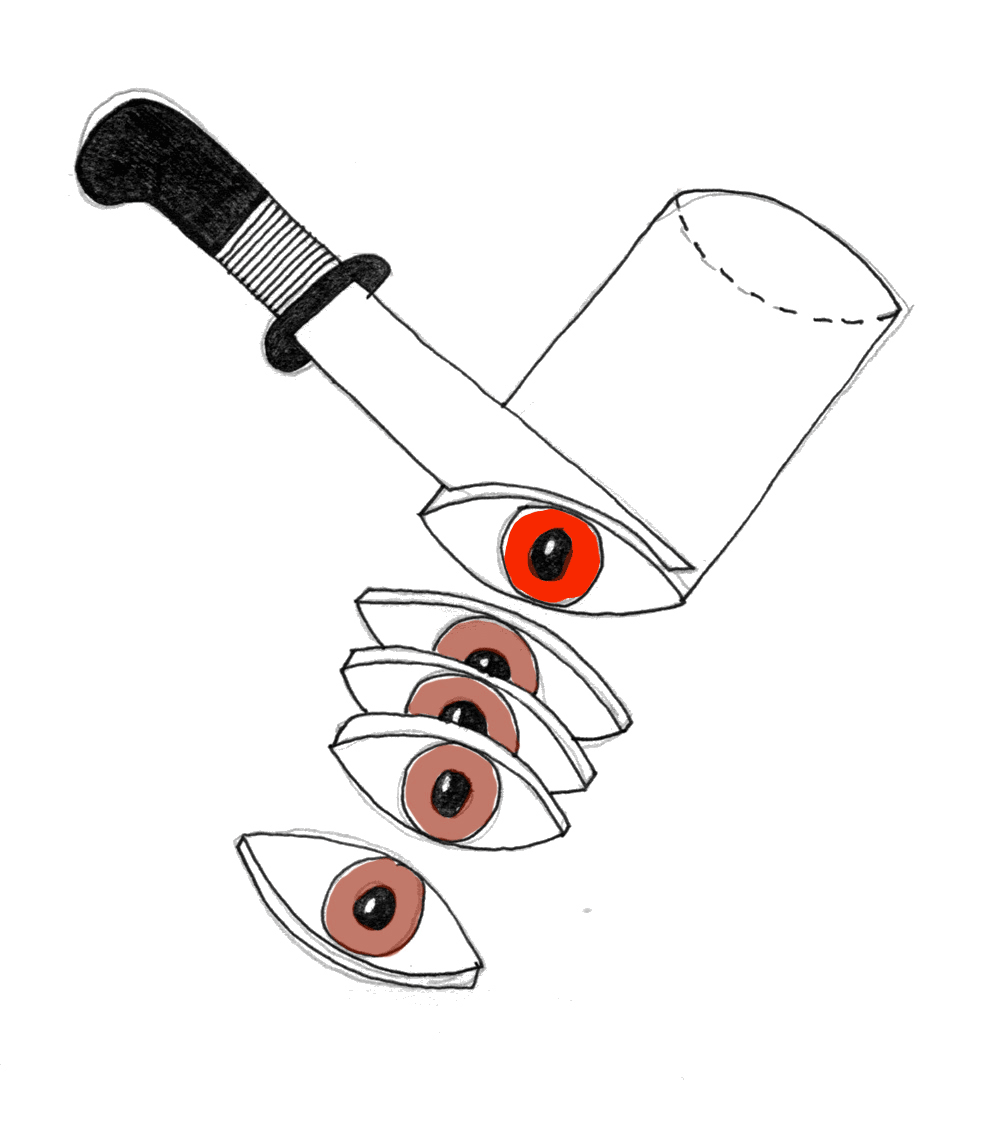
C’è del pianto in queste lacrime di Antonio Latella (andato in scena dal 13 al 18 ottobre al teatro San Ferdinando) è uno spettacolo-saggio che prendendo spunto dalla sceneggiata – senza volerla riesumare né nobilitare ci dicono le note di regìa –, e forse più dal mondo reale che la produceva, prova a ragionare sulla città.
Forse non è un caso che l’autopsia del cadavere della sceneggiata (quasi alla lettera) sia stata fatta al San Ferdinando, che fu il teatro di Eduardo e di quella Napoli che appena risorta dai disastri della guerra fu troppo velocemente “milionaria”. Già lì, a colpi di grande teatro, era iniziato un processo di addomesticazione linguistica che avrebbe scortato il feretro della parlata dura, vivianesca per intenderci, verso il cimitero del dialetto italianizzato. In una ferita aperta pullulano personaggi squallidi e familiari. Urlano, cantano e s’incantano. Sono germi, un virus senza virtù, e non vivono di vita propria bensì di battute e ruoli che una stantia codificazione ormai gli ha cucito addosso.
Lo spettacolo, sia chiaro, è impeccabile dal punto di vista formale. Calibrato a puntino, dalle scenografie ai costumi. Il ritmo è serrato, le canzoni e gli effetti sonori avvolgenti, così avvolgenti da diventare presto rumore di fondo, chiacchiericcio da editorialisti, che si va a sommare alle tante analisi sulla città fatte – il risultato è pressappoco lo stesso – al microscopio o col cannocchiale, ossia ignorando le persone reali che stanno tra la cellula e la galassia.
È vero, il popolo era infetto. E rischiava di contagiare quanti andavano e vanno professando civiltà. Certi valori che di generazione in generazione da secoli sopravvivevano non potevano resistere all’antibiotico televisivo che poi, se da un lato allunga la vita, dall’altra la rende più insipida.
Un punto tra molti è: cosa abbiamo prodotto noi che ci siamo vergognati de ‘O zappatore o Lacrime Napulitane, dopo aver giustamente rinnegato – per camminare sulle nostre gambe – quel tipo di cultura che ci sommergeva sino al collo?
Questo per dire che sì, i padri (o le madri) andavano ammazzati, ma ragionando sul “poi” nel momento stesso che il braccio, armato di coltello, si calamitava nel molle ventre materno (o paterno). Ucciderli sì, ma per cibarcene. Permettendo all’intestino di selezionare cosa trattenere in termini di energia e cosa espellere in solidi stronzi. Allora, di questa lingua tosta e violenta che ne vogliamo fare? C’era e c’è ancora da ingentilirla per renderla intelligibile extra moenia? O lasciarla viaggiare verso il suono puro, l’informazione tonale? Perché servirsene (male) teatralmente se poi se ne disprezza intimamente la radice di provenienza?
È vero, l’eredità che, vuoi o non vuoi, ciascun napoletano si porta sulle spalle è il più delle volte un macigno difficile da gestire. Il semplice fatto di liberarsene, non garantisce la leggerezza sperata. Come dire che hai voglia a buttar giù zavorra, niente, il pallone gonfiato che siamo stenta a decollare. Migliaia di canzoni, biblioteche di proverbi e modi di dire, trasmissione oral-secolare su binari paralleli del più cieco familismo da un lato e di un individualismo culo e camicia con la cattiveria più pura dall’altro. Tutto un sistema di valori, per quanto discutibile, che quando è venuto a mancare (maciullato dall’alfabetizzazione di massa) s’è portato con sé anche quelle forme espressive che aveva partorito (innestato dice Latella, come se fosse l’unico Frankestein dello spettacolo che coi colpi bassi del sentimento arraffa più pubblico possibile). Intanto c’è da dire che la sceneggiata è stato l’ultimo genere che ha riempito i teatri di quel proletariato marginale e marginalizzato che il resto della città, se solo fosse più sincero con se stesso, non esiterebbe a diagnosticare come cancro, più che da curare da estirpare, senza voler vedere che si appartiene tutti allo stesso corpo malato e che da solo non si salva nessuno.
Fino a metà degli anni Settanta la sceneggiata è stata – con al centro la canzone – schemi, serialità, riconoscibilità dei personaggi, e il semplice ma non scontato fatto di portare il vicolo e le sue dinamiche sulle assi del palcoscenico, faceva sì che un pubblico numerosissimo (che in tutto questo si riconosceva e si specchiava) affollasse le anche tre rappresentazioni al giorno che, per esempio, si facevano al teatro Duemila (a due passi dal San Ferdinando). Oggi, è bene ricordarlo, quel teatro (come tanti altri) è un supermercato. Questo tipo di metamorfosi dei luoghi narra in contemporanea anche quella trasformazione antropologica di cui si è parlato molto in passato. Quello stesso popolo che affollava le sale delle sceneggiate, tenuto privo di difese culturali, è stato ridotto in poche generazioni a folla di consumatori (frustrato dall’essere senza reddito per di più); e illuso che anche i bassi potessero essere “un posto al sole”.
Senza possibilità di essere attori del consumo, una parte della città s’è chiusa sempre più in se stessa, fino ad arrivare alla deriva degli ultimi mesi che vede protagonisti di una diffusa guerra urbana ragazzini che non hanno quasi mai più di venti anni. Quindi è vero, si doveva cambiare direzione, ma per andare dove?
Lo spettacolo di Latella mette bene a fuoco un decalogo di modididire-comandamenti che sono stati l’informazione non genetica principale tra un mondo in via d’estinzione (per quanto non privo di persistenze) e la città contemporanea, che si vorrebbe più laica e che tra ragione e sentimento si è schierata con la prima, di facciata. Tant’è che – cosa curiosa ma neanche troppo – il pubblico dello Stabile, nonostante gli venga mostrato per circa due ore e mezza tutto lo schifo che una classe sociale (resa dai costumi insetto da schiacciare) ha saputo produrre: dallo strozzinaggio all’omicidio, dalle molestie sessuali domestiche alla violenza verbale quotidiana e gratuita, il pubblico dicevamo, si comporta ancora esattamente come il vecchio pubblico della sceneggiata, applaudendo a scena aperta le canzoni più emozionanti e ben interpretate, ghignando cinicamente a quelle più palesemente derise.
Se si pensa che negli anni passati i pochi borghesi che frequentavano la sceneggiata ci andavano soprattutto per godere, come a un safari, della reazione della platea, bisogna osservare che è cambiato veramente poco, e che il pubblico d’oggi, più benestante ma addomesticato come quello d’un tempo, va a teatro per specchiarsi compiacendosi, mai per riflettere trasformandosi. E in questo Latella ci sembra si accodi a tutti quelli che danno al pubblico – magari travestito da innovazione – ciò che silenziosamente quest’ultimo esige. (cyop&kaf)


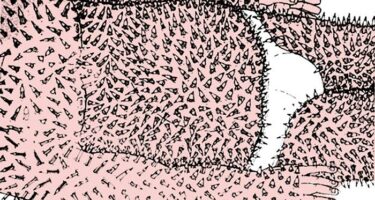


Leave a Reply