
All’aldilà di qua è un film scritto da Alessandra Cianelli e da lei diretto insieme a Opher Thomson. Il film è stato di recente presentato al Torino Film Festival e dall’8 dicembre è visibile sul sito del simposio Recursive Colonialism.
Scrivo da persona coinvolta, per parlare di un film che mi sta a cuore, figlio di una ricerca che nasce dal tentativo di ricostruire una memoria privata e finisce per rivelare l’“inconscio coloniale” che segna il nostro modo di vedere, agire e sentire. All’aldilà di qua, è stato scritto dall’artista, esploratrice e ricercatrice Alessandra Cianelli e co-diretto insieme all’amico, artista e regista Opher Thomson. La memoria in questione è quella del vissuto familiare dell’autrice, una memoria interrotta che si intreccia alla storia obliata del colonialismo italiano. Al centro del film, di fatto, c’è l’opera di rimozione storica che negli ultimi settant’anni ha congelato il colonialismo all’interno di una bolla inviolabile. L’occultamento di quella violenza sistematica – praticato nel secondo dopoguerra dalle istituzioni, dai partiti politici e dalla stampa ufficiale – non ha fatto altro che avvalorare l’azione di auto-legittimazione intrapresa dai “civilizzatori” di fine Ottocento e proseguita fino agli anni Quaranta del Novecento. Brutali quanto l’azione coloniale stessa, queste omissioni hanno prodotto un buco nero che continua a sottrarre materia prima alle memorie individuali e, soprattutto, alla coscienza collettiva di questo paese. Tra cronaca e ricordi d’infanzia, All’aldilà di qua affonda le mani e lo sguardo in questa voragine, si chiede quali sono gli effetti del rimosso e prova a reagire alla “smemoratezza” ormai cronicizzata.
«Mamma, ma tu ce l’hai un padre?». «Nonna, ma tu ce l’hai un marito?». A stimolare queste domande è la storia oscurata di Saverio Rossi, il nonno materno di Alessandra, che insieme a molti altri corpi, oggetti e storie è sparito nel vuoto cosmico dell’amnesia coloniale dopo essersi imbarcato per la Cirenaica come soldato della fanteria reale. Partito dall’Irpinia nel giugno del 1940, il sig. Rossi salì quasi certamente su una delle tante navi che salpavano dal porto di Napoli per raggiungere le “terre italiane d’oltremare”. Dalla “quarta sponda del Mediterraneo” riuscì a spedire poche lettere e cartoline con le quali informava la famiglia delle condizioni di vita in colonia e del suo stato d’animo mentre viveva quell’esperienza, suo malgrado. Oltre a questi documenti, non esistono tracce che spieghino le ragioni, i tempi o i modi della sua sparizione. Attorno al dolore causato da questa perdita, nel corso degli anni, si è cementificato un vuoto, un vortice agitato da un silenzio tanto ingombrante da diventare insostenibile. Il film, o meglio, il processo di scavo, relazione, scoperta sentimentale e consapevolezza che ha portato alla sua realizzazione non risolve il mistero del “nonno scomparso”, ma rompe il silenzio emotivo che lo aveva reso innominabile. Simultaneamente, All’Aldilà di qua interrompe un tabù nazionale a partire dalle parole che lo nascondono: «Libia, Tripolitania, Bengasi, Cirenaica». «È successo un Ambaradàn». «Che fine ha fatto la Regina Taitù?». «Qual è la lingua di Menelik?».
«Ci sono domande che non si possono fare» – una delle asserzioni che incontriamo nel film – è la verità più vera che si può acquisire quando si entra a contatto con certi archivi del passato coloniale. Insieme ad Alessandra, ho incontrato questa verità quando, grazie a lei, venni a contatto con l’archivio della Mostra d’Oltremare di Napoli, tra le più imponenti testimonianze materiali dell’ambizione coloniale-imperiale di Mussolini. Il complesso espositivo nacque come progetto di Mostra Triennale delle Terre Italiane d’Oltremare e fu per il duce il modo migliore per celebrare il neonato Impero d’Etiopia e provare a fare di Napoli il punto di congiunzione ideale tra le colonie in Africa e Roma, cuore dell’Impero a cui si era sempre ispirato. La sua costruzione comportò lo sventramento di una vasta area del quartiere Fuorigrotta, impegnò enormi risorse fisiche, economiche e intellettuali, sfruttò ogni mezzo e strumento a disposizione. L’arte, le tecnologie audiovisive e gli allestimenti ebbero un ruolo cruciale nella costruzione della differenza tra “noi” autori della “millenaria opera di civiltà” e “loro” bisognosi del nostro intervento.
Un frammento dell’archivio Luce riportato nel film documenta l’entusiasmo che accolse la sua inaugurazione e la solennità di quell’evento, partecipato e promosso dalle massime cariche e autorità statali. La Mostra venne aperta al pubblico il 9 maggio del 1940, poco prima che l’Italia fosse attaccata dalle prime bombe della seconda guerra mondiale e che Severino Rossi lasciasse la penisola. Mentre lui veniva esportato in quell’“altrove selvaggio”, circa sessanta persone venivano importate dalle colonie perché animassero lo “zoo umano” della Triennale mostrando agli italiani la propria “tipicità” e “arretratezza”. Insieme a loro, il regime fece importare migliaia di specie vegetali da trapiantare (palme, tamarindi, papiri), animali da esibire (fenicotteri, scimmie, leoni, elefanti) e qualsiasi oggetto fosse utile a simulare l’ambiente naturale in cui vivevano i “nuovi sudditi”. Il progetto iniziale prevedeva che la Mostra rimanesse aperta al pubblico fino al 15 ottobre del 1940, ma il 10 giugno, quando Mussolini decise di entrare in guerra al fianco della Germania, l’impianto venne chiuso bruscamente e finì per diventare una sorta di prigione in cui rinchiudere i corpi precedentemente importati, in attesa di rimpatrio. Di questi corpi assoggettati e abbandonati non si è saputo niente fino a tempi molto recenti (vedi Partigiani d’Oltremare di Matteo Petracci, 2019).
Molte scene del film, accompagnate da brani musicali storici e recenti, suoni ambientali e documenti audio di repertorio, ci portano dentro il complesso espositivo, tra i suoi archivi vegetali, animali, architettonici; tra le rovine della storia. Le immagini delle sue strutture così come si trovano oggi si sovrappongono continuamente a quelle d’archivio in un flusso non lineare che evoca il ritorno ciclico degli eventi, il passato che non passa. Nel film, la Mostra è “la città perduta del desiderio oltremarino”, il luogo fisico in cui si materializza il “sogno fanta-esotico” degli italiani avanguardisti-futuristi. Ma è soprattutto uno spazio simbolico, l’emblema del potere bianco, occidentale e imperiale, nonché la prova tangibile di quanto gli italiani facciano ancora oggi fatica a liberare la propria storia da fascismo e colonialismo.
Pesantemente danneggiato dai bombardamenti bellici, che ne rasero al suolo intere porzioni, il complesso espositivo venne riaperto al pubblico nel 1952, quando divenne Ente Autonomo e fu ribattezzato come “Mostra d’oltremare del lavoro italiano nel mondo”. Da quel momento, le proposte dell’Ente si susseguirono lungo direttrici totalmente acritiche nei confronti della storia che aveva portato alla sua costruzione. Persino la mostra dedicata alla storia della Triennale del 1940, allestita nel 1996, si allineò a questa scelta. Nel corso dei decenni, la Mostra venne aperta e chiusa più volte per ragioni economiche e politiche. Ad aggravare la sua condizione già precaria fu poi il terremoto del 1980, che rese inagibili moltissimi edifici. Così, fatta eccezione per alcuni eventi sporadici, i suoi cancelli rimasero chiusi al pubblico per oltre trent’anni, per essere ufficialmente riaperti il 10 maggio 2014. Per l’occasione, l’Ente mise a disposizione sessantadue ettari di spazi e un bando pubblico (“Isola delle passioni”) rivolto alle associazioni e alle aziende del territorio affinché si incentivasse il rilancio della storica Fiera Monumentale.
Il 2014 è anche l’anno in cui, insieme ad Alessandra e con la complicità di Iain Chambers (e del Centro studi postcoloniali e di genere dell’Università L’Orientale di Napoli), riuscimmo a stipulare una convenzione che ci permetteva di accedere all’archivio della Mostra, che nel frattempo era diventata una S.p.A. e aveva redatto il suo nuovo statuto. Il nostro rapporto diretto con gli amministratori e i materiali conservati rendeva concreta l’opera di rimozione di cui parlano gli studi storici – tra gli altri, quelli di Del Boca, La Banca, Rochat, Triulzi – che dagli anni Settanta hanno messo in discussione “il colonialismo dal volto buono”. Le criticità segnalate da questi studi divennero un argomento che potevamo toccare con le nostre mani, mentre rovistavamo tra scatole e scaffali pieni di materiali poco organizzati e in parte ancora non catalogati e mentre constatavamo questa stessa incuria.
Se la dispersione di una gran parte dei documenti trovava la sua giustificazione nei bombardamenti, nel terremoto e nei saccheggi che la struttura aveva subito nel corso dei decenni, meno comprensibile risultava invece lo scarso interesse a ricostruire quel passato problematico. A rendere sospetta questa trascuratezza era l’imbarazzo provocato dalle nostre richieste, una sorta di disagio che sembrava celare un misto di senso di colpa e ignavia. Quando chiedevo di potermi spingere un po’ oltre la superficie del visibile, avevo la sensazione di essere percepita come una presenza scomoda e inopportuna. Capivo che c’erano domande che non si potevano fare, che c’era un limite che non si poteva oltrepassare.
In quel periodo, in effetti, di pari passo con l’“aziendalizzazione” dell’ente, il nuovo carattere della Mostra si stava definendo attorno a delle necessità squisitamente imprenditoriali e commerciali. L’interesse era tutto rivolto a valorizzare e sfruttare quel patrimonio potenzialmente molto produttivo, farlo diventare un’attrattiva turistica per napoletani e stranieri. Così, mentre i suoi spazi diventavano sede di attività come la piscina, la palestra, il ristorante, l’hotel, nessuno degli eventi culturali ospitati all’interno dei padiglioni ristrutturati osava proporre argomenti critici. Probabilmente, portare sotto i riflettori l’arroganza e la prepotenza che aveva dato vita a quel progetto ne avrebbe appesantito l’immagine e contraddetto la bellezza.
Ancora oggi visitando il complesso possiamo notare l’assenza di qualsiasi cenno alle origini storiche di quel mastodontico esercizio di potere. Al piano terra del Teatro Mediterraneo, divenuto sede degli uffici e spazio per convegni e spettacoli, troviamo un plastico che ricostruisce la struttura originaria, in cui è visibile l’area dedicata all’Africa Orientale Italiana, con il Castello di Gondar immerso nel laghetto di Fasilides, il Cubo d’Oro, la Chiesa copta, il Padiglione della Libia, quello della Somalia, il Caffè arabo. Attorno al plastico, alcuni pannelli didascalici sintetizzano le varie tappe della ricostruzione. Queste descrizioni riguardano gli aspetti architettonici, urbanistici, paesaggistici, ma in nessun modo ricordano le intenzioni, le ambizioni e il ruolo che la Mostra assunse nella costruzione dell’“italianità” e nella invenzione razzializzante dell’“altro”.
Se non possiamo raggiungere la Mostra fisicamente, una visita al suo sito web può essere ugualmente rivelatrice. La pagina dedicata alla Storia ci dice che “la Mostra d’Oltremare […] era ed è un grande parco protetto e sicuro, unico nel suo genere. […] Rappresenta uno dei maggiori esempi di architettura razionalista italiana”. Una sintesi estrema e sconcertante che, ai miei occhi, non può che apparire come la riproduzione di una precisa volontà politica, tutta tesa a occultare un passato evidentemente imbarazzante. Se navighiamo tra le pagine che descrivono i singoli edifici e padiglioni notiamo anche che nella maggior parte dei casi i loro nomi originari sono stati “neutralizzati” e sostituiti da numeri (Padiglione 1, 2, 3, ecc.). È grazie a queste rimozioni se molte persone vedono la Mostra semplicemente come un “parco dei divertimenti”. Ed è nell’approccio acritico che le istituzioni e gli studiosi di varie discipline continuano ad adottare nei confronti del colonialismo che si manifesta l’inconscio coloniale italiano.


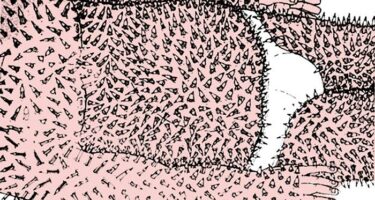


Leave a Reply