
«Europe!».
L’urlo spezza il silenzio. Risate, applausi, gridolini di gioia riempiono la stanza.
Davanti a noi, sul monitor di un piccolo computer portatile, compare una foto di Francesco Malavolta, fotoreporter che dagli anni Novanta documenta i flussi migratori. In quella foto c’è un piccolo gommone che sembra un puntino al centro di un mare enorme e piatto. A bordo un uomo allarga le braccia e sorride: «Europe!». Sembra il grido del marinaio che urla: «Terra!».
Chi lo sa se hanno urlato così quando anche loro erano a bordo di un gommone come quello della foto. Europe, come una speranza che non è morta.
L’entusiasmo iniziale lascia ben presto il posto al ricordo. Emergono frammenti di quello che è stato il loro viaggio. Sono schegge di orrore. Per quell’orrore, una di loro era svenuta e non ricorda il momento in cui ha visto per la prima volta l’Europa. Un’altra ha pregato Dio di farla morire. Ad altre gli occhi si riempiono di lacrime. Ma tutte, alla mia domanda: «Cosa avete provato quando avete visto che eravate arrivate in Europa?», sorridono e rispondono: «Speranza». «Una nuova vita che inizia». Ma chi sono loro? Per privacy scriverò puntati i loro nomi e quindi ve le presento come A., B., J. ed M.
FUORI TRATTA
Sono quattro ragazze africane. Due vengono dalla Nigeria e due dalla Costa d’Avorio. Sono quattro delle tante donne migranti che vivono in Campania, destinatarie di un progetto contro la tratta finanziato dal Dipartimento per le pari opportunità della presidenza del consiglio, gestito da enti e associazioni sparse sul territorio regionale. Si tratta di un progetto rivolto a migranti vittime di sfruttamento sessuale o lavorativo.
Secondo l’Associazione Italiana Migrazioni soltanto nel 2016 sono entrate in Italia circa diecimila ragazze nigeriane come forza-lavoro per il mercato della prostituzione. Spesso buttate in strada per ripagare il debito che hanno contratto con i trafficanti. C’è poi la maledizione del juju, che spesso incombe sulle loro teste e da cui liberarsi sembra quasi impossibile. In parole povere, si tratta di una sorta di rito voodoo, con una maledizione formulata dal “doctor”, uno sciamano che obbliga le ragazze a non ribellarsi alla madame, la protettrice delle prostitute. Impazzire, non dormire mai più, qualcosa di brutto che accade ai familiari rimasti in Nigeria, sono alcune delle conseguenze a cui va incontro chi si ribella. Nel 2018 però qualcosa cambia. In Nigeria, a Benin City, nell’Edo State, l’Oba Ewuare II, cioè la massima autorità del popolo Edo, convoca tutti gli sciamani del juju, obbligandoli a interrompere questa pratica. Un evento di rilevanza non trascurabile, che può cambiare per sempre la vita di moltissime donne nigeriane.
Ma non è solo a chi incontra la strada della prostituzione che si rivolge il progetto. Ci sono migranti vittime di sfruttamento lavorativo, accattonaggio forzato, caporalato. Tra gli i partner del progetto c’è la Caritas di Benevento ed è tramite loro che ho conosciuto le quattro ragazze protagoniste di questo racconto.
Quello delle foto in origine doveva essere un laboratorio di “photovoice”, ma poi è diventato uno spazio settimanale in cui guardare insieme le foto di alcuni grandi autori e avviare una discussione. In pratica, la foto diventa uno stimolo per parlare di ciò di cui abitualmente non si parla. Così una foto di nudo di Ren Hang diventa lo spunto per una discussione sul proprio corpo, tra chi disapprova il mostrarsi nuda, sottolineando il significato religioso che per lei ha il suo corpo, casa di Dio, e chi rivendica la sua libertà di scelta, di essere in tanti modi diversi: triste, arrabbiata, felice, stanca e anche “sexy”. Guardando le foto scopro i nostri gusti diversi: loro odiano il bianco e nero, amano quelle con i colori vivi e accesi che per me risultano a tratti fastidiose. Vogliono il colore. E lo si capisce anche dai capelli. Nonostante il dread e la rasatura, i miei capelli sono banali e tristi in confronto alle loro treccine coloratissime, alle loro acconciature ogni settimana diverse al punto da farle sembrare ogni volta un’altra persona. Davanti alla ragazza dagli occhi verdi di Steve McCurry, una di loro dice: «Questa ragazza ha gli occhi tristi, le avranno fatto del male, l’avranno obbligata a fare cose che non voleva. Mi ricorda il mio passato». Il passato è il grande tabù.
Spesso le narrazioni sui migranti assumono il viaggio come punto zero del racconto. Come se la vita di un migrante iniziasse dal momento in cui mette piede in Europa. Non è così e sarebbe giusto restituire a ognuna di queste persone la propria identità individuale, un’identità che è fatta anche del passato. Sarebbe un’azione necessaria, da opporre a chi invece vorrebbe ridurre l’identità a un numero, uno dei tanti numeri di quella che si continua a chiamare “emergenza migranti”. Eppure il passato sembra a tratti innominabile.
Una di loro ha lasciato un figlio al paese d’origine. Le altre hanno lasciato cose poco piacevoli da ricordare. Il passato irrompe, però, come una piccola crepa nella corazza del presente, quando J. se ne sta in disparte e quando le chiedo cosa sia successo risponde: «Oggi è il compleanno di mio figlio», oppure quando si avvicina il Natale e tra decorazioni e lucine sento dire: «A Natale tutti escono insieme, è il periodo dell’anno in cui sento di più la mancanza della mia famiglia». Il passato irrompe in quel presente che adesso è qui, tra crocifissi e pasta, che, scopro, a loro non piace per niente. Preferiscono i noodles, che cucinano quasi tutti i giorni.
Tra i vari passaggi del progetto è previsto il trasferimento in una struttura protetta, per cui loro adesso vivono qui, tutte insieme. Attaccato al frigo c’è un foglio con i turni delle pulizie, dal palazzo di fronte arriva la voce di un neomelodico. Due di loro guardano dal telefonino una telenovela nigeriana. Il loro presente è qui. A. organizza un baby shower per la figlia che tra poco nascerà. La festa diventa poi una festa anche per il compleanno di B., che a un certo punto prende la parola per ringraziare i presenti e dice: «Io non ho una famiglia, ma qui ho trovato la mia famiglia».
OLD WHITE MEN
Qui possono anche pensare al futuro. «Io voglio avere un cagnolino come i tuoi – mi dice M. – e poi prego Dio di farmi trovare un marito e fare una famiglia». «A me piace cucinare, vorrei fare soldi cucinando», sono i loro desideri. Per qualcuna il futuro è rappresentato dalla scuola. Accompagno M. al suo primo giorno di scuola al Centro provinciale per l’istruzione degli adulti. È emozionata, quando ha saputo che erano riusciti a iscriverla a scuola ha iniziato a pregare e ringraziare Dio. Siamo arrivate in aula quasi un’ora prima del previsto. «È presto. Andiamo a fare una passeggiata, a prendere un caffè?». Fa no con la testa. Sta lì, seduta nel suo banco, con la penna e il quaderno. E aspetta. Poteva scegliere se frequentare le lezioni di mattina o di pomeriggio. Ha scelto sia mattina che pomeriggio. Insieme a M. inizieranno ad andare a scuola anche B. e J. In tasca l’abbonamento dell’autobus e sveglia presto la mattina. B. resta affascinata dal modo di parlare della professoressa. J. si sfoga «È difficile. A scuola sembra che capisco, poi sento le persone fuori parlare e non capisco più niente». Il progetto, oltre all’iscrizione a scuola, prevede una serie di tirocini retribuiti.
Il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, andiamo insieme a vedere “Com’eri vestita?”, mostra organizzata dall’associazione Exit Strategy per sensibilizzare sul tema degli stereotipi che piovono addosso a una donna che subisce molestie. Le ragazze girano per la mostra, si scattano selfie. Ci troviamo davanti a un quadro. Raffigura una donna africana che gira su una spiaggia per fare treccine alle turiste. B. guarda il quadro e dice: «Un uomo può venire e dirti: ti do più soldi di quanti ne guadagnerai facendo tutta la giornata treccine, fai sesso con me». Una volta avevo chiesto a B. cosa non le piacesse di questa città. Mi ha risposto: «Old white men». I vecchi uomini bianchi, il modo in cui la guardano solo perché è una donna nera.
Tornando dalla mostra assistiamo a un episodio di violenza. Per strada un uomo mette spalle al muro una donna, prova a baciarla. Lei si sposta e riesce a mandarlo via. Le chiediamo se va tutto bene e lei dice di sì e se ne va. Davanti a questa scena B. si arrabbia, vorrebbe prendere la sua stampella e darla in testa a quell’uomo. Nei giorni successivi questo episodio, insieme a quello che abbiamo visto alla mostra, ci fornisce lo spunto per avviare una discussione sulla violenza di genere. B. non si aspettava che in Italia fossero state uccise solo nell’ultimo anno quasi cento donne. È una rivelazione che la lascia a bocca aperta. Quando chiedo se c’è un modo per una donna per liberarsi di questo, mi rispondono: «Il lavoro, se lavori sei una donna libera e puoi separarti dall’uomo violento». Lo vogliono, il lavoro, più di ogni altra cosa perché lavoro è uguale a futuro.
A. il futuro lo vede negli occhi di sua figlia, nei suoi capelli nerissimi. Nata a Benevento da madre nigeriana, senza la legge sullo ius soli dovrà aspettare diciott’anni per essere cittadina italiana. Pugni chiusi e una tutina rosa. Sulla bavetta porta scritto: “Senza donne non c’è rivoluzione”. (giulia tesauro)


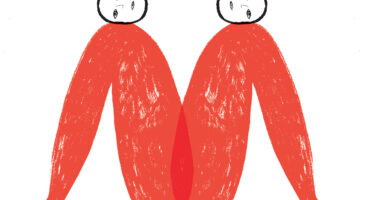


Leave a Reply