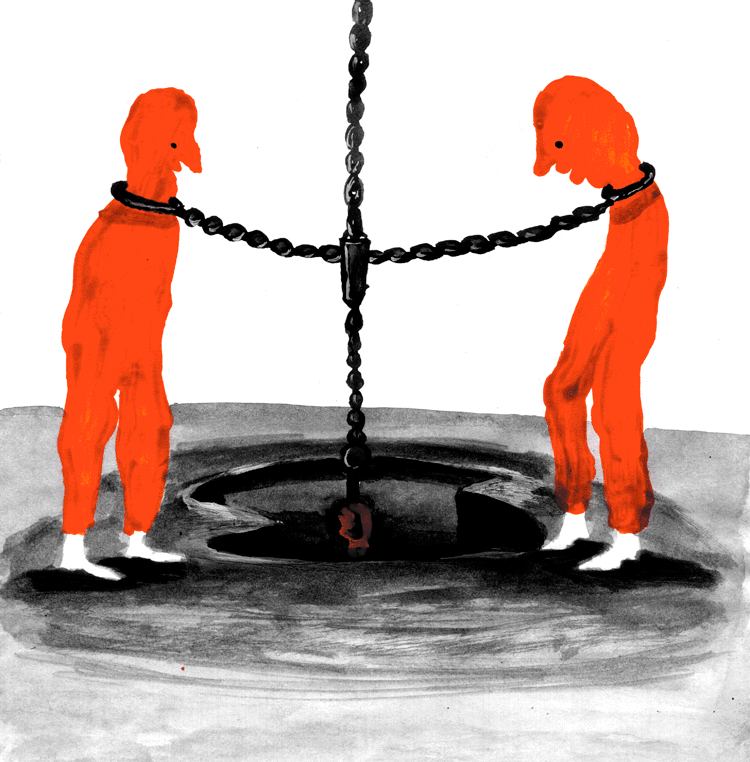
L’ultimo grande processo politico nello stato spagnolo è durato quasi diciotto mesi, è iniziato nel novembre 2005 e si è concluso con condanne a 525 anni di carcere comminate dall’Audiencia Nacional, il Tribunale Speciale, a quarantasette persone. Sul banco degli imputati sedeva la sinistra indipendentista basca – politica e sociale –, a essere condannata è stata la lotta politica per l’indipendenza. Eppure, né nelle accuse mosse dai tribunali né nei fatti considerati si parlava di esplosivi o di autobombe e detonatori. Si parlava invece di movimento popolare, di giornali e riviste, di associazioni e fondazioni. Si parlava perfino, paradossi bellici del giudice Baltasar Garzón, di disobbedienza civile non violenta al servizio dell’ETA.
Contribuiva all’epoca dei fatti la criminalizzazione collettiva sotto lo slogan “è-tutto-ETA”. Alla fine, la sentenza ha ratificato quella tesi. L’offensiva giudiziaria si è tradotta in oltre 239 anni di carcere inflitti a trentotto persone – la Corte Suprema ha ridotto qualche pena – e nell’apartheid elettorale senza il quale il socialista Patxi López non avrebbe mai vinto le elezioni. Va ricordato, infatti, che quando la sinistra basca illegalizzata è potuta tornare alle urne, ha raccolto il venticinque per cento dei voti nelle municipali del 2011, divenendo la prima forza politica basca per numero di consiglieri comunali.
Da quel processo, dalla macroistruttoria 18/98, sono passati appena dieci anni. Ne sono passati ancora meno se consideriamo che l’ultimo detenuto di quel processo ha recuperato la libertà l’anno scorso, il 4 gennaio 2018, dopo undici anni di carcere. In altre parole, appena un anno fa, dopo una repressione di lunga durata e organizzata come vendetta. Non importa se l’artefice di “è-tutto-ETA” (il giudice Garzón) ha finito col prendere le distanze dalla sua invenzione: gli effetti espansivi non si sono mai fermati. Da allora, e in seguito alla deriva contro diritti e libertà che tanto è costato conquistare e così poco smantellare, vi sono state molte altre cause politiche repressive: da Núria Pòrtulas agli undici del Raval, dagli indignati del Parlamento all’Operazione Pandora, dai giovani di Altsasu a Adri e Tamara Carrasco.
Se insisto a frugare nella memoria per recuperare le battute cupe di quel processo politico d’eccezione, amalgama grigio di zelante maccartismo e inquisizione spagnola, non è tanto – si notino le similitudini e le differenze con questo 2019 in cui si processano le urne del Primo Ottobre catalano– per com’è andata (ed è andata nel modo peggiore), quanto piuttosto per com’è finita. Di come si è sviluppato – kafkianamente – ci resta l’antologia di indecenze raccolta da Vilaweb, uno dei pochi giornali ad averlo seguito; la schiacciante e categorica testimonianza degli osservatori internazionali (”credevamo di assistere a un processo senza prove e ci siamo trovati davanti a un processo senza reato”) o il disprezzo nei confronti della Corte europea dei diritti dell’uomo ribadito ad alta voce dal magistrato Angela Murillo durante le deposizioni: “Quanto può dire la Corte di Strasburgo, a questa Corte non interessa”. Solo gli accusati di disobbedienza civile sono stati assolti dalla Corte Suprema, per l’esattezza nove anni dopo il loro arresto. Confermando così che era il processo, il castigo: la condanna era stata di nove anni e nove anni hanno dovuto aspettare. L’assoluzione della Corte Suprema sosteneva nel 2009: “La disobbedienza civile può essere concepita come un metodo legittimo di dissidenza nei confronti dello Stato, dovendo essere ammessa tale forma di pensiero e ideologia nel seno di una società democratica”.
Di quel processo, August Gil Matamala ha detto con lungimiranza: “Prima si sono inventati la figura del terrorista disarmato e ben presto s’inventeranno la figura del terrorista pacifico”. Eccoli: Jordi Cuixart, Jordi Sánchez. Tuttavia, per capire com’è finita, si consiglia vivamente di analizzare con attenzione l’altra sentenza, quella nata dalla resistenza nelle piazze. In quell’intricata stagione basca, l’esperienza solidale della Piattaforma 18/98 è riuscita a radunare la maggioranza sociale basca contro quel folle processo che minava i diritti civili e politici. E il 20 dicembre 2007, il comunicato stampa in cui si valutavano le pesanti condanne imposte dall’Audiencia Nacional è diventato un brutale e lucido esercizio di riflessione condotto dal giornalista Mariano Ferrer. Vale la pena di rileggerlo per intero – insegnamenti e autodifese di ieri per oggi e per domani – in vista del processo imminente che punta, ancor prima di cominciare, a un castigo esemplare in grado di paralizzare, bloccare e durare nel tempo.
Davanti alla sinistra ragion di stato che schiaccia ogni ragione, la voce libera di Mariano Ferrer si alza ancora, tra lucidità e impotenza, e ci sussurra: “Costruzione giuridica di uno stato d’eccezione non dichiarato”. “Agli imputati hanno inflitto, a mo’ di castigo previo alla sentenza, un vero e proprio calvario”. “Avevamo tre ragioni di peso per essere solidali: la prima è che si trattava di una causa giusta in quanto a queste persone non doveva essere applicata la legislazione antiterrorismo, poiché l’attività per cui sono stati incriminati doveva essere intesa come esercizio legittimo dei loro diritti civili e politici e, inoltre, anche qualora dovessero essere processati, avrebbero dovuto farlo con le garanzie che spettano ai cittadini di uno stato di diritto; la seconda è che, difendendoli difendevamo noi stessi e tutta la società in quanto società democratica; e la terza è che eravamo consapevoli di unirci a una causa giusta e globale, che cercava di proteggere l’eredità dell’Illuminismo e dei Diritti dell’uomo dagli attacchi sferrati a partire dall’11 settembre 2001”.
Mariano Ferrer aggiungeva molto di più, fornendoci un quadro completo: “Si capiva che il giudice non aveva bisogno di dimostrare l’accusa, erano gli imputati a dover dimostrare la loro innocenza”. “Il Diritto non è l’esercizio della Giustizia ma del potere che lo redige”. Inseriva domande a tutt’oggi senza risposta: “Quanto tempo e quanti sforzi ci vorranno per ricostruire la ragione democratica?”. E citava Thomas Paine: “Chi vuol essere sicuro della propria libertà deve proteggere anche il proprio nemico dall’oppressione, perché venendo meno a questo dovere stabilisce un precedente che varrà anche per sé”.
Trapelava anche il rischio dell’impotenza. “La sentenza colloca la Piattaforma 18/98 di fronte ai propri limiti: siamo grati della risposta ricevuta. Dimostra che molti hanno capito che non era un problema d’altri, che era anche il loro problema. […] Noi riconosciamo il nostro limite: la nostra denuncia solidale è stata insufficiente a frenare quest’offensiva”.
E chiudeva così: “Non illudiamoci, il problema di fondo che emerge da questo sproposito giudiziario non si risolve nei tribunali; siamo di fronte a un problema politico la cui soluzione dev’essere politica. […] Con questa sentenza si ridefiniscono i limiti della libertà. La libertà dei condannati, ovvio, ma non solo. D’altra parte, non è soltanto il tribunale a definire tali limiti: la nostra risposta di fronte all’arbitrarietà è determinante. La giustizia arbitraria che ha prodotto questa sentenza non è infatti solo cattiva in sé, ma per essere efficace richiede la nostra complicità, poiché questa giustizia perversa ci esorta a condividerne il ruolo inquisitore, esorta ognuno di noi a redigere la propria lista di giusti e peccatori. Se accettiamo che la domanda che salva l’imputato dall’essere condannato non sia ‘che cosa ha fatto?’, ma ‘che cosa pensa?’ e ‘chi è?’, ci trasformeremo a nostra volta in inquisitori volontari dell’Audiencia Nacional. Diverremo complici di una caccia alle streghe in cui ciò che è umano ci sarà estraneo”.
Da quel comunicato stampa sono passati undici anni lo scorso dicembre. Sembra scritto ieri, sembra scritto oggi, sembra scritto domani. Ma tra le righe di quella riflessione, tra il sale e la ferita, Mariano Ferrer aggiungeva anche: “Facciamo nostra questa frase, usata in un altro contesto ma valida anche in questo: anche se ci rompono gli strumenti, la musica deve continuare”. E, bisogna proseguire: per non dover mai dire di non aver fatto tutto il possibile per evitarlo. (david fernàndez – higiniaroig, traduzione di ursula bedogni)



Leave a Reply