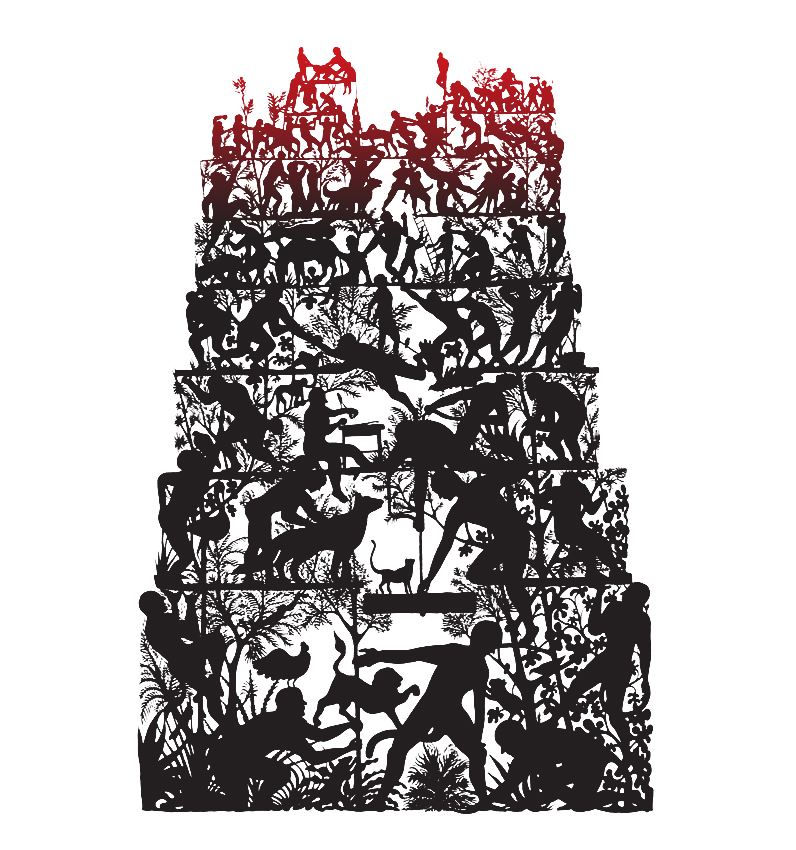
Qualche mese fa è uscito un libro, L’edificio OccupAto, sottotitolo: le centoventi giornate, che rievoca in forma libera, romanzata, rapsodica, un’epoca precisa – la fine degli anni Ottanta –, e un luogo e degli avvenimenti, per quanto trasfigurati, altrettanto definiti – l’occupazione del TienAment nel quartiere Soccavo, che fu a Napoli l’anteprima anarco-punk alle occupazioni e ai movimenti che animeranno la vita culturale e il dibattito politico lungo l’arco degli anni Novanta. Di questi e altri temi abbiamo discusso con l’autore, Adriano Casale (BK Bostik). Qui alcuni frammenti del suo discorso. (-lr)
«In città c’erano state esperienze precedenti, il Jessica di piazza Medaglie d’oro, la centralina di Montesanto occupata dai libertari. Prima di partire da Napoli cercai qualcuno con cui occupare, ma con scarsi risultati. A metà degli anni Ottanta eravamo davvero quattro gatti, tra l’altro con visioni diverse, c’era la frangia autonoma, quella anarchica, quella anarco-comunista, i cani sciolti… Il passaggio all’azione non fu mai così forte da farci scavalcare le differenze, che poi viste col senno di poi erano di poco valore… All’epoca facevo performance audiovisive, degli amici mi invitarono a Berlino per un “live” in una fabbrica occupata, Babilonia, una delle prime strutture cosmopolite, dove si insegnavano le lingue, si integravano gli stranieri… Lì si aprì un mondo, vidi cose che non pensavo potessero esistere, per esempio la possibilità di fare un’occupazione senza fondamentalismo politico ma nella modalità “cani sciolti”. Invece di sette giorni rimasi un mese e dopo un po’ ci tornai. Ho vissuto lì, ho imparato, sono cresciuto, mi sono educato a queste storie, entrando in una delle prime case occupate berlinesi, a Marianen Platz: partecipare al collettivo di quella casa è stata la mia scuola.
«A Napoli non c’era niente. Ma non solo: per un chiodo, un giubbino, una cresta ti portavano in questura e ti picchiavano. Là invece potevi essere quello che eri; e ciò che pensavi era realizzabile. Presi una stanza in questo grande edificio che organizzava un sacco di eventi, per lo più di taglio punk. Riabilitai una sala prove, partecipavo all’organizzazione, mi ero totalmente integrato nella vita berlinese. E Berlino, all’epoca del muro, era l’isola felice. Un ottavo di città controllato dalla Germania federale, mentre il resto era Ddr, quindi una micro-isola in un paese straniero, tanto che per andarci con un furgone dovevi attraversare un corridoio di centinaia di chilometri senza mai poter uscire, coi Vopos che ti osservavano dalle loro postazioni. Addirittura, per mantenere una presenza occidentale, la Germania ovest incitava le persone ad andare a vivere a Berlino, ci si potevano scontare anche piccole pene: droga, politica, chi non voleva fare il militare. Invece di farti i domiciliari o un anno di galera potevi andare a vivere là… Poi a Kreuzberg, tra i punk e i turchi di prima generazione, la polizia aveva davvero problemi a entrare. C’erano quasi quattrocento edifici occupati nel quartiere, con questi plenum, queste assemblee enormi nei cinema occupati…
«Dopo un paio d’anni, non per mia scelta, dovetti andare via. Spinto da questa eccitazione libertaria mi ero lanciato in situazioni che invece avevano un controllo, e infatti ho avuto problemi legali, sono stato anche un po’ dentro, mi feci storie sbagliate e dovetti andarmene. C’era una via d’uscita, convenuta tacitamente tra est e ovest: a tutte le situazioni di militanza estrema veniva data questa possibilità. All’est tutte le fermate della metro erano blindate, perché la metro apparteneva all’ovest. Il treno non fermava mai, se non ad Alexander Platz, e lì c’era una linea che divideva le due giurisdizioni: quella era la via di fuga. Io me ne andai aiutato da compagni, e una volta arrivato a quella fermata, e passata quella linea, non potevi più essere toccato.
«Napoli quando tornai era mutilata, molti erano confluiti nella lotta armata, mancavano riferimenti, gli anziani erano finiti in galera o nell’eroina. Tornando in Italia prima del previsto aiutai prima i compagni del Paso di Torino, poi passai all’Isola nel Kantiere di Bologna, un teatro occupato. E lì pensai, ma perché Napoli deve rimanere fuori da tutto questo? Così un giorno andai alla riunione del Louise Michel a Montesanto. Per fortuna ci trovai un sacco di gente giovane che non conoscevo, in quei due anni finalmente erano usciti fuori… Il primo tentativo lo facemmo alla centralina di Montesanto, un edificio diroccato su un lato delle scale. Era stato occupato negli Ottanta dai libertari e noi tentammo di rioccuparlo. Dopo mezzora arrivò la polizia, chiusero le scale da sopra e da sotto, e poi, siccome era di proprietà dell’azienda dei trasporti, arrivò il direttore affiancato dalla polizia. In quel periodo, come Contropotere, il nostro gruppo punk di movimento, contavamo su una sorta di seguito, al di là dei concerti, e quella volta c’erano dei ragazzi di Milano, di cui alcuni veramente scoppiati, che quando videro la divisa dell’Atan cominciarono a scherzare: “Ua ragazzi, c’è il controllore, fate vedere i biglietti…”. Non finirono nemmeno la frase che cominciarono le mazzate.
«Un altro tentativo fu fatto alla Sanità, in un edificio enorme dalle parti dell’ospedale San Gennaro. Là arrivò direttamente la camorra: mazzate, pistole… Un giorno mi segnalarono un edificio in via Arno, una scuola o quello che era, perché in realtà non era più niente: per cacciare i terremotati il Comune in pratica l’aveva demolito. Per questo, tra l’altro, non calpestavamo i piedi quasi a nessuno. Immediatamente si aggregò un sacco di gente. La prima notte restammo a dormire in cinquanta e respingemmo il primo tentativo di sgombero della polizia. All’epoca esisteva lo scontro fisico: arrivavano, cercavano di rompere il catenaccio, di entrare… Oggi lo scontro è politico, dialettico, allora invece no: la prima cosa da fare era mettere catenacci dappertutto. Io tra l’altro, come si dice nel libro, avevo appena preso una videocamera e così mi misi a filmare l’occupazione. Qualcosa è andato perso, ma altro è rimasto, e nelle poche presentazioni che ho fatto del libro, ho proiettato alcune di quelle immagini e… veramente sembra un’altra epoca.
«Quelli attivi, determinati, convinti – astri che vivono di luce propria –, eravamo una dozzina, forse meno. Ma non voleva essere assolutamente un’azione simbolica… Io non so oggi perché la gente occupa, comunque va bene, sono delle azioni, degli spazi acquisiti, ma mi sembra così diverso dalle motivazioni che hanno spinto me e gente come me a occupare. Non era un movente politico, era un movimento umano di disperazione… O te ne andavi dalla città, o ti facevi le pere, o soccombevi; ma se prendevi una via così estrema, cioè decidevi di vivere in quella maniera, fuori dalle regole, con un’indole quasi animale, allora a un certo punto avevi bisogno, per sopravvivere, di avere uno spazio tutto per te. Altrimenti morivi. O ti facevi. Era semplice, quasi banale, non era frutto di studi: era la possibilità di vestirti come cazzo volevi, sentire e organizzare concerti che nessuno ti faceva, o ancora peggio c’erano posti che accettavano la nostra controcultura, chiamiamola così, ma poi ci giudicavano, ci guardavano come una banda di alcolizzati, di fuori di testa… Ma questo mi è accaduto spesso nella vita: ero un fuori di testa, uno che si stava vendendo la causa negli anni Ottanta, perché dal palco cominciavo a usare il computer, mentre ora tutti stanno con il computer sul palco… Lo dico senza presunzione, ad arrivare troppo presto su certe cose prendi solo mazzate, ma se lo fai è perché ne senti l’esigenza, non cerchi altro… L’occupazione del TienAment non era mossa da nessun ideale. Solo dall’istinto di sopravvivenza, punto.
«Nel TienAment sono stato paladino della policromia antagonista. Il Poeta, per esempio, di cui parlo anche nel libro, era denigrato perché non portava il chiodo; lui si metteva le giacche, alla Burroughs; per me è stato un maestro, mi ha insegnato il situazionismo, ma quello applicato non teorico, e lui era visto male perché metteva la giacca… Su queste cose ho sempre lottato. Perché gli altri dovevano passare quello che avevamo passato noi? Rischiavamo di fare lo stesso gioco… Alla fine, però, credo che il TienAment abbia avuto la forza dell’apertura. Abbiamo accolto tutto, sia situazioni politiche che culturali, addirittura abbiamo fatto suonare gente che veniva dall’house napoletano, che in quel periodo aveva fagocitato tutta la musica elettronica, molti li vedevano come dei fasci… In questa clip che ho montato per le presentazioni c’è una frase del Poeta, che intervistai nemmeno venti giorni prima che morisse: “Abbiamo un posto, diceva, l’errore peggiore sarebbe imitare degli stereotipi o dei posti che abbiamo visto altrove, o creare una specie di gestione aziendale; la gestione ce la dobbiamo inventare giorno per giorno, solo così diventerà il posto che vogliamo”.
«I primi due anni sono stati i migliori, anche perché, banalmente, quel posto era unico, era la novità. Anche se all’inizio molti avevano paura di entrarci. Si veniva dalle lotte armate, con tutto il loro corredo di decreti antiterrorismo: le persone avevano paura di essere arrestate, schedate, nei periodi caldi avevano proprio paura di parlare con te; e infatti si avvicinarono per prime le frange più estreme, i punk, i fricchettoni, i meno prudenti diciamo, e questo creò il movimento. L’apice poi si raggiunge quando arriva la Siae e tu puoi dirgli “quella è la porta”; oppure la denuncia dei baretti perché stai ostacolando i loro affari, o affermati registi teatrali che chiedono di fare le prove, di fare spettacoli lì dentro… A un certo punto era passata la paura ed era diventata una moda; era l’evento, la stampa cominciava a prendere posizione a favore, cosa che non aveva fatto per anni, e noi quel posto lo chiamavamo non “csoa”, come si usava allora, ma “coca”, centro occupato di cultura autogestita, per mettere il fuoco sulle controculture. Eravamo fieri di non essere catalogati come politici.
«La camorra a un certo punto ci offrì il suo appoggio per basi di droga, la sinistra ci offrì protezione, “la storia si sta facendo pesante, dovete avere una copertura”, e arrivò l’avvocatino di cui parlo anche nel libro… Gli uni con il linguaggio dei camorristi, gli altri con quello dei politici. Ma una delle cose belle di allora è che non abbiamo mai dato il culo, mai accettato alcuna mediazione.
«L’esperienza del TienAment l’ho poi ritrovata nelle Taz, le zone temporaneamente autonome, i rave illegali. A un convegno organizzato da Philopat sulle controculture, metà anni Novanta, dissi che il nuovo vestito del punk erano i rave, e lo penso ancora, l’anima del punk si era trasferita lì, perché a lungo andare un posto chiuso rende claustrofobici, toglie l’aria, invece nei rave per una notte facevi quel che volevi, come volevi, e finiva là; sempre con la stessa regola però: autoproduzione, libera musica, nuovi fermenti… perché, parliamoci chiaro, i fermenti creativi sono sempre nati dagli spazi liberati, buona parte della nuova musica è nata negli illegal rave… Gli spazi, e anche le sostanze, creano relazioni ravvicinate e quindi trasformazioni chimiche; questo toglie le inibizioni, ti porta a esprimere quello che sei senza pensare al consenso, che poi è il motore dell’innovazione…
«Qualcuno dice che ci siamo fatti cacciare da quattro vigili, ma non è andata cosi. Probabilmente ci mancava la protezione politica. In quel periodo, metà anni Novanta, destra e sinistra si stavano giocando la partita dell’Italsider e non so per quale motivo uscì fuori che andava ripulita la città. Fu deciso di attaccare il posto meno protetto, meno sponsorizzato. Ci fu un blitz dei vigili urbani, del tutto inaspettato, pistole alla mano, sparando in aria; ci buttarono fuori, misero una catena, e solo dopo vennero i sigilli, quindi del tutto illegale… Da lì ci fu un inedito compattamento dei centri sociali, una riunione al Damm in cui c’erano tutti, e insieme si tentò la rioccupazione, che però fallì. In queste situazioni di massa è facile che le voci fuggano, se ci sono sessanta persone può sempre infilarsi la Digos, e infatti la polizia era là, pronta ad aspettarci… A quel punto decidemmo di cominciare tutto daccapo, usando la tattica del cavallo di troia. Un commando di pochi folli, di notte, conoscendo il posto a memoria – il posto sorvegliato giorno e notte –, entrammo dalla pineta, con una fiamma ossidrica tagliammo la catena dall’interno, ne mettemmo una tale e quale, e poi aspettammo il momento giusto, non ricordo se era un concerto o cosa: aprimmo, entrammo e ci chiudemmo dentro, perché la catena era nostra, loro pensavano che fosse la loro: l’astuzia ebbe il sopravvento sulla forza…
«Dopo di questo ero già stanco, rientrai per questa azione ma mi mancava l’aria, l’occupazione mi aveva totalmente occupato e mi volevo disoccupare. C’erano questi ragazzi giovanissimi che presero in mano il posto, molti anche minorenni; fu bello anche questo, avere la forza di dire: va bene ho fatto il mio, adesso tocca a voi. Poi le cose si misero male, alcuni di loro finirono dentro, ci fu un patteggiamento che forse si poteva evitare, in ogni caso al processo, dopo tutto quel casino, ci ritrovammo in quattro gatti. Pian piano i ragazzi abbandonarono la gestione, la gente cominciò a viverci dentro, mentre noi all’inizio avevamo lottato tanto perché nessuno ci vivesse, se non in situazioni d’emergenza. Alla fine il TienAment non fu sgomberato, ma si dissolse com’era nato. Tornarono i barboni, non i punkabbestia, proprio i barboni, e la gente tornò a farsi. Già qualche anno prima il Comune aveva venduto a privati. In una situazione del genere fecero un’ordinanza e se lo presero.
«Il TienAment, più dei rave illegali, mi ha lasciato l’appartenenza a un’idea, a un gruppo, a qualcosa in cui credi al di là del profitto e del potere. Faccio un esempio stupido: ascoltare un certo tipo di musica; stupido ma anche vero, perché chi ascoltava il punk negli anni Ottanta si sentiva di appartenere a una piccola enclave, a una nicchia, ma aveva un’identità segnata dalla passione, dal credere in qualcosa. Sono stato a Roma di recente per una piccola rentrée dei Mutoid, uno spettacolo al Forte Prenestino. Noi come Contropotere, e poi io da solo, abbiamo lavorato a lungo con loro, per me sono più che fratelli. Quella sera c’erano migliaia di giovani, il Forte era pieno. Alla fine lo spettacolo era poca cosa, però stavano vedendo i Mutoid… Io sono andato là per ritrovare i miei fratelli. Mi sono commosso, non per lo spettacolo o per la musica, ma proprio per questa idea di appartenere a un modo di vedere le cose, di vivere in una certa maniera. L’appartenenza è quel che resta, ed è anche la base che crea i nuovi linguaggi, le controculture».





Leave a Reply