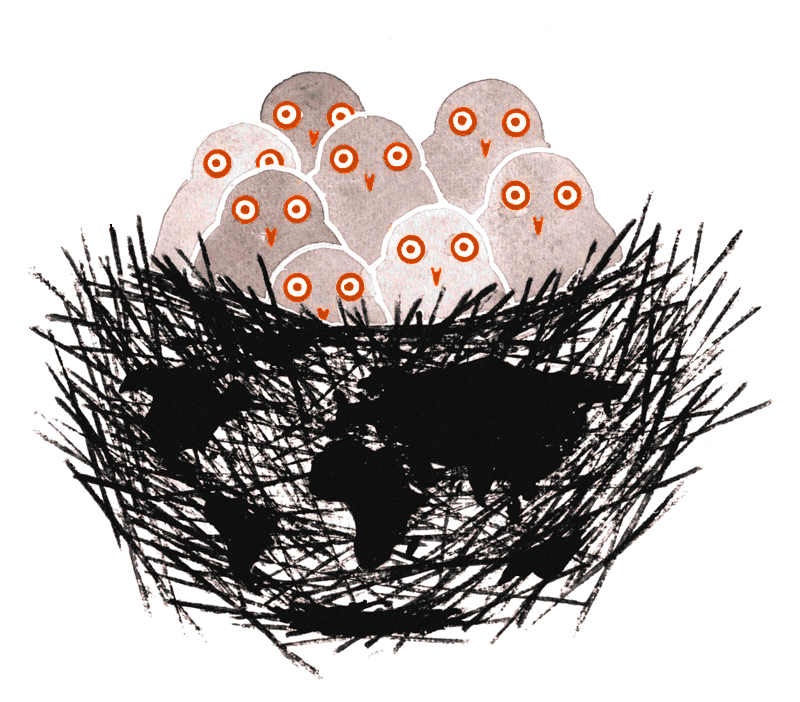
A Lampedusa è una bella mattina di sole, calda. Una delle prime di febbraio. Fuori dall’ufficio di Mediterranean Hope, un programma per migranti e rifugiati della federazione delle chiese evangeliche in Italia, alcuni ragazzi scuri di pelle e dai tratti orientali parlano al telefono, chiamano familiari e amici. Ogni tanto entrano, prendono un bicchiere d’acqua, chiedono informazioni su quando verranno trasferiti in Sicilia o sulla loro situazione legale. Alcuni si siedono all’ombra sui divani, ma la maggior parte è fuori, sul marciapiede. Da alcuni giorni l’hotspot dell’isola ospita poco meno di un centinaio di migranti. La prima barca, soccorsa dalla guardia costiera, aveva a bordo una settantina di persone provenienti soprattutto dal Bangladesh, con loro viaggiavano anche alcuni ragazzi algerini e una donna camerunense. La seconda barca invece era entrata direttamente in porto. Partiva da Al-zawiya, a ovest di Tripoli. Sono scese una ventina di persone, bambini, anziani, si sono avvicinati al molo commerciale di Lampedusa autonomamente, quasi in punta di piedi. Sono quattro famiglie libiche in fuga dalla guerra civile. Quando arrivano sono subito trasferiti nell’hotspot, insieme alle altre persone arrivate due giorni prima.
Un buco nella recinzione permette alle persone di raggiungere il paese, un passaggio ben conosciuto, tollerato nella sua splendente ipocrisia. Vengono in paese per chiedere informazioni, per comprare da mangiare o le sigarette, per usare internet – nell’hotspot la connessione si trova ma è inefficiente – e comunicare con i loro cari, informandoli, finalmente, che ci sono riusciti, che sono arrivati e sono vivi, in Italia, a Lampedusa. Una macchina anonima si ferma davanti alla porta dell’ufficio. Un uomo spunta dal finestrino e grida in direzione degli operatori: «Perché li fate stare qui? Mandateli via che ci attaccano le malattie!». I ragazzi fanno finta di niente, non comprendono le parole, ma intuiscono il significato.
Il nesso costruito tra malattie e migrazioni non è certo una novità portata dall’emergenza dell’epidemia di Coronavirus. Nel 2014, l’Unhcr in collaborazione con Open Migration pubblica un articolo in cui tenta di smentire quell’intreccio strumentale e causale tra malattie e flussi migratori. “Associare l’arrivo dei migranti e dei rifugiati al ritorno di malattie sconosciute o debellate è una storia che fa sempre parecchia presa sulla popolazione”, scrive Claudia Torrisi nell’articolo. Del resto sarebbe inutile elencare qui gli innumerevoli articoli pubblicati sul Giornale o su Libero che diffondono questo pregiudizio, o le tante dichiarazioni di politici e opinionisti. Il pregiudizio ormai esiste e si riassume nella formula “gli immigrati ci attaccano le malattie”. L’allora ministro dell’interno Salvini, nel giugno 2019 indicava come cause dell’aumento in Italia dei casi di scabbia e tubercolosi gli sbarchi e gli immigrati. Enunciata questa “verità”, inutili sono state le proteste e la precisazione che semmai era la povertà, e non gli immigrati, a provocare tale aumento. Una vignetta, questa invece recente, di un disegnatore sovranista ritrae un gommone carico di persone nere, tutti uomini. Uno di questi al posto della testa ha una rappresentazione grafica del virus, mentre in lontananza si vede la prua di una nave ONG che, con tanto di bandiera rossa, afferma nel fumetto: “Un attimo! Ora vi portiamo in Italia!”. La vignetta riassume temi noti della propaganda razzista – l’invasione, l’anti-italianità delle ONG – tra i quali ottiene il ruolo di protagonista l’equazione instaurata tra migranti e malattia.
Col fine di contrastare le tendenze disaggreganti insite nel fenomeno epidemico, si scatena la ricerca del responsabile della sciagura, del morbo. Gli untori della contemporaneità non si discostano molto dalle descrizioni ricevute dalle cronache di passate epidemie. In un bel saggio[1] sulla peste del 1656 a Napoli, l’autrice Giulia Calvi racconta la ricerca delle cause del morbo all’interno e all’esterno della comunità. L’untore, nella Napoli del Seicento, è prima di tutto chi frequenta quei luoghi fisici o simbolici che il senso comune della società relega in un immaginario contraddistinto da sporcizia e impurità. È colui che abita negli interstizi, negli angoli bui che viene indicato come portatore della malattia: l’avvelenatore che minaccia l’integrità del gruppo sociale. Spesso sono accusati gli stranieri, probabilmente perché la peste è sempre considerata un pericolo proveniente dall’esterno della comunità. Tanto che, riportano le cronache del periodo raccontate dall’autrice, “tutti li forestieri che non vestono alla spagnola vivono in una grandissima inquietudine”.
I migranti, essendo abitanti dei margini della comunità, delle zone grigie delle città e, allo stesso tempo, di quello spazio pericoloso e temibile della mobilità, sono implicitamente o esplicitamente indicati come responsabili della diffusione della malattia, appaiono come i perfetti untori della contemporaneità. Una volta approdati in Italia, anzi, sbarcati, come pretende il lessico dell’invasione, sono associati nel discorso razzista a un universo simbolico in cui essi diventano agenti del degrado. Spaccio, piccola criminalità, lavoro in nero, sporcizia, pigrizia, indigenza, malattie. Il razzismo si articola in un mosaico di affermazioni infondate in cui convergono pregiudizi antichi e immagini invece nuove o rielaborate. Il migrante è l’ignaro untore, è la minaccia alla salute pubblica oltre che alla sicurezza, è il nemico.
Abbiamo ben presente il governatore leghista del Veneto, Zaia, che su una tv locale accusa la comunità cinese: «Mangiano topi vivi», dice Zaia, che dopo aver esposto la tesi della sporcizia cinese come fatto culturale, bilancia questa affermazione con l’opposta «cultura dell’igiene» e della «pulizia personale» che contraddistinguerebbe i veneti e, in secundis, i cittadini italiani. Cause e responsabili dell’epidemia sono quindi inizialmente ricercate all’esterno della comunità: i cinesi, gli asiatici più in generale, e i migranti sui gommoni. Nella storia delle epidemie incontriamo alcuni tipi fissi, caratterizzati da impurità e mobilità, su cui si costruisce il perfetto responsabile avvelenatore: le donne, i soldati stranieri, i venditori ambulanti e i vagabondi. Essi erano coloro su cui scatenare la rabbia popolare. E la rabbia popolare, anche qui e oggi, si è scatenata. Sulla comunità cinese in Italia, prima che sugli altri, o su chi semplicemente ha tratti somatici assimilabili a quell’area geografica. Le prime settimane di febbraio sono un susseguirsi di segnalazioni di aggressioni ai danni di cittadini cinesi – e in un caso di un cittadino filippino – a Roma, Torino, Napoli, in provincia di Vicenza, Como. Mi sono limitato a una veloce ricerca web, ma probabilmente i casi di violenza fisica sono molti di più, escludendo poi la violenza verbale e non verbale che spesso non è denunciata. Negli stessi giorni viene imposta la quarantena preventiva, quindi senza che fossero state registrate motivazioni che inducessero a prendere tale decisione, di quattordici giorni ai migranti salvati dalla Sea-Watch 3 e dall’Ocean Viking, i quali dovranno rimanere in osservazione a terra una volta fatti scendere dalle navi. La discriminazione c’è, e non riguarda la scelta discutibile ma legittima di imporre un periodo di osservazione in quarantena, ma il semplice fatto che nessun’altra imbarcazione, turistica o commerciale, sia stata interessata da misure preventive simili nel periodo precedente o successivo all’arrivo delle navi impegnate in operazioni SAR.
Oggi i ventisei migranti che si trovano sull’isola di Lampedusa non possono più uscire dal passaggio nella recinzione. Rimangono in quarantena, come quelli che sono stati trasferiti in Sicilia. Il rito della sicurezza pubblica in tempi di emergenza impone su di loro un «eccesso di precauzione», formula utilizzata dal sindaco di Pozzallo in un’intervista andata in onda su Quarta Repubblica il 24 febbraio, per tranquillizzare le paure popolari del contagio all’indomani dell’arrivo dell’Ocean Viking nel porto della città. Un popolo considerato sempre manipolabile, suggestionabile e impaurito, in cerca di sicurezza. Tra chi la sicurezza cerca e chi la sicurezza offre, nel mezzo ci sono i migranti, gli stranieri. La minaccia, gli untori. (giovanni d’ambrosio)
___________________
[1] Giulia Calvi, L’oro, il fuoco, le forche: la peste napoletana del 1656, Archivio Storico Italiano, Vol. 139, No. 3 (509) (1981), pp. 405-458.


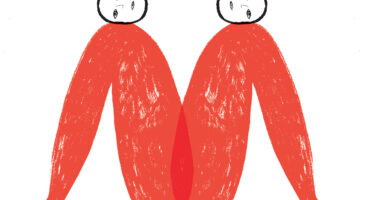


Leave a Reply