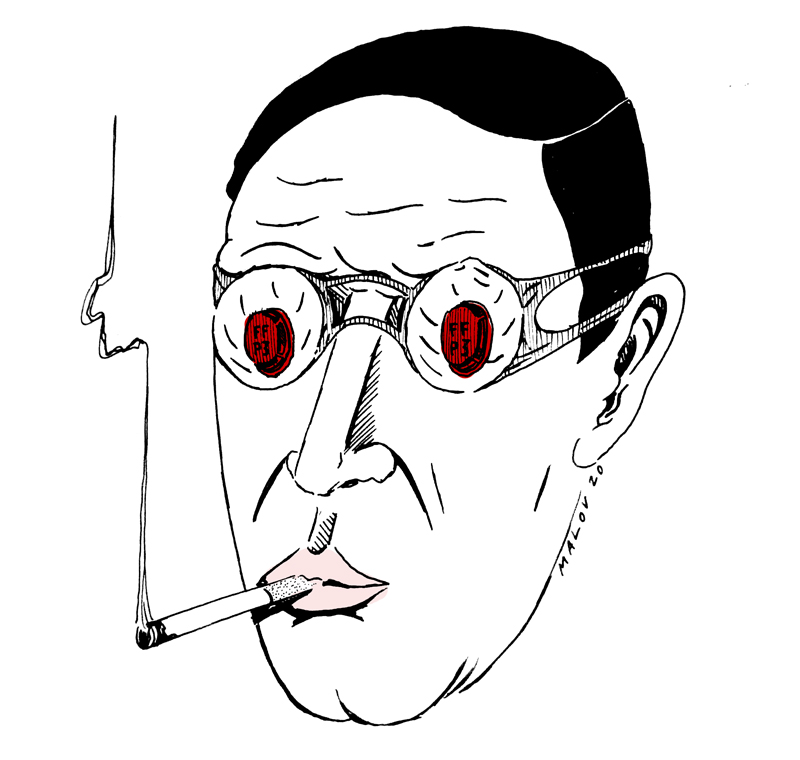
Nelle ultime settimane, un gran vociare di immagini ha provato a raccontare il silenzio. Fotografie, reportage, articoli di giornale hanno invaso i nostri canali di comunicazione e ci hanno narrato dell’irreale sensazione di assenza nei luoghi in cui l’occhio è da sempre abituato alla folla. Tuttavia, di fronte al velo patinato di queste immagini estetizzate e sentimentali si tende troppo facilmente a dimenticare la natura politica delle logiche di gestione dell’emergenza. Il susseguirsi incessante di queste immagini diffonde un nuovo ordine estetico e morale che investe gli spazi urbani e ne determina le modalità di governo: esso prende le forme del vuoto, e il suo mantenimento è affidato alle forze armate. Si ragiona allora in termini di sicurezza, sanitaria certo, ma con il lessico dell’assalto bellico. In un articolo de La Stampa del 23 marzo (“Coronavirus, l’esercito svuota le periferie. E a Torino crollano i reati”), una giornalista descrive la Torino di questi giorni. La notizia principale sembra essere l’azione uniformante dell’intervento militare su quella che fino ieri, ci dice, pareva una città “a due velocità: un centro che rispetta le regole e una periferia più refrattaria”. Il senso di questa divisione, malcelato in questo e in altri articoli, è quello di una spartizione manichea tra disciplinati e indisciplinati, buoni e cattivi.
Nel bisogno tutto umano di dare un volto alla minaccia, il virus prende le sembianze dello spacciatore di quartiere, del senzatetto all’angolo della strada, della prostituta nelle vie dimenticate, ma anche dell’anziano che passeggia, del runner nel parco urbano. Con la scomparsa del viavai dalle strade aumenta esponenzialmente la visibilità nello spazio pubblico del corpo non disciplinato, deviante, che viene ora letto come vettore del virus e disturba il desiderio di ordine. Mascherine e autocertificazioni, buste della spesa e rispetto delle distanze diventano il simbolo che distingue tra corpi tollerabili e corpi indecenti. Il normale rimane in casa e dunque è legittimato a criminalizzare ogni attraversamento illecito, denunciandolo dalla propria finestra. “Io lascerei i militari in giro anche dopo l’emergenza Coronavirus…ci potremmo liberare di tutta quell’immondizia che vediamo qui in giro a Torino ogni giorno. I reati diminuirebbero drasticamente come succede oggi”, si legge tra i commenti in calce a quello stesso articolo. La richiesta di tranquillità e sicurezza si lega a doppio filo alle ideologie del controllo e della sorveglianza, una pretesa che si estende dall’ambito domestico fino a coinvolgere l’intera città, creando il terreno fertile per l’accettazione acritica dei diversi gradi di restrizione a cui stiamo assistendo.
Un altro titolo (da Sky Tg 24) recita: “Il Coronavirus svuota le strade: città deserte da Milano a Napoli“. L’effetto che la lettura di questi enunciati produce è quello di investire la malattia di uno specifico ruolo semantico nel momento in cui essa diventa il soggetto della frase. In questo modo il discorso difensivo e securitario viene giustificato e si confondono, appiattendoli, i diversi livelli di interpretazione delle scelte operate dallo stato. Le misure messe in atto nell’ultimo periodo si intrecciano, soprattutto nei quartieri più “refrattari” della città – come li definisce La Stampa – con quelle volte a garantire e imporre legalità, ordine e quiete pubblici. Il risultato è quello di una sovrapposizione simbolica di malattia e delinquenza: contagio e crimine sono connessi fino a costituirsi in una sostanziale identità che investe i corpi di chi abita lo spazio pubblico ormai deserto: “Nei giardini Madre Teresa di Calcutta ci sono cinque uomini. Alle spalle hanno qualche denuncia per spaccio. Da ieri ne hanno collezionata un’altra per non aver rispettato il decreto”, continua la nostra giornalista.
Nelle zone più marginali della città le misure messe in atto per il controllo del rispetto dei decreti prendono la forma dell’intimidazione. “Sarà l’effetto dell’esercito in strada. O forse il clima, meno mite dei giorni scorsi, ma domenica mattina le vie della periferia Nord della città erano vuote. […] Niente più capannelli. In giro solo qualche sbandato con birre in mano”. Nel servizio video girato da un secondo giornalista che accompagna questo resoconto i militari sono inquadrati mentre accerchiano chi ancora si ostina ad abitare le strade di Barriera di Milano. L’impressione che si prova mentre le riprese scorrono è che l’oggetto principale delle loro attenzioni sia chi porta su di sé i segni evidenti della povertà e diventa la concretizzazione di un male che è insieme sociale, fisico e morale.
La militarizzazione messa in atto per arginare i contagi, presentata come la naturale risposta immunitaria del corpo sociale al virus sconosciuto, diventa occasione per il potere repressivo di uscirne rafforzato. In un ambiente in cui per motivi sanitari si è costretti a intrattenere rapporti interpersonali più rarefatti, a mantenere distanze maggiori prima di tutto tra i corpi, l’unica forma di cooperazione accettabile è quella con le forze dell’ordine. “«Rispettate le distanze», ripetono i soldati. Qualche residente ringrazia: «Era ora. Da queste parti, per colpa dei soliti, facciamo sempre la figura di quelli che se ne fregano. Ma non è così»”. La voce del “buon cittadino” che, suo malgrado, si trova a vivere nella “zona cattiva” della città, diventa il simbolo dell’opinione dei buoni, di coloro che richiedono le soluzioni di arginamento del contagio e il loro diventare ulteriore occasione per ripulire i loro quartieri. La Torino delle due città ci allontana una volta di più dalla domanda che riguarda le cause strutturali della differenza di velocità, e nonostante la militarizzazione giunga per imporre l’uniformante estetica del vuoto, le disparità sociali non scompaiono.
Anche per le strade più rispettose del centro, le disuguaglianze sociali presenti da prima del virus permangono, e chi già faceva parte di una categoria più vulnerabile affronta con maggiore inquietudine reclusione, desertificazione e presenza dell’esercito. La diminuzione, dall’inizio di marzo, del 55% delle chiamate ai numeri antiviolenza denunciata da Repubblica (“Coronavirus, i centri antiviolenza: ‘Le donne non riescono a chiederci aiuto. E noi siamo senza fondi’”, articolo del 21 marzo) è uno dei sintomi di come il mutamento drastico dello spazio sociale in cui siamo abituati a muoverci si ripercuota anche sulle dinamiche personali nel privato. Questa – così come altre situazioni tanto rese invisibili quanto radicate nel nostro tessuto sociale – smaschera l’illusione della serenità dello spazio domestico e insieme dell’equivalenza, presentata sempre più come ovvia, tra l’imposizione della legalità e la sicurezza in termini assoluti. Centro e periferia, pubblico e privato, smart-worker e spaccino, obbedienza e refrattarietà: esiste un mondo sezionato in compartimenti dove categorie dualistiche a tinte altamente moralistiche si oppongono e sovrappongono, ostacolando le possibilità di contatto. Nel frattempo il questore ci rassicura che “Torino sta rispondendo bene alla gravità della situazione”. Ma è davvero così? Quale sicurezza viene messa in atto, e per quali gruppi? Sembra che alcuni ora se la meritino più di altri. (arianna friso / laura raccanelli)





Leave a Reply