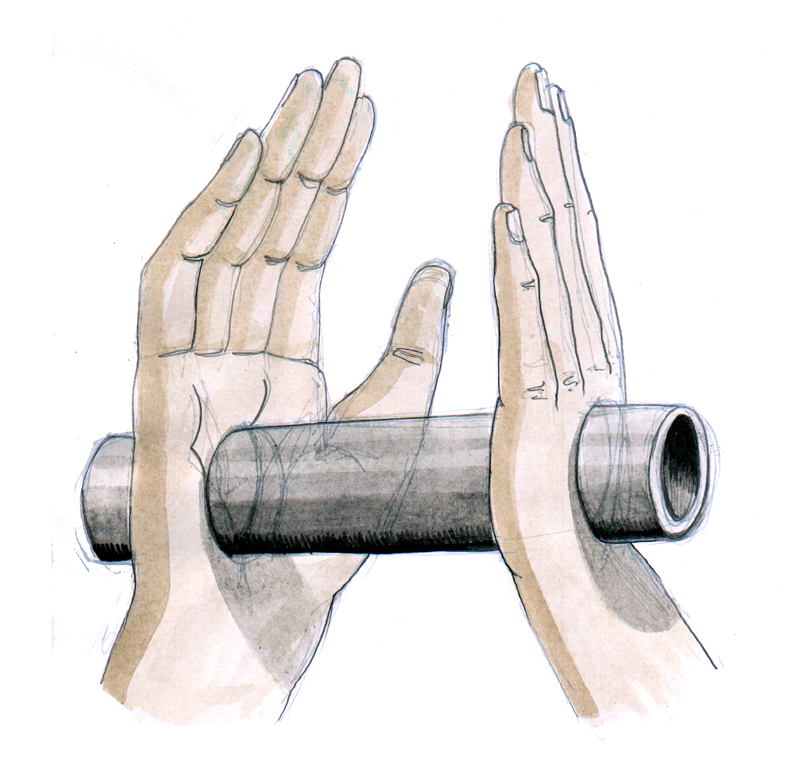
Sono nel “parco senza nome” e leggo un articolo di Renzo Piano. “Siamo in un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città del futuro”. Il testo è stato pubblicato sul Sole 24 Ore nel gennaio del 2014. Sono seduto su una panchina e davanti a me alcuni ragazzi del quartiere parlano e scherzano radunati in cerchio, ogni tanto una voce sovrasta le altre. Renzo Piano, senatore a vita da due anni, ha deciso di devolvere il suo stipendio da parlamentare a una squadra di sei architetti. Il gruppo ha il compito di progettare piccoli interventi urbanistici per agevolare la rigenerazione delle periferie metropolitane. L’articolo – dal titolo “Il rammendo delle periferie” – è il manifesto dell’iniziativa. Alzo gli occhi dalla pagina e osservo tre ragazzi con il capo avvolto nel cappuccio: si riscaldano al ritmo di una musica che esce da una cassa appoggiata accanto. L’anno scorso la squadra di Piano è intervenuta in tre aree periferiche di Roma, Catania e Torino. “Le periferie sono la città del futuro, ricche di umanità e quindi il destino delle città sono le periferie”. Il sole è ormai nascosto dietro ai palazzi e la luce del cielo inizia a scemare nel parco senza nome di Borgata Vittoria, nord di Torino. Mi trovo a pochi passi dalla struttura ideata da due collaboratori del senatore.
Davanti a me corre un viale che attraversa una striscia di prato. Il parco è un corridoio incassato tra una scuola materna, un campo di sterpaglie e i palazzi a dieci piani costruiti negli anni Sessanta per gli operai della Fiat. Qua e là ci sono piccoli prefabbricati che portano a un parcheggio sotterraneo: hanno ampie vetrate e pareti coperte da scritte. Sull’erba, oltre le panchine, noto alcuni attrezzi – ostacoli, barre, assi per piegamenti e flessioni – che disegnano un percorso atletico. Mi volto verso l’estremo limite del parco e vedo l’opera progettata dalla squadra di Piano: otto basi di cemento sorreggono uno scheletro di pilastri e travi in legno. È un parallelepipedo essenziale alto più di tre metri, avvolto da teloni recuperati da vecchi striscioni pubblicitari. Le coperture sono cadenti e sgualcite, accanto a uno squarcio noto lo stemma di Torino Expo. Su un lembo inferiore qualcuno ha tracciato con una bomboletta una scritta rossa: suca.
Estraggo dallo zaino il primo numero di Periferie, la rivista dedicata agli interventi di riqualificazione promossi dal gruppo di Piano. Sfoglio le pagine su Torino. “Il gruppo di giovani architetti […] ha rivitalizzato la zona con piccole strutture in legno, oggetti di recupero, tessuti usati per i pannelli informativi del comune […]. L’intervento di per sé è molto semplice, vuole restituire allo spazio un carattere dignitoso, attivando idee, energie, iniziative». Questa è l’unica traccia lasciata a Torino dagli architetti del senatore. La panchina sotto i teloni è sfondata ed è avvolta da un nastro rosso e bianco. A fianco la griglia di un canale di scolo ha ceduto e il buco è coperto da una transenna, anch’essa bianca e rossa. Seguo una scritta sul selciato: ciao amore resta per sempre; a fianco leggo la data: un innamorato è stato qui lo scorso agosto. Il master plan descrive le funzioni dell’installazione: “Una struttura in legno a formare una porta d’accesso verso un luogo di sosta, incontro e condivisione”. I ragazzi del quartiere fumano e schiamazzano trenta metri più in là, nessuno s’avvicina alla struttura.
Poco oltre termina il parco senza nome e le macchine sfrecciano su corso Grosseto. È un viale ampio e diritto, tutti lo attraversano di corsa quando le auto sono ancora punti all’orizzonte. Corso Grosseto sembra un intaglio di asfalto che divide il quartiere. Secondo Piano bisogna “cucire e fertilizzare con delle strutture pubbliche” le periferie. Il micro-intervento urbanistico in Borgata Vittoria è un rammendo, un tentativo di unire i margini slabbrati di questo luogo. “Alle nostre periferie occorre un enorme lavoro di rammendo, di riparazione. Parlo di rammendo, perché lo è veramente da tutti i punti di vista, idrogeologico, idrico, estetico”. Mi pare che il rammendo sia una parola apprezzata dagli amministratori. Qualche giorno fa l’assessore comunale ai trasporti ha tenuto una riunione nel circolo del partito democratico di Borgata Vittoria: il termine è fluito almeno tre volte dalle sue labbra. Qui al parco senza nome sussurro parole di successo: rammendo, rigenerazione urbana, bene comune. E ripeto piano una frase dell’architetto: “Andiamo a fecondare con funzioni catalizzanti questo grande deserto affettivo”.
Dall’altra parte di corso Grosseto si staglia la facciata d’una chiesa, l’edificio fa parte della parrocchia di San Giuseppe Cafasso. Dal cortile interno vedo il lungo edificio della mensa dei poveri, una palestra, l’ingresso alle docce per chi non ha dimora. Poco oltre sorge la scuola paritaria. Don Zucchi dirige questa città di dio. «Mi domandi degli architetti di Piano? Una è di Alessandria, l’altro vive a Ferrara. Non sanno nulla di questo posto». Il suo sorriso è ironico e freddo. «Sì, li ho visti girare qui intorno, un pomeriggio. Hanno dato giusto un’occhiata, poi via, si sono volatilizzati». Intravedo la genealogia dell’opera di ricucitura: la struttura è inefficace e aliena perché è l’esito di un approccio distante, indifferente alle relazioni materiali del quartiere. Osservo lo scheletro di legno come una forma dello sradicamento. Un ragazzo con un cappellino a visiera mi passa accanto, forse non mi vede; anche io mi sento un estraneo che va in giro con un taccuino.
«Io non riesco a prendermi cura di tutto il quartiere – mi dice don Zucchi –, mi concentro solo sull’area della mia parrocchia. Vedi come tutto è pulito, senza cartacce né altre schifezze? Ho ottenuto un finanziamento dalla Compagnia di San Paolo e ho istituito un corpo di green angels che puliscono le strade dall’immondizia e dalle scritte». Gli “angeli verdi” sono due ragazzi rom che don Zucchi paga con i voucher. «Guarda qui che bel lavoro», dice.
Mentre passeggio nel parco senza nome penso al lavoro e alle sue condizioni. So che la struttura in legno è stata eretta da un gruppo di giovani architetti di Torino. Per loro non è stata prevista alcuna retribuzione, hanno svolto il lavoro più faticoso sull’onda dell’entusiasmo: «Credevamo nella possibilità di fare una valida operazione di riqualificazione», mi hanno detto. Hanno la mia età e hanno terminato gli studi di recente. L’opportunità di acquisire esperienza è la moneta con cui pagano il nostro lavoro volontario. Scrive Renzo Piano: “Se c’è qualcosa che posso fare, è mettere a disposizione l’esperienza che mi deriva da cinquant’anni di mestiere, per suggerire delle idee e per far guizzare qualche scintilla nella testa dei giovani. Una scintilla di una certa urgenza, con una disoccupazione giovanile che sfiora una percentuale elevatissima”. Mentre la luce del pomeriggio è sempre più flebile presto attenzione alla metafora della scintilla. Il numero di Periferie menziona la “scintilla del rammendo”, poi evoca la “ricerca di una scintilla umana, aggregativa e di sincera ostinazione”. Si attizzano le braci della retorica.
Alla fine del parco – sono all’estremità opposta, alle spalle ho corso Grosseto – compare una cascina seicentesca abbandonata. La cascina Fossata è un edificio ampio con una corte interna e mura perimetrali più alte di me. In alcuni punti le pietre antiche franate sono state sostituite con rattoppi in mattoni. Il tetto è crollato e sono stati stesi dei teli verdi. Fra la cascina e le mura si distende una terra di nessuno dove cresce una selvaggia natura urbana. Gli alberi sono spogli e fatico a riconoscere la loro specie. Noto una palma e un acero grandioso in un mare di sterpaglie. Due uomini sono in piedi, immobili l’uno di fronte all’altro nell’aria fredda, hanno il cappuccio calato sulla fronte. Uno ha una giacca con due scudetti tricolori, mi ferma. «Hai una sigaretta, gentilmente?». Chiedo loro chi fossero gli abitanti che s’accampavano nella cascina. «Mah, zingari». Ora non c’è più nessuno. Forse sono stati sgomberati? «Non ti so rispondere».
Presto la cascina Fossata sarà “riqualificata”. Il comune ha indetto un bando per l’assegnazione di quattordicimila metri quadri e una società di investimenti ha ottenuto il diritto di gestire l’area per i prossimi ottant’anni. Nell’antica corte si apriranno esercizi commerciali e “spazi per manifestazioni temporanee”, l’edificio invece diventerà una residenza abitativa temporanea, o social housing. L’articolo di Piano si confonde con le mie visioni: “Un’altra idea guida nel mio progetto con i giovani architetti è quella di portare in periferia un mix di funzioni. La città giusta è quella in cui si dorme, si lavora, si studia, ci si diverte, si fa la spesa”. Cammino al fianco delle mura e osservo i cartelli gialli con un punto esclamativo in centro. I segnali mi avvertono: pericolo!
È buio, la facciata scura della cascina emerge misteriosa contro le nuvole d’un colore arancione elettrico. Continuo a camminare e raggiungo la stazione Rebaudengo-Fossata. Lo scalo accoglie i treni che entrano ed escono dalla rete metropolitana, ma l’edificio è ancora in costruzione: un reticolo di cemento è esposto all’aria di dicembre, scorgo una rampa di scale sospesa nel vuoto. Un tempo qui si distendeva il passante ferroviario, la via ferrata tagliava in due la città da sud a nord. Nel 2012 sono terminati i lavori di interramento delle rotaie, ora i treni corrono nel ventre di Torino. In superficie è stata realizzata la Spina, una lunga arteria stradale che ha stimolato nuovi progetti di espansione urbanistica. Verso sud il mio sguardo spazia sul cantiere della Spina: un lungo e vasto canale silenzioso tra Borgata Vittoria e Barriera di Milano. Seguo la linea delle transenne, in lontananza ecco mi appare la sagoma del grattacielo di Intesa Sanpaolo. Vedo le luci rosse delle impalcature lampeggiare intorno a un’ombra slanciata e più oscura della notte. Di giorno il palazzo di vetro si specchia nel cielo, oppure svanisce come nuvola tra le brume. Il progetto del grattacielo è stato disegnato da Renzo Piano. È tardi ormai. Queste visioni sono sintomi di qualcosa che ci accade, penso mentre m’allontano. (francesco migliaccio)





Leave a Reply