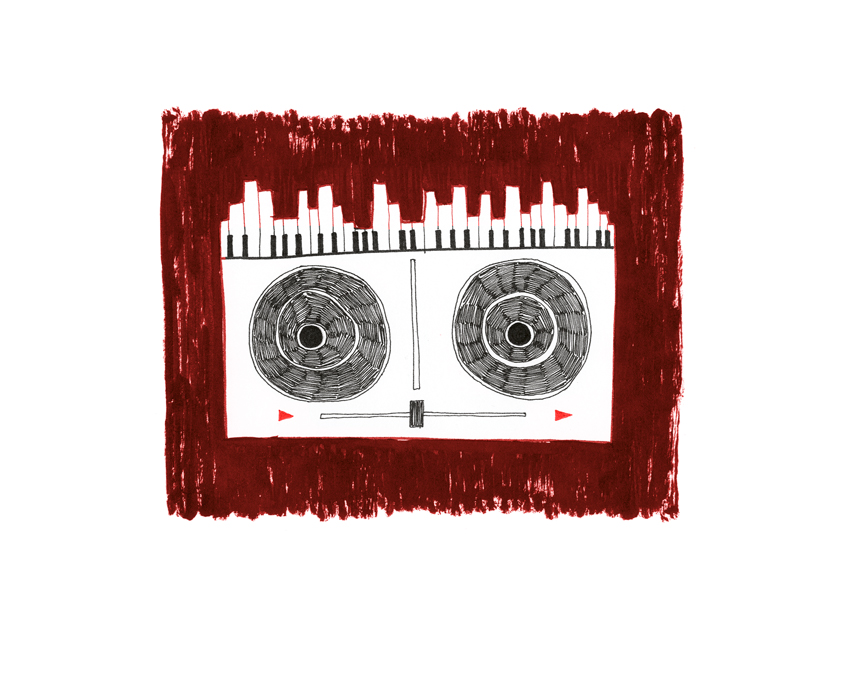
Un altro campionato sta per finire e con lui se ne vanno pure le stagioni di concerti. Si preferiscono appuntamenti più leggeri, una musica più disimpegnata, il calcio estivo.
Vado a sentire il mio ultimo concerto della Digestion di quest’anno (si chiude il 16 giugno al Riot studio). Concludo nella chiesa di San Giovanni Maggiore Pignatelli, in assetto vangoghimmersion.com: sono questi gli acquari in cui l’arte – soprattutto se tecnologica – ci porta ultimamente, a garanzia di un’esperienza al pari mistica e massiva. Ci sono quei teli che chiudono le arcate, a fare la scatola per il pubblico, dipinti a mano per stimolare la continuità percettiva dei marmi. E poi le sedie, tante sedie. Fino a metà chiesa. E – udite udite – tre divani ben celati. Aspettiamo un po’ di persone, dicono le sedie. Nel rettangolo di proiezione si gioca a una porta sola: siamo direzionati infatti verso i pali, queste due colonne per la diffusione del suono al cui centro l’esecutore trova spazio, al pari del Buffon nell’addio ai pali, e non al calcio. Il vociare degli intervenuti riempie spazi e attese. E gli applausi, ogni tanto. Lentamente si sfocia nel sold out per un concerto da far vibrare le pareti. Esecutori sono l’uno (Thomas Köner) e l’altro (Rashad Becker).
L’uno si prende un rischio. Lo spazio gli restituisce quello che il suono gli concede e per questo risponde attivamente, sapientemente sollecitato. Lavora di basse frequenze, sulle quali talvolta inserisce un piccolo ricamo, un disegnino musicale altro. Sprofondo sul divano, consapevole di ascoltare qualcosa di molto meditato, poco estemporaneo. Le vibrazioni si fanno corporali, di stomaco. In linea di principio, compone in modo che lo spazio sia l’interprete, se ne frega quasi ci sia il pubblico, al punto che non capisco perché dobbiamo starci pure noi. Si lavora di lontananze anche incorniciate dal battimento. Il rapporto causa-effetto anima l’esecuzione. Mai spazio trova il silenzio, e questo un po’ mi dispiace perché a suonare sempre sono tutti bravi. Bravi forti. Capito l’andazzo, infatti, c’è solo da aspettare l’esito di tutto questo. Ci mette sempre qualche bassa, cambia registro, in quella sottile linea tra il saper gestire il tempo e il saperci fare la palla. Siamo un bel pubblico di calmierati, molti scontenti, eppure zitti e fermi. Liquidiamola interessante, questa esperienza immersiva al pari che Van Gogh. Da suicidio stoico, si consuma nell’attesa della fine; gli echi cromatici della sala ci portano all’apertura della stagione – affidata al deludente Basinski – e annebbiano il momento.
Intervallo, tra un primo e un secondo tempo. Giusto il tempo di acchiapparsi fuori, laddove il dentro è lasciato alla contemplazione. Il pubblico ha pagato per ascoltare in silenzio.
L’altro inizia uno studio sul decadimento. Un piglio completamente diverso, variegato; inserisce opportunamente livelli, punti, spazi e superfici: stavolta lo spazio non è l’architettura ma la misura degli interventi nel tempo. Una roba che avanza per moduli – peccato non lavori per tutto il campo, in un perdersi quadrifonico. I diversi suoni si rincorrono ciechi. L’altro è un nome della registrazione, ma gode alla grande della dignità di esecuzione. La tavolozza dei suoni che usa per macchiare la scena performativa dipinge il tempo. Lo ascolto e non ve lo racconto: finalmente la Digestion trova risposte. Simmetrie, sovrapposizioni, scanalature. I suoi interventi si svelano in una continuità quasi ineccepibile. Un nuovo segmento, timbricamente diverso, si interpone nella struttura e, pur nella cecità dei suoni, tutto si ritrova. Non c’è danza, ma danzità.
Poi tutto quello che era passato si sovrappone in quello che ora succede. Emergenze acustiche fanno capolino senza adocchiare alcuna soluzione di facciata. Arrivano delle frequenze, quasi un ventaglio che si apre per fare aria. Finalmente uno che osa un po’ di beat riconoscibile al punto da far muover le teste, una struttura su cui fa evolvere altri disegni decisamente meno riconoscibili eppure chiari nella loro intenzione di scardinare la gabbia entro cui sono racchiusi, ridotta ormai a solo pretesto. Non si può avere la pretesa di ridurre l’estemporaneità di un ascolto a una comprensione effettiva dell’ascoltato: pone sempre dei chiari problemi di analisi musicale. A ogni modo, questa seconda parte audace forse allunga il brodo un po’ troppo, perché non si può richiedere a un pubblico di essere attento per più di novanta minuti, per una epifania del suono. Andiamo avanti, fino alla fine. Finisce. (antonio mastrogiacomo)


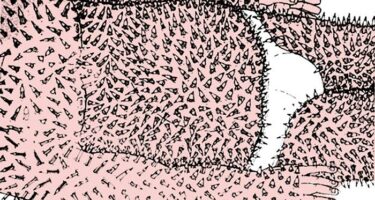


1 Comment