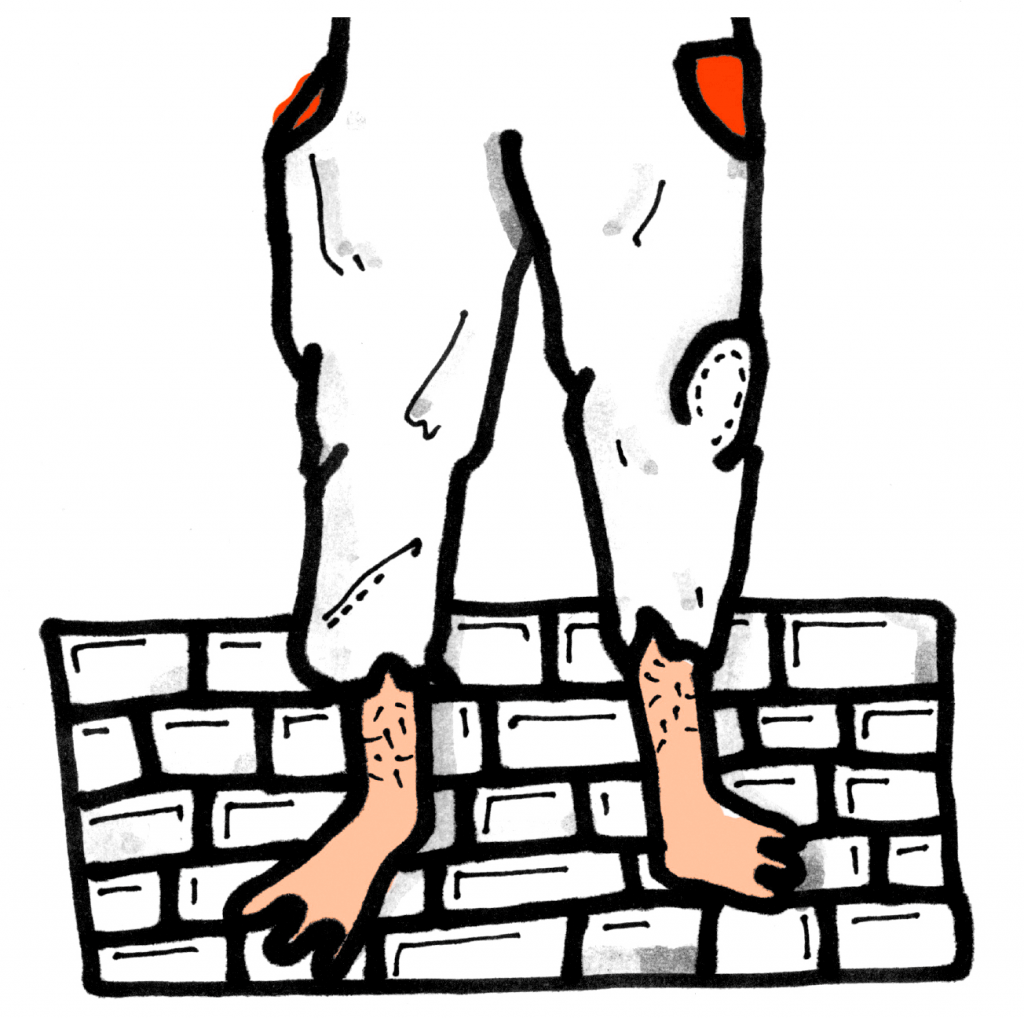
Quando usciamo il sole non si è ancora affacciato da dietro la collina. I campi sono bagnati da una luce spettrale, l’aria è fredda e pungente. Sulla strada per il castello incontriamo altre persone, che camminano da sole o a gruppetti. Ci si saluta con un cenno del capo. Siamo tutti pickers, e stiamo per iniziare la giornata di lavoro. È il primo di settembre, da qualche parte nel sud della Francia. Tempo di vendemmia.
Lo chateau che ci ha assunto si trova nella regione di Rhone-Alpes. Come il nome suggerisce, l’edificio principale della tenuta è un vecchio castello ristrutturato. È qui che l’uva viene pigiata, filtrata, fermentata e messa in bottiglia. Qui si trovano anche le cantine, gli uffici, e gli alloggi per i lavoratori coinvolti nel processo di produzione vero e proprio. I raccoglitori alloggiano in un casale a poca distanza. Assieme a un letto e a un tetto abbiamo anche da mangiare: due pasti completi al giorno più due abbondanti colazioni. Acqua e vino rosso a volontà. Vitto e alloggio costano quindici euro al giorno, che ci vengono detratti direttamente dalla paga.
La squadra di pickers è composta da circa quaranta persone. I francesi sono cinque, giovani e mediamente avventurosi. Come Pierre, poco più di trent’anni, che vive in un camion e passa l’inverno in una specie di comune. Oppure Sylvie, che di anni ne ha ventisei, e l’inverno lo trascorrerà in Mali lavorando per una Ong. Ci sono due ragazzi polacchi arrivati in autostop, e noi quattro italiani. Tutti gli altri sono lettoni: uomini e donne tra i venti e i cinquant’anni, per la maggior parte arrivati in bus dopo un viaggio di tre giorni. Si capisce subito che sono piuttosto contenti di essere qui, ed è presto chiaro il motivo. In Lettonia il salario minimo è di due euro e mezzo all’ora. La paga da picker si aggira invece sui dieci euro lordi, e parecchi di loro hanno scelto di campeggiare tra le vigne per mettersi in tasca anche i quindici euro del vitto. Ma c’è anche qualcos’altro che li tiene allegri, oltre la paga. Per Marta Viktoria, giovane e appassionata studentessa d’arte, attraversare l’Europa per venire a fare il vino in Francia ha qualcosa di romantico. Per gli altri, forse un po’ meno sensibili, stare qui è comunque meglio che stare a casa. Il tempo è decisamente migliore, e pure il cibo; il vino si fa bere, e la compagnia non è male. Di giorno parlano poco e lavorano veloce. La sera bevono parecchio e si divertono altrettanto, condividendo con generosità birre, vodka e vino del supermercato. Quando qualcuno rovescia un bicchiere, finisce la bottiglia o si accorge di essere in ritardo per la cena, dice: «Katastròfa!», e tutti gli altri ridono. Dopo un paio di giorni ridiamo pure noi.
A dirla tutta noi italiani non siamo qui per lo stipendio, ma per la disoccupazione di rimpatrio. Si tratta di una legge che risale agli anni Settanta, ma è di fatto rimasta a lungo sconosciuta ai più. Al termine di un contratto di lavoro all’estero, il lavoratore rimpatriato può godere di un sussidio di disoccupazione pari a un terzo dello stipendio mensile, per un massimo di sei mesi. Quel che è singolare è che la normativa non specifica la durata minima del contratto. Un anno, un mese, una settimana o un giorno vanno bene, purché non si venga licenziati. Durante gli ultimi cinque anni la notizia si è diffusa per passaparola, soprattutto tra quella fascia di lavoratori condannati a una precarietà che rasenta spesso la miseria. La vendemmia offre le condizioni ideali per fare richiesta del sussidio: è un lavoro con contratto necessariamente breve, non richiede particolare esperienza né conoscenza della lingua.
La disoccupazione di rimpatrio può essere richiesta una sola volta nella vita; ma alcuni di quelli che ne hanno già usufruito ritornano comunque, e a poco a poco entrano nel circuito dei lavori stagionali, che in paesi come la Francia sono pagati piuttosto bene. I più intraprendenti si trovano una residenza di fortuna e, raccolta dopo raccolta, provano a mettere insieme le seicentodieci ore di lavoro in ventotto mesi che daranno diritto a usufruire del generoso welfare locale.
In apparenza c’è qualcosa di vagamente piratesco in tutta la faccenda. D’accordo, non è come passare la frontiera con una valigia piena d’erba, ma neanche come fare il commesso da H&M. Il lavoro agricolo stagionale spezza inoltre il dogma della sedentarietà del lavoro dipendente, con il suo corollario di routine, dipendenza dallo schermo e incombenze fuori orario a cui dover far fronte con un sorriso; nomade e fisico, a stretto contatto con la natura e con gli altri, intermittente e almeno in questo caso ben pagato, per molti versi consente un margine di manovra più ampio nel limitato territorio di un’esistenza felice. Se ci metti anche il sussidio, poco ci manca per trasformarci in novelli Jack Sparrow, pirati in erba pronti ad affrontare con coraggio l’onda della precarietà in mare aperto piuttosto che restare sulla riva a raccogliere conchiglie.
La prima colazione viene servita nel castello alle sei e trenta. Caffellatte, pane, burro e marmellata. Alle sette e un quarto siamo in viaggio, venti persone nel retro di un furgone senza finestre. Alle sette e trenta siamo sulla vigna; un secchio e una cesoia a testa e via, schiena curva per le successive quattro ore e mezza. In barba ai vestiti da pioggia che ci è stato richiesto di portare, alle nove fa già caldo. Una seconda colazione a base di vino rosso, salame e formaggio servita poco prima delle dieci direttamente dal retro del furgone, rende la mattinata tutto sommato sopportabile. Ma dopo pranzo non c’è più scampo. Trenta, trentadue gradi. Il sole fisso in testa. Le vigne sono dei maledetti cespugli che non arrivano alla cintura. L’uva cresce praticamente a terra, mentre la fine del filare si perde nell’orizzonte infuocato. Se c’è mai stata una goccia di romanticismo nel venire a fare il vino in Francia, per le tre del pomeriggio è del tutto evaporata. Quel che resta è l’eco di una domanda, che sotto al sole si dilata fino a diventare un monolite scuro: ma io, cosa ci faccio qui?
Nel mio caso, dire che sono qui per il sussidio di disoccupazione è una risposta parziale. Volendo essere più precisi, sono qui perché con la disoccupazione di rimpatrio spero di poter godere di qualche mese di relativa tranquillità che mi occorre per trasformare la mia tesi di dottorato in un libro, cosa che mi è stata suggerita ma per la quale nessuno mi pagherà – anzi, più probabilmente sarò io a dover pagare per essere pubblicato. Sono qui anche perché tagliare l’uva sotto il sole a cinquantacinque euro netti al giorno è il lavoro meglio pagato che mi è stato offerto nei sei mesi successivi alla fine della borsa di studio. Una praticante avvocato, una costumista teatrale e un illustratore di talento, i miei compagni d’avventura raccontano storie simili. Tutti a cavallo dei trent’anni, con un buon titolo di studio e una buona esperienza nel proprio settore, guardiamo al sussidio come un’oasi nel deserto di opportunità lavorative che ci circonda. Ma, proprio come un’oasi, anche il sussidio finisce per rivelare la sua natura di miraggio.
Il sole fa brutti scherzi. Mentre mi fermo a prender fiato, attento a non farmi notare dal caposquadra, mi torna in mente la ciurma piratesca che anima il libro di Linebaugh e Rediker sui ribelli dell’Atlantico. Un proletariato transnazionale, inclusivo e multietnico, che sceglie il mare come strada per sottrarsi allo sfruttamento del nascente capitalismo mercantile. A parte l’esser “vestiti di stracci”, cosa resta in noi della soggettività antagonista che i due storici descrivono? Quanto coraggio c’è nella nostra scelta di vendemmiatori-per-caso, e quanto invece è una finta scelta, una deviazione obbligata, uno zuccherino ingoiato dopo l’ennesima cucchiaiata di letame? E non si tratta di rimpiangere l’etica lavorista, quanto di capire che l’accesso al reddito o è strutturale e universale o è poco più che una boccata d’aria mentre si sta per annegare. Sulle mance non si può costruire un’esistenza felice.
A giornata finita, un’occhiata alla home di Facebook, prima di crollare sulla branda, mostra il quadro di una katastròfa generazionale. Buona parte dei miei contatti posta selfie sorridenti tra vigne e trattori, cesoie e secchi pieni d’uva. Tra loro ex dottorandi, traduttori, precarie dell’università e della ricerca; musicisti, attrici e scenografi; grafici, fotografi e perfino una nutrizionista che lavora da anni a nero in uno studio medico. So che in fondo si stanno pure divertendo, come anche noi. Ma il punto è la possibilità di scegliere.
Anche i francesi intanto se la ridono e, mentre contano le ore che li separano da diciotto mesi di sussidio, si ha la certezza che – loro si – sono qui per la poesia della vita nei campi. Noi, pirati o mendicanti poco importa, il nostro sussidio ce lo prendiamo pure a morsi se occorre. Con la consapevolezza che non è un regalo, ma un misero acconto su quello che ci spetta. Uno sputo nel piatto dove doveva esserci la torta. (brian d’aquino)

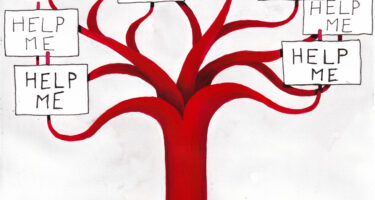



Ciao,
sarei interessato a vendemmiare in Francia, ha percaso ancora dei contatti?