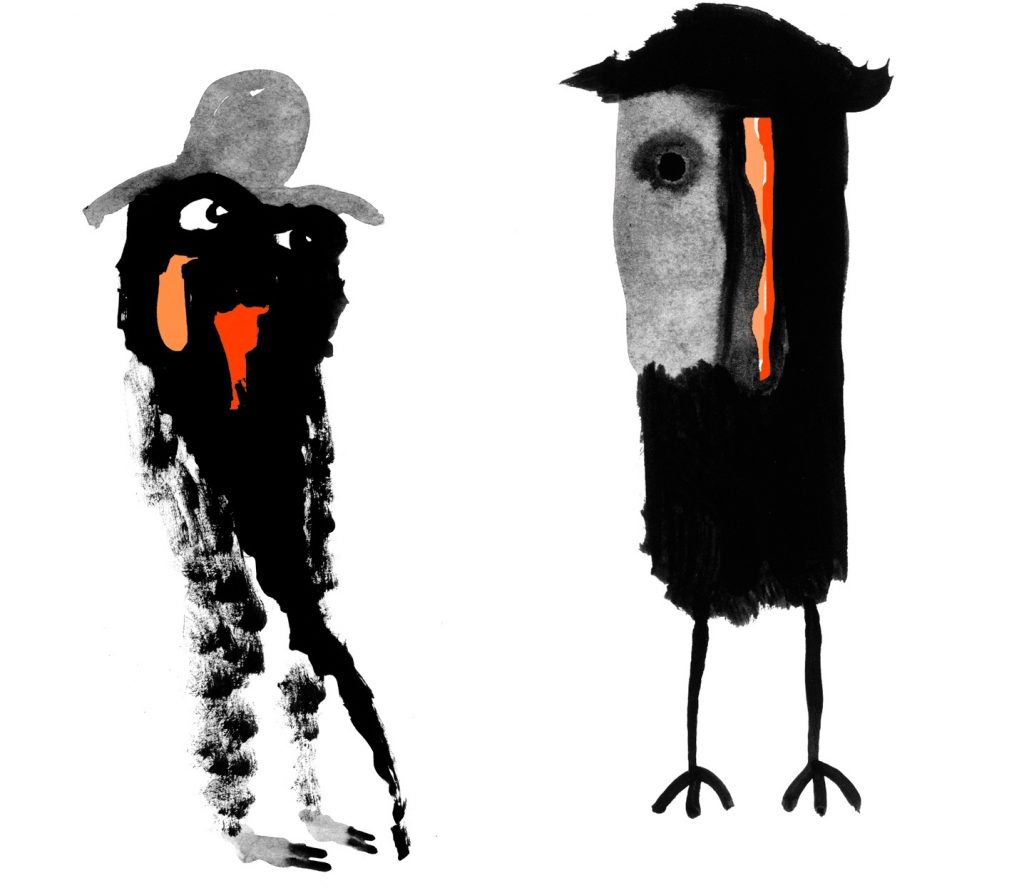
L’8 dicembre, festa dell’Immacolata di alcuni anni fa, il teatro dell’Asilo Filangieri era gremito: la scena era occupata da Daniele De Michele, supportato dalle musiche di Davide della Monica a interagire con le immagini diffuse su pedane in verticale. Si parlava di fare cibo secondo tempi altri che non la produzione in scatolame, a corredo dell’esperienza dell’orto della struttura di vico Maffei. Al tempo era ancora Don Pasta, un salentino che nell’intermediazione di suoni e immagini portava avanti una idea creativa di cucina, dove la composizione del piatto risultava dalla natura degli ingredienti e non dalla loro disposizione. Avrei letto poi il suo Artusi Remix, sperimentando (con poca fortuna) la ricetta delle melanzane alla amalfitana.
De Michele arriva a Napoli venerdì 16 novembre, in occasione della proiezione de I Villani, presentato alle Giornate degli autori della 75° Mostra del cinema di Venezia. A Napoli fa tappa ospitato da AstraDoc, alla prima stagionale di un percorso giunto ormai alla “doppia cifra” e che ha saputo avvicinare alle sale del cinema di Mezzocannone un pubblico proprio, in orari extraccademici, grazie a una programmazione ostinata e alla frequente presenza degli autori in sala. Il film di De Michele era atteso e all’appuntamento si era in tanti.
Ma il film è forse la cosa minore di tutto il lavoro di De Michele, una antropologia orale fissata dal potere della registrazione audiovisiva per ricostruire una memoria erasa dai nostri canoni di consumo; un lungo percorso coltivato insieme a tanti compagni, rivoltando lo stivale in lungo e in largo, muovendo dagli antichi valori dell’ospitalità e dell’accoglienza, nel minimo comune multiplo del donare e basta. Seguivo De Michele anche grazie alle immagini di Antonello Carbone, e alle pillole audiovisive che entrambi producevano: mi sembrava un contenuto importante negli spazi e nei tempi del social, laddove altri tipi di produzioni audiovisive legate al cibo andavano imponendosi nei broadcast televisivi. Ripartivano dalle parole di gente senza storia (secondo la vulgata della storia degli storici) eppure al pari testimone di un racconto altrimenti perso; un’indagine che partiva dai meno abituati al mezzo tecnologico, osservatore indiscreto delle loro azioni e delle loro parole. Qualcosa che si evince anche dal fatto che la voce in ascolto non è mai quella del regista, ma sempre la loro, di chi racconta e non di chi domanda, volontariamente omesso. Così il film mette la parola fine, per un nuovo inizio, a questa pratica del raccontare per suoni e immagini la radicalità di una vita in piena adesione ai tempi e agli spazi dell’ambiente.
Il carattere intimo della narrazione, la forza dei colori delle immagine scelte, l’attenzione al volto dei protagonisti di un documentario che rivendica la propria autonomia negli spazi del montaggio, sradica il pubblico dal solito cinema degli effetti, per riconsegnare a tutti noi – che poco prima di entrare in sala potremmo aver consumato un panino, una pizza, una bevanda prodotta in aperta contraddizione con quanto narrato – le ragioni politiche di una scelta di rottura verso l’apparato produttivo legato a quella catena (alimentare) che si nutre del solo consumo. Le storie sullo schermo rivendicano una esistenza possibile solo grazie alla solitudine e al sacrificio, e farlo vedere a Napoli significa qualcosa, in una città mai umile nei confronti della tradizione, che deve averlo smarrito nel mantra dell’identità insorgente. Così, il pubblico che sorride ogni qualvolta in scena compare qualcosa di paradossale, esorcizza la propria condotta morale sul cibo, avendo tutti noi in sala un rapporto con la terra quasi come luogo di safari, e mai luogo della nostra identità e cultura.
Le immagini del film raccontano il tutto senza far ricorso alle parole, con il silenzio dei protagonisti che ritma il portato audiovisivo; il lavoro sul paesaggio sonoro è fertile, in grado di far respirare immagini che non hanno bisogno di musica se non nei canti spontanei dei lavoratori della terra (altro luogo della memoria soggetto a rimozione, grazie alla leva di una musica che veste le orecchie facendoci stare tutti zitti). Adeguati i suoni, meno le musiche, con rigurgiti elettronici che tradiscono la natura artigianale della lavorazione. Altre volte i passaggi sono più consoni e c’è un legame emotivo tra quanto è pensato per gli occhi e quanto per le orecchie. La forza del racconto sta comunque nell’aperta contraddizione con il paradigma iconodulo del nostro fanatismo gastronomico.
Modesto, uno dei protagonisti del racconto di De Michele, proviene da Baselice, nel fortore beneventano. Si trova in sala, guarda il film, riguarda sé stesso sul grande schermo. Ci ricorderà poi che la cultura non è un libro di gala. (antonio mastrogiacomo)





1 Comment