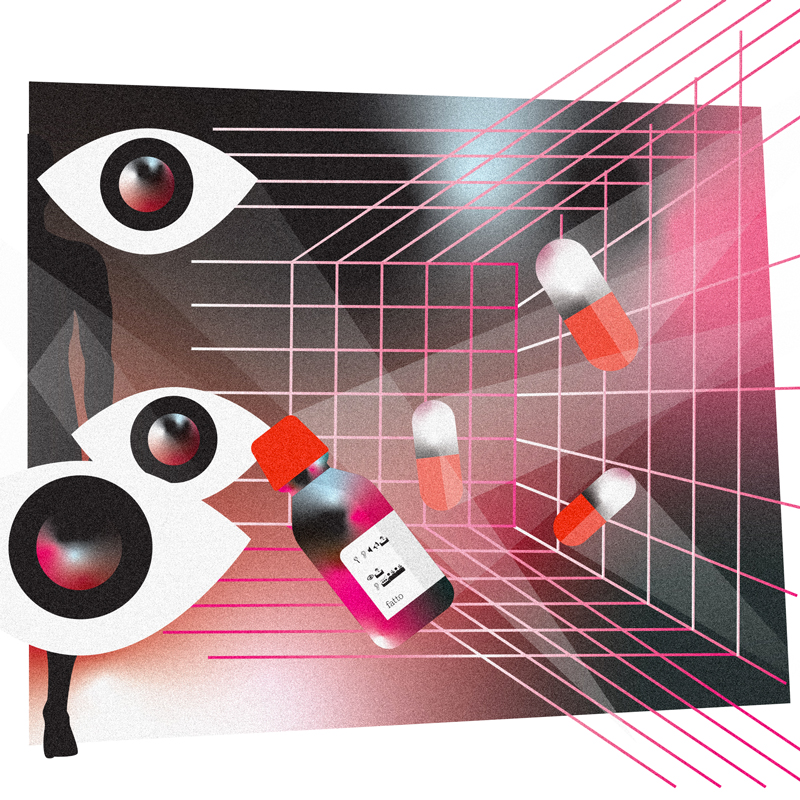
«Direttore, quanti detenuti assumono psicofarmaci?».
«Sono sincero… tutti».
L’appuntamento con la direzione della casa circondariale di Avellino è alle nove del mattino. Il carcere – come spesso capita con gli istituti di nuova generazione – è fuori dal centro città, in una contrada nel paese di Bellizzi Irpino. Chi viene da Napoli e non dispone di un’auto, deve prendere almeno un paio di autobus per raggiungerlo. La posizione degli istituti di pena è questione delicata: la collocazione di una struttura detentiva, oltre a restituire la storia e l’idea di pena che si vuole perseguire, ci racconta della capacità di intessere e mantenere i rapporti tra il “dentro” e il “fuori”.
La casa di reclusione “Antonio Graziano” è stata costruita poco prima del terremoto del 1980 e inaugurata quattro anni dopo. Il carcere è immerso tra le colline di noci e castagni a ridosso delle montagne che circondano la città. La struttura di cemento e mattoncini rossi – che ricordano quelli di un’antica casa di correzione inglese – è protetta da una doppia cinta difensiva, la prima con ringhiere di ferro arrugginite, la seconda fatta di muro spesso e vetri di protezione.
Subito dopo il primo check point (dove un’edicola di San Basilide, protettore degli agenti di custodia, accompagna l’ingresso ai metal detector) ci sono gli uffici dell’amministrazione, e dopo un altro cancello le sezioni di reclusione: alta sicurezza (As3), detenuti comuni, detenuti protetti, reparto femminile.
«Il carcere sta diventando un manicomio!», mi dice un agente di penitenziaria mentre attraversiamo la sezione di “isolamento disciplinare”, che in realtà somiglia più a un serbatoio di casi disperati: detenuti che si cospargono di feci, che manifestano manie persecutorie, che compiono atti di autolesionismo… È la punta d’iceberg di una sofferenza strutturale che non trova alcuna attenzione da parte del Dipartimento di salute mentale territoriale. Gli psichiatri arrivano in carcere – se va bene – una volta al mese, mentre gli psicologi sono a disposizione dei seicento detenuti solo per diciannove ore totali. Le “gocce” per dormire, invece, vengono date indiscriminatamente e in assenza di diagnosi.
L’isolamento carcerario racconta per lo più storie di uomini travolti da disagi psichici intercettati solo al loro culmine: la marginalità diventa fattore di criminalità, semplificando in maniera elementare il piano delle contraddizioni nelle nostre relazioni sociali. I reati sono per lo più violenze in famiglia, aggressioni, oltraggio a pubblico ufficiale. La sfera penale ha il compito di fornire la soluzione più semplice e immediata al problema. Qualcuno ha oltrepassato la linea e va punito con il carcere.
Il reparto di isolamento si trova alla fine di uno dei bracci della struttura “a palo telegrafico” (un unico corridoio in cui si innestano diversi moduli). È stato da poco ristrutturato, per cui non ci sono più i bagni a vista e sono state eliminate le infiltrazioni nelle celle. La risistemazione dell’edificio, strappata a fatica dal bilancio dell’istituto, ha coinvolto anche altre sezioni con l’obiettivo di introdurre le docce in stanza. Ne rimangono sprovvisti soltanto il femminile e l’alta sicurezza. È nella prassi, d’altronde, che si testano le nuove tecniche di tenuta della sicurezza interna. Nell’ultimo triennio, per esempio, quasi tutti gli istituti hanno iniziato a dotarsi di una sezione destinata ai detenuti “articolo 32”, ovvero quelli che hanno mostrato particolare avversione al regime detentivo.
Lo spiega in maniera chiara, in una circolare datata giugno 2019, lo stesso Dipartimento di amministrazione penitenziaria: “Come è noto, il Dipartimento – condividendo alcune delle argomentazioni rappresentate dal personale della polizia penitenziaria per tramite delle organizzazioni sindacali – ha sentito il bisogno di proporre nuovi modelli di gestione della popolazione detenuta, unitamente a nuovi e più attuali progetti di definizione delle piante organiche degli istituti. Proprio nel solco delle proposte di riassetto gestionale […] deve innestarsi il contributo degli uffici provveditoriali per ciò che concerne l’individuazione di nuovi spazi detentivi di Alta o Media sicurezza, ovvero per ciò che riguarda l’ottimizzazione dei circuiti detentivi all’interno degli istituti. Le informazioni in possesso del Dipartimento permettono di affermare che: a) sussisterebbero soluzioni sfruttabili, idonee ad attuare azioni di parziale alleggerimento delle quantità e delle presenze detentive nelle carceri; b) potrebbero essere adottate proposte di diversa classificazione, con il recupero di nuovi spazi, pur nel rispetto della territorialità della pena o delle esigenze trattamentali o sanitarie”.
Una delle possibilità di questo riassetto sta nel fatto che le celle di isolamento disciplinare manterranno solo in via residuale il loro fine storico, quello di raddrizzare la schiena del “detenuto irascibile”. Negli istituti che non hanno articolazioni psichiatriche, potranno con facilità, se necessario, essere trasformate in bracci assai più simili a quelli manicomiali.
Continuo ad attraversare l’istituto accompagnato dalla penitenziaria. La configurazione cambia da un braccio all’altro, ma ci sono alcune costanti. Quella principale è il ferro, che riporta alla mente l’era delle carceri d’oro di inizio anni Ottanta, quando con la costruzione dei nuovi edifici si realizzarono profitti enormi. Ancora oggi gli scheletri di ferro pesante si poggiano a incastro sui cortili interni che dividono le aree delle sezioni, ma di ferro arrugginito sono anche alcune parti del vecchio padiglione (quello dove sono imprigionati i detenuti che non mostrano una progressione trattamentale, in particolar modo dal punto di vista della socializzazione e della “rieducazione”).
Nel femminile sono recluse trenta donne. Per ragioni di sicurezza il reparto si raggiunge soltanto dall’esterno («Maschietti e femminucce hanna sta’ divisi…»), anche perché l’edificio è separato dagli altri. Incrocio gli occhi di una ragazza che avevo conosciuto all’istituto di Pozzuoli in uno degli incontri dello sportello di Antigone. Sopraggiunge un po’ di imbarazzo tra me e lei per la presenza del Comandante, ma ci capiamo con uno sguardo e le immagini dei nostri colloqui irrompono in silenzio, in un istante: le richieste per mantenere le relazioni con la famiglia, il bisogno di gestire la tossicodipendenza, il desiderio di andare via da Pozzuoli. Ad alcune di queste istanze siamo riusciti a fornire delle sponde, poi una volta trasferita la donna, ognuno ha ripreso a rincorrere la propria vita.
Siamo nel reparto. Una ragazza un po’ agitata si avvicina per chiedere udienza al Comandante. Dice di aver bisogno di modulare nuovamente la terapia perché non riesce a dormire: «Tengo l’ansia, e il dottore non si fa vedere da sei mesi». Spesso ho sentito descrivere dai detenuti il proprio stato emotivo con la parola “ansia”, un modo unico per raccontare l’arcipelago infinito delle emozioni sofferte: il dolore di una morte non salutata, la separazione da un compagno o una compagna, la nostalgia di un figlio o la voglia di averlo, il desiderio (a volte ossessivo) di fare l’amore. Tutto è ansia e per l’ansia servono le gocce.
Se è vero che il sovraffollamento rallenta ogni procedura di gestione interna, l’elemento più fragile di questa complessa macchina è proprio quello sanitario. Patologie cancerogene lasciate alla gestione dei medici di guardia (duecentoquaranta ore mensili), disabilità articolari, malattie infettive sepolte nel quotidiano assordante e ossessivo del recluso. Il punto è talmente critico che qualche magistrato di sorveglianza ha ritenuto di inviare un fascicolo alla Procura della Repubblica. La sanità campana è in ginocchio, ma il fardello maggiore è scaricato sugli ultimi, e tra questi ci sono i detenuti, i quali a differenza di altri non possono che attendere. Poche e isolate sono le spinte per la creazione di un coordinamento regionale tra i direttori delle Asl, le direzioni degli istituti e le rappresentanze del corpo detenuto, così come per la predisposizione di strumenti idonei a concretizzare il superamento della vecchia medicina penitenziaria. Basti pensare, per avere un’idea di quanto il piano della vita reale all’interno degli istituti sia lontano da quello normativo, che sono serviti undici anni per creare un sistema di prenotazione delle visite specialistiche (con attesa minima di circa otto mesi) interno al carcere.
Sono quasi le due di pomeriggio quando lascio il carcere. Di fronte all’istituto un piccolo capannello di gente è al chiosco che offre caldarroste e riparo in attesa dei colloqui. Il quotidiano dei familiari racconta di un inverno rigido in arrivo, bambini che non fanno i compiti e «vogliono solo giocare a pallone». Mi allontano mormorando un saluto, lasciando le persone e le loro storie in compagnia delle colline a ridosso del Partenio. (luigi romano)





Leave a Reply