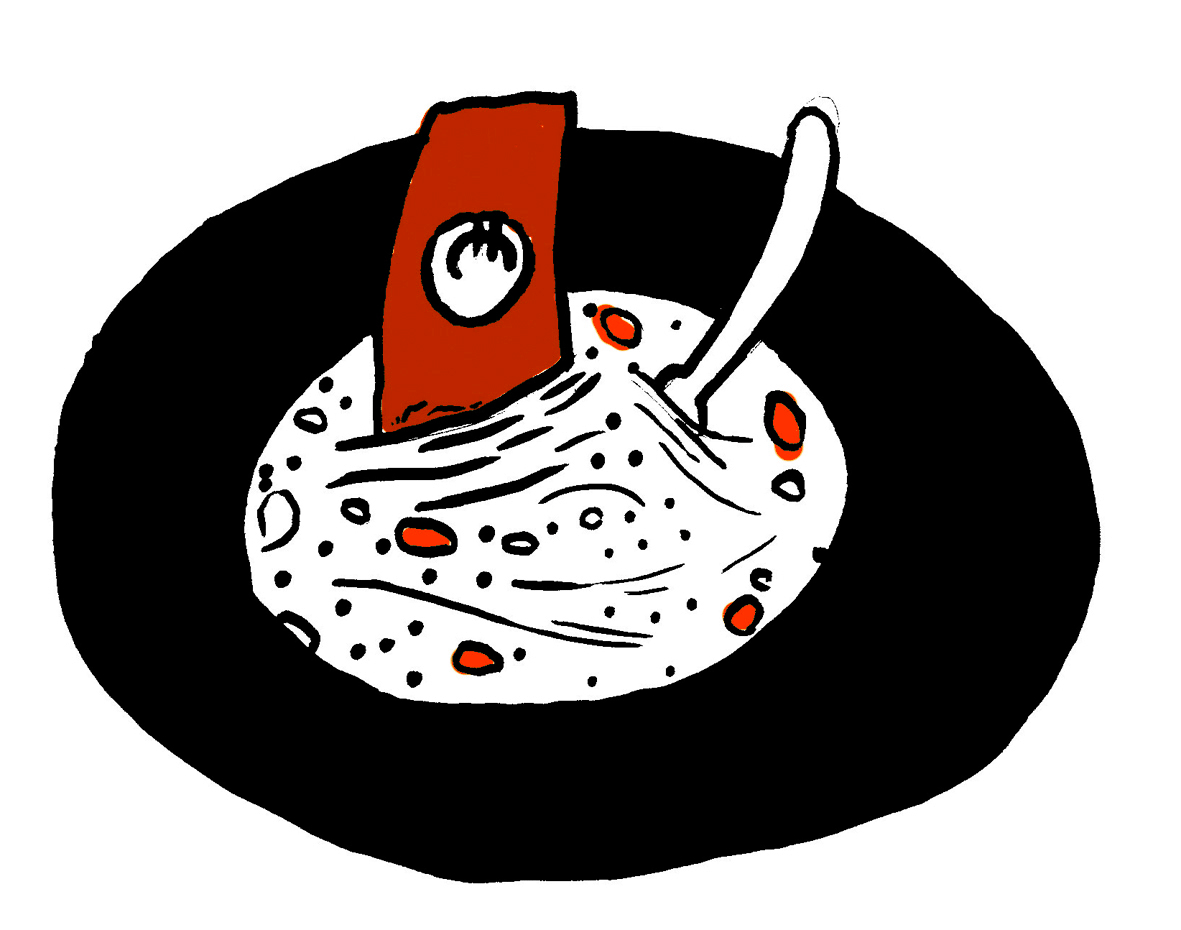
Pubblichiamo a seguire il testo apparso sull’ultimo numero (primavera 2016) di L’almanacco de La Terra Trema, rivista trimestrale di vini, cibi e cultura materiale. L’almanacco è una pubblicazione periodica autofinanziata, organizzata dal gruppo La Terra Trema di Milano, a partire dal novembre 2015.
Per altre info, clicca qui.
Sono uno che ha smesso. E come tutti quelli che smettono vado preso un po’ con le pinze. Non troppo sul serio. Quelli che finiscono la terapia con gli alcolisti anonimi o gruppi analoghi spesso li trovi che hanno sostituito il bicchiere pieno con quello vuoto. Stessa attenzione, stessa idolatria. Ma io ho smesso da solo. E non certo di bere. Quelli che abbandonano il fumo guardano con disprezzo i rimasti con la sigaretta in mano e celebrano l’aver ritrovato fiato e olfatto e persa l’ansia da tabaccaio aperto. Ma io non è che ho lasciato proprio: ho fatto del cibo buono e del vino buono un fatto privato. Ho finito di recitare nei film porno, non di fare all’amore. Sono due cose diverse, magari simili nella tecnica, ma distanti nella sostanza. Avevo cominciato a scrivere di cibo e di vino prima che comparisse quella parolaccia impronunciabile: enogastronomia. Non esistevano i prodotti tipici, le persone che facevano le cose buone e fatte bene spesso sbarcavano il lunario a fatica e non avevano un brand, al massimo un’insegna. Nei ristoranti c’erano i cuochi e le cuoche. Poi i primi sono diventati chef, le altre hanno avuto almeno il pudore semantico di rimanere cuoche. Un punto in più per le donne.
Avevo cominciato per tre motivi. Il primo: un articolo bellissimo di Giuseppe Fava. Sulla sua rivista I Siciliani, raccontava di donne vestite di nero, salsicce focose e vini densi alle pendici dell’Etna. Lì avevo capito che si potevano usare i sapori per raccontare la terra, la gente, la vita. Secondo: facevo l’inviato in giro per l’Italia per una rivista di pesca sportiva (certo, esistevano pure quelle). Viaggiavo e mi spostavo raccontando ai lettori dove andare a pescare. Nelle valli solcate da torrenti quasi sconosciuti, nei paesi affacciati su laghi dai nomi ignoti, nei luoghi più anonimi della nazione ma provvidenzialmente bagnati da qualche corso d’acqua, visto che c’ero, dovevo mangiare. Questo rendeva il mio lavoro un po’ più curioso. Avevo avuto una nonna cuoca e uno zio protogourmand, uno che cercava i prodotti tipici prima che esistessero. Lo faceva per piacere. Si sarebbero divertiti insieme, lo zio Piero e Luigi Veronelli, ne sono certo. Insomma, per imprinting parentale ero curioso di quello che mangiavo. Ed essere in luoghi quasi dimenticati mi permetteva di scoprire l’essenza della cucina italiana, da sempre locale, regionale, dei prodotti e dei sapori che nascevano nel Mondo dei vinti di Nuto Revelli e finivano nelle vetrine di Peck a Milano. La città che si mangia tutte le terre intorno, in senso fisico non metaforico, è ben raccontata da Carlo Emilio Gadda in Le meraviglie d’Italia – Gli anni. Basta leggere Una mattinata ai macelli e Mercato di frutta e verdura. Non c’è bisogno d’altro per capire la materia.
Il terzo motivo per cui scrivevo di cibo era perché non ne parlava quasi nessuno. E chi lo faceva aveva spesso motivi diversi dall’indagine e dal racconto. A me piaceva quel clima un po’ carbonaro che aleggiava attorno alla cultura materiale italiana. Roba di poveri trasformata per la gioia dei ricchi. Lo sapevo bene: io stesso da ragazzo vendevo i funghi e le trote alla trattoria di un paese di montagna perché se ne beassero i cittadini (non che io non lo fossi, cittadino, ma mi piaceva mescolarmi con la gente che non lo era).
I maestri capaci di trasformare la fatica contadina in delizia per le classi privilegiate erano loro, i cuochi. Non quelli popolari delle vecchie trattorie agli incroci delle strade, ma gli eredi di quelli arrivati direttamente dalle aristocrazie. Rimasti disoccupati dopo la rivoluzione francese erano stati loro a inventare i ristoranti, nient’altro che specie di teatri dove mettere in scena il buon cibo. In fondo, credo, per molto tempo, l’alta ristorazione è stata alla necessità di mangiare fuori, come il teatro borghese al teatro.
Ce ne siamo accorti tardi che gli spettacoli cominciavano a degenerare: non abbiamo capito subito che dare un nome alle cose (denominarle doc, dop, igp o in qualsiasi altro modo) le avrebbe private di sostanza. Non abbiamo compreso in tempo che contava più la rappresentazione della realtà. Che le rane non erano più espressione del territorio perché arrivavano dalla Turchia e non erano più cucina tipica, ma simulacro. Non abbiamo colto al volo che maturare i prosciutti nelle celle a temperatura e umidità controllata significava togliere per sempre valore e importanza all’aria dei luoghi di stagionatura. Non abbiamo compreso subito che il pollo era diventato cattivo non perché ci avesse annoiato ma perché era passato dall’aia agli allevamenti in batteria. Non abbiamo capito. Non ho capito.
Così come ci sono sfuggiti di mano gli aggettivi: bastava un bravo, per un cuoco. Siamo arrivati al superbo, sublime, divino, magistrale, per uno chef. Sono diventati dei divi. Come con i calciatori abbiamo fatto finta di nulla quando li sentivamo sbagliare i congiuntivi. Mica occorre conoscere la lingua per far bene da mangiare, così abbiamo pensato. Senza immaginare che era il primo passo: avremmo nominato ambasciatori di un paese trasformato in un grande teatro del gusto, delle persone che tra acqua e sale non sanno con precisione quale delle due evapori. Non ce l’ho con i grandi nomi della cucina. Non è questo il problema. Ne ho conosciuti tanti: qualcuno è davvero un grande artista, ma, come gli altri, viene considerato solo se si esibisce in modo che sembri un pagliaccio. I più, comunque, sono pagliacci che si credono artisti. Da anni mi accorgo che tutto quello a cui abbiamo dato un nome è diventato finto, un simulacro, una bugia. È successo nel cibo quello che già stava avvenendo nel mondo del vino. Ed è accaduto in Italia che pensavamo fosse il cuore della tradizione culinaria.
Anche per il cibo valgono ormai le parole di Guy Debord in Panegirico: “La maggioranza dei vini, quasi tutti i liquori, e la totalità delle birre di cui ho evocato qui la memoria, hanno oggi completamente perduto il loro gusto, prima sul mercato mondiale, poi localmente: con i progressi dell’industria, come col movimento di sparizione o rieducazione economica delle classi sociali che erano rimaste a lungo indipendenti dalla grande produzione industriale; e dunque anche per il gioco delle diverse legislazioni statali che vietano ormai quasi tutto ciò che non è fabbricato industrialmente. Le bottiglie, per continuare a vendersi, hanno fedelmente conservato le loro etichette, e questa esattezza garantisce che le si possono fotografare com’erano; non berle”. Al cibo, al cibo italiano, credo sia successo lo stesso. Tutto è merce e nulla di più. Come nel porno, appunto. Non che sia necessariamente brutto, può essere anche divertente. Io, però, del buon cibo, del vino contadino, della terra, della fatica e di quel mondo lontano dalla plastica mi ero innamorato.
Non so se quello che è accaduto sia sbagliato o sia giusto. In fondo ha allargato un certo benessere o comunque l’idea di un certo benessere, anche alle campagne, alle montagne e a quelle botteghe marginali dove un po’ scarseggiava. Ha portato il marketing là dove c’era il mercato settimanale. Tutto questo ha trovato nuovi aggettivi e nuovi profeti. Non ultimi gli chef con le stelle. Ho spento l’ultima volta la televisione nel 2004, non ne ho sentito, a venire, nessuna mancanza. Ho letto più libri, passato più tempo coi figli e con gli amici. E proprio mio figlio me li ha fatti vedere quelli di Masterchef, imitati da Maurizio Crozza, su YouTube. Pensando agli originali, la parodia credo che li renda più umani.
Come ho detto all’inizio, ho smesso. Un pezzo alla volta. Prima ho chiuso l’ultima pagina che raccontasse di cibo e di vino. Poi non sono più andato al ristorante. Infine mi sono guardato dall’andare a mangiare fuori tout-court. Mi regalo solo una pizza ogni tanto; è un antico amore. Per la socialità ho risolto invitando gli amici a cena. La salute ne ha guadagnato e ringrazia. Il portafogli pure. Con quello che risparmio posso permettermi di non andare al supermercato. Ho un contadino che mi porta le verdure a casa, quello che c’è va bene. Imparo da lui cosa cucinerò. Quando sono in città di mare vado al mercato, dai pescatori. Di carne ne mangio assai poca, ma ne conosco la filiera intera, non perché ci sia scritta su un fogliettino, magari sullo scontrino, ma perché sono andato a vedere dove e come crescono gli animali che mangio. Ne sono testimone. Non sempre sono sobrio: “Write drunk, edit sober” diceva Ernest Hemigway mentre Gino Veronelli sosteneva che “il peggior vino contadino è migliore del miglior vino d’industria”. Ecco, quello è il solco nel quale credo sia bello restare, col passo del vagabondo e un sogno grande nel cassetto: ritrovare certe osterie della memoria dove i vini non hanno nome ma fragranza, sul tavolo passano le cose del luogo, nella giusta stagione, le verdure sono quelle dell’orto, le carni sono di animali vissuti come si deve, di uccelli sparati al volo da un cacciatore poeta, i pesci quelli del mare o del fiume, a seconda di dove si trovi il locale. In cucina c’è una cuoca. Miracolosamente un cuoco. Si riconoscono entrambi dal grembiule. E dalle mani in pasta. Un luogo così sarebbe già la rivoluzione. (michele marzani)


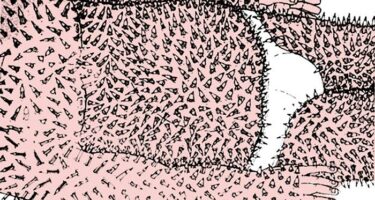


Leave a Reply