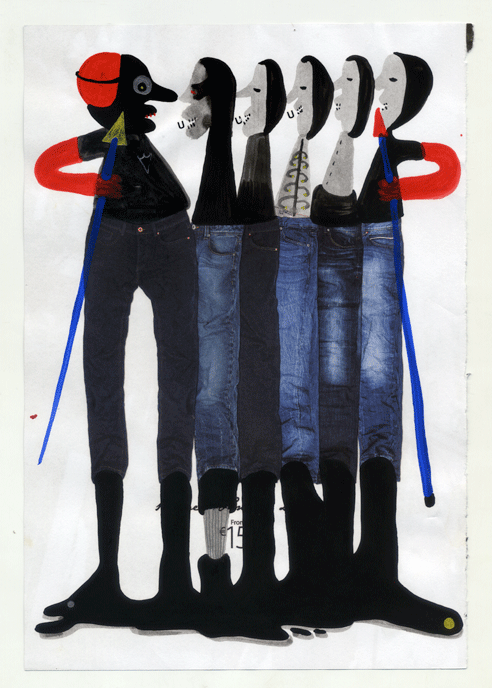
Tutti in giro la chiamavano Wendy, ma chiunque ignorava che il suo nome di battesimo era Wanda. Quando una sera, seduti a terra sfiniti sotto ai portici del Banco, uscì il discorso intorno al suo nome, nessuno ci credeva. Eppure così stavano le cose, e a noi ogni cosa insolita allora ci pareva scandalosa. Alla mamma di Wendy piaceva una vecchia canzone di Paolo Conte. “Paolo chi?”. “Quello di Izzwonderfull – rispondeva lei –. Non lo conoscete?”. Il suo sorriso beffardo sbiadiva la nostra collera adolescenziale. Nel frattempo, Wendy si faceva notare. Già alle scuole medie le urlavano dietro, sicché dovette presto imparare a difendersi da sola. E quando diceva alla mamma che la prendevano in giro, lei non sapeva cosa risponderle. Abitava in un appartamento minuscolo di un palazzo fatiscente in via Roma, di mestiere faceva la parrucchiera. Wendy era alta, aveva gli occhi neri accesi, vigili, che nascondevano una gentilezza repressa dalle condizioni ambientali in cui era destinata a crescere. Frequentava il quarto anno del liceo scientifico. Era insicura ma elaborava nella sua testa domande alla ricerca di risposte. Perché mio padre se n’è andato di casa lasciandoci sole? Perché non trovo neanche un lavoretto di merda? Perché la scuola mi sfianca? Perché questi maschi si ostinano a imparare dei passi così difficili? E quegli altri lesionati che mi sbavano appresso e che fumano dalla stagnola?
Per noi quattordicenni esisteva solo una passione. La sua attenzione sprezzante ci rendeva arzilli e motivati. Eravamo osservati da una femmina più grande di noi che ci studiava per capire fino a che punto potesse fidarsi. Per farla incazzare la provocavamo: tu sei una femmina, Wendy. Lei ribatteva colpo su colpo, dicendo che noi eravamo dei ricchioni scoordinati. Con quelle tute acetate, a furia di provare quei passi a terra, pulivamo a poco a poco tutto il pavimento sotto ai portici. Avremmo dovuto chiedere al Comune un posto come operatori ecologici. Disprezzandoci ironicamente a vicenda, sapevamo bene quanto fossimo attratti gli uni dall’altra. Meglio: sapevamo dentro di noi che era una questione di esempio reciproco. Lei con la sua arguzia, noi con la nostra ostinazione. Alzavamo il volume dello stereo a pile, e con i Gravediggaz di sottofondo, appena scoperti grazie a Corrado il Masto, cercavamo di imparare il turtle, che era come imparare a volare.
Quel posto era un’estensione della nostra casa. Ci eravamo affezionati. Avevamo pure passato la cera a terra per scivolare meglio sulla schiena; avevamo cucito delle retine verdi sui cappelli di lana per girare sulla testa, ma quella roba dal vivo l’avevamo vista raramente, al massimo l’avevamo studiata nel vhs della Battle of the year del 1995, facendo rewind migliaia di volte e mandando il video al rallentatore nella sfida finale, perché non riuscivamo a capire come riuscissero quei tizi a fare certe malattie volanti.
Poi con il tempo capimmo. Ci attirava piuttosto l’idea di un gruppo su cui contare, di una condivisione al di là del bene, del male e della mercificazione. Istintivamente ci ripugnava quel collasso cognitivo in corso per mezzo della rete, l’idea di affrontare da soli quel misto di disgregazione sociale, marginalità e innovazione tecnologica. Da quell’esercizio quotidiano per terra imparammo molto di più che dei passi magici. Scoprimmo innanzitutto che bisognava partire da raso terra, dal suolo appunto, dal suono, dal ritmo e dal pavimento sporco. Da zero. Se avessimo avuto già allora la consapevolezza politica, avremmo detto che bisognava partire dal basso, che la strada più difficile era anche la più giusta. Capimmo che la perseveranza avrebbe prima o poi dato i suoi frutti, che contava lo sforzo più che il risultato, che certi limiti si potevano e si dovevano sfidare. Imparammo anche la differenza fondamentale tra lo stile e la tecnica quando vedemmo ballare Crash Kid, morto giovanissimo un anno prima.
Sempre meglio che farsi le seghe. Eravamo alle prime armi con il mondo e avevamo la ritirata alle serate organizzate dai grandi. Le riviste porno cedevano a fatica il posto alle copie di Aelle che ci passavamo di mano in mano. Concentravamo l’attenzione sui gruppi che ci facevano ascoltare i dj durante le jam, e soprattutto avevamo vergogna. Vergogna del nostro provincialismo, della nostra età, della nostra voce e del nostro corpo. Quella danza urbana era un potente antidoto, ci dava un orientamento nella giungla preparandoci alla battaglia, ci garantiva una fragile possibilità di esprimerci e di fare i conti con quella vergogna.
A me insegnava anche l’autodisciplina, che poi era la stessa cosa che diceva Robertino in altri termini durante le lezioni d’italiano, anche se lui a quella danza non dava alcuna importanza: lui continuava a ripetere che la disciplina, se non te la dai tu da solo, te la imporrà qualcun altro. Un padrone molto probabilmente. Nella migliore delle ipotesi. Un datore di lavoro in un territorio che interpreta le leggi dell’economia secondo i princìpi del capitalismo di rapina. “Ti servirà un metodo”, diceva. Lui il barbone di Treviri se l’era letto con attenzione, la realtà la studiava mentre noi ci ostinavamo a inquadrarla attraverso quella danza con le mani e la schiena per terra; sottovalutava più di Wendy la nostra passione verso la coreografia del reale, forte delle sue letture. Un giorno, dopo essere andato a Napoli a trovare mia nonna, girovagando per il centro alla ricerca di musica, lo incontrai per caso. Mi portò in una libreria di Port’Alba, cercò un libro tra gli scaffali. Lo trovò: Ágota Kristóf, Trilogia della città di K. Prima di darmelo, nella prima pagina scrisse: “Per A., affinché non smetta mai di amare e lottare. Ovvero resistere”.
Wendy andava avanti a frequentare come noi i portici del Banco di Napoli. Eravamo ancora troppo inibiti per guardarla dritto negli occhi. Assecondava le nostre provocazioni infantili ricambiando con la stessa moneta. Con il tempo altra gente si accorse di quell’angolo di città. La sera, una volta tornati a casa dopo quelle feste che lasciavamo quando iniziavano, davanti a un computer ci saremmo connessi a internet – di notte costava meno – e avremmo cercato la musica su Napster per ore. Era una magia. I nomi da ricercare si scrivevano a penna su un foglietto di carta. Black helicopters dei Non-Phixion, Iron galaxy dei Cannibal Ox. Un programma in televisione mostrava il video di un paio di afroamericani che rappavano dentro a una fogna con le torce infuocate in mano. Gente che corre, cerotti sulle guance, maschere antigas, scarpe nelle pozzanghere, rime che seguono un flusso come picconate in una miniera di carbone. Era perfetto. Chi cazzo sono questi? Wendy pure rimase colpita quando sentì quel beat uscire dallo stereo a pile, mentre ci ostinavamo a imparare senza speranza l’headspin. “I Das Efx!”. “Voglio imparare a ballare pure io”.
La cosa ci spiazzò in un primo momento, poi ci accorgemmo che Wendy era più insicura e curiosa di noi, alle prese come noi con l’identificazione del nemico da combattere a vita. Quel nemico senza volto che aveva invaso la terra e che nel fumetto dell’Eternauta chiamavano Loro. Il rap aiutava a dare un volto all’avversario nella folla, era la risposta che Wendy cercava.
Un giorno venne sotto al Banco un tale appena tornato dalla Francia che Wendy conosceva. Portava con sé una musicassetta della Brigade. La inserimmo nello stereo. Non si capiva niente ma ci piaceva, ispirandoci passi nuovi che perfezionavamo a furia di sbagliare. Apprezzavamo l’idea di un collettivo che remava nella stessa direzione. Una brigata. Wendy ascoltava immaginando come sarebbe andata. Non la convinceva quel ritmo. Diceva che andavamo contro tempo, che il tempo era tutto e che il tempo era più lento di noi. Dovevamo provare con Afrika Bambaataa e con James Brown, diceva.
L’economia si ristrutturava in maniera repentina e lontano scoppiava un’altra guerra imperialista, quando andammo a occupare insieme agli altri del centro sociale una scuola abbandonata. Avevamo bisogno di uno spazio di azione politica. Tre settimane e il desiderio di rivolta crollò su se stesso, ma in compenso avevamo aperto un po’ gli occhi. Al Banco un giorno scoppiò una rissa a bottigliate e fummo costretti a sloggiare. Le pile dello stereo cominciavano a scaricarsi.
Wendy voleva mettere alla prova le sue capacità e noi, situazionisti involontari, la lasciavamo fare. “Ascoltate questi – diceva –. Li ho scoperti tramite mia cugina che vive in Francia. Si chiamano Fonky Family”.
Alla vigilia del Duemila prendemmo armi e bagagli e andammo via da là. Avevamo anche noi il nostro Arco di Trionfo, adesso. Piazzammo un linoleum a terra preso in un negozio di ferramenta e ricominciammo da dove avevamo lasciato, ostinati e testardi, a cercare d’imparare i powermoves sotto a un monumento in marmo bianco fatto costruire nel periodo fascista per ricordare i concittadini caduti nella Grande Guerra. “Che schifo – diceva Wendy –. Io i fascisti li odio”.
E pure noi. Alle nostre spalle un’area verde immensa e abbandonata. Sopra le nostre teste, una statua rappresentava la vittoria e la libertà di una storia che non ci apparteneva. In cima all’arco una scritta. La strada era lunga e in salita. Sventurata è la terra che ha bisogno di eroi. (pomè)





Leave a Reply