
I fatti narrati risalgono al periodo 2012-2015 nel quale ho svolto la mia attività di operatrice volontaria in un servizio campano per le dipendenze. Sono raccolti in un diario e non seguono alcun ordine cronologico. L’esperienza è terminata, ma continuando a confrontarmi con chi lavora sul campo posso affermare che le condizioni descritte sono rimaste quantomeno immutate.
* * *
Il nostro “padrone” […] il corpo cessa di diventare proprio
per diventare una cosa del “padrone”.
Il tossicomane come “addetto alla droga”,
come si dice di qualcuno che è “addetto” a qualche mansione,
qualcuno che organizza tutta la sua esistenza intorno a questa mansione. […]
La segregazione nel campo della salute mentale è proprio questo:
l’idea che si possano trattare i soggetti più facilmente
se li prendiamo dal lato “categorizzante”,
cioè segregante, del consumo di una certa sostanza.
Avremo così, gli alcolisti, gli eroinomani, i cocainomani e così via. […]
La droga non è un sintomo ma bensì qualcosa che “vela” il sintomo,
cioè la formazione di un compromesso assolutamente singolare
su cui si attiene un soggetto.
La droga fra clinica e discorso sociale, tre lezioni su Lacan e la tossicomania, Graziano Senzolo, 2011
TRA UNA PIAZZA CENTRALE E UNA STRADA INDUSTRIALE
La pertinenza del servizio copre un’area estesa e multiforme della città. Da luoghi considerati ancora centrali, si estende verso aree industriali (per lo più abbandonate) e penitenziarie. Aprendo Maps di Google la prima immagine che trovo è la fotografia di una statale ricoperta da sacchetti di spazzatura. Il servizio è confinante con abitazioni private. I locali sono sempre stati di proprietà dell’Asl e fino agli anni Novanta erano destinati ad altro uso. Nonostante i cambiamenti effettuati si intuisce che vi erano ambulatori separati e contrassegnati da targhette di metallo di cui, oggi, restano i buchi delle viti al muro e gli aloni. Le visite si prenotavano al piano terra e, in effetti, dove oggi c’è il gabbiotto della guardia giurata, ci sono (ancora) le vetrate sporche e in disuso da cui si rilasciavano pratiche in entrata e uscita.
Il servizio non nasce in questo stabile. In seguito alla legge 162/1990 (che istituiva la nascita dei servizi pubblici per le tossicodipendenze), in un edificio poco distante, oggi grande struttura ricettiva, era già presente una odierna Uosm, l’Unità operativa di salute mentale [1]. Qui, un piano fu adibito per il servizio. In seguito, all’incirca nel 1992, fu stabilito che “i Sert dovrebbero essere tutti oggi inseriti nei Dipartimenti delle dipendenze e godere di autonomia tecnico-gestionale, essere ben distinti e non inglobati nei Dipartimenti di salute mentale e avere un assetto organizzativo autonomo e di tipo strutturale, avendo quindi un proprio budget e una propria responsabilità di spesa” [2]; così il servizio fu trasferito dove si trova oggi. Relativamente al budget e all’autonomia di spesa, per quanto ne so, al momento sono duemila gli euro da spendere. Uno psicologo in proposito, mi dice che «era meglio stare lì, ci si conosceva tutti tra i piani del palazzo, ci incontravamo tra operatori del Sert e operatori di salute mentale e ci confrontavamo. Inoltre, la nostra guardia giurata era una specie di portiere, conosceva la vita di ogni piano e smistava tutto dall’ingresso». Al mio arrivo nell’attuale sede il dirigente era un medico. Da meno di un anno il dirigente è uno psicoterapeuta.
Entriamo. Al piano terra stazionano alcuni senza fissa dimora. Tranquilli. Certo, ogni tanto bisogna scendere perché vogliono bere, fumare o pisciare nel servizio, ma per il resto sono anche di compagnia. Dopo la prima rampa di scale si accede alla sala d’aspetto per l’utenza, che in realtà è un corridoio scarno dalle pareti celestine, con una piccola panca di legno e nessun arredo alle pareti. Alcuni utenti mi dicono che avrebbero piacere di vedere al muro «quadri di pittura». Inoltre, non c’è nessun cartello che indica la presenza di una biblioteca alla fine del corridoio. Subito dopo vi è la “stanza del metadone”, nella quale, però, ci sono anche altri elementi e avvicendamenti. Tale stanza era destinata ad altri usi e ci sono, ancora oggi, lunghi raccoglitori metallici arrugginiti che contengono le cartelle cliniche degli iscritti ai piani terapeutici del servizio.
Al secondo piano vi sono le stanze della dirigenza, degli operatori, per le riunioni e il bagno dei non utenti. Nei primi anni il personale impiegato era ampio, in opposizione alla carenza odierna di organico [3]. Al momento dell’istituzione vi erano dai sette ai nove medici, dai cinque ai sei psicologi, dai tre ai quattro assistenti sociali, dai quattro ai cinque infermieri. Tutti in un sistema di turnazione. L’équipe oggi è ridotta alla metà e l’infermiere che fa fronte a ogni compito è uno.
Talvolta, il clima è folle.
Il personale era stato assunto sul territorio, data anche la presenza di un istituto penitenziario che rientrava tra i luoghi di competenza del servizio. In effetti, uno dei medici ha alle spalle circa dieci anni di esperienza proprio in carcere. Mi dirà: «Oltre ai tagli economici, alcuni soggetti hanno effettuato lotte intestine per farsi trasferire o andare via da qui. Tutti provenivamo da esperienze che si avvicinavano a un contesto di questo tipo, ma non c’era una vera e propria cultura di servizio per le tossicodipendenze, oggi dipendenze in senso ampio. L’attività in carcere aveva ritmi più rilassati, il detenuto arrivava portato dalle guardie carcerarie. Inoltre, il metadone in carcere non esisteva. Dal 1994-95 iniziò anche un sistema di turnazione dei medici di questo servizio presso uno afferente all’area penale all’interno del carcere. Poi il Sert penitenziario iniziò ad avere i propri medici».
Un operatore mi parla dei cambiamenti maturati nel tempo: «Inizialmente l’approccio al trattamento del tossicodipendente era differente. Il novanta per cento consumava eroina. C’erano due fasce: chi era venuto in contatto con la sostanza negli anni Settanta e gli eroinomani cosiddetti post-terremoto dell’80. Per la maggior parte si somministrava metadone. Questo era meno concentrato, più liquido e zuccherino, e si dava nel bicchiere di plastica di media grandezza. Per un periodo si usarono anche bottigline da 20mg, per cui la somministrazione poteva essere a carico di qualsiasi figura professionale e non solo del medico, come invece è oggi. Progressivamente il metadone è divenuto più concentrato, meno zuccherino e somministrato in bicchieri poco più alti di quelli da caffè. Inoltre, il metadone si estraeva a mano, mentre oggi una macchina dosatrice riceve l’informazione da un pc ed eroga la quantità da assumere al momento e quella in affido. Anni fa, l’affido non era previsto e ci si recava al Sert ogni giorno. Il Sert era perciò aperto anche di sabato e domenica. Inoltre, i protocolli terapeutici erano rigidi sia per i dosaggi che per le tempistiche. Per esempio, un trattamento durava un tot di tempo. L’esame tossicologico non era strumento anche d’indagine, come oggi, ma solo di controllo. Se eri pulito non ti stavi drogando, se l’esame era sporco stavi combinando “qualcosa” durante la terapia. E qui scattava la logica della riduzione del danno: se fossi risultato positivo all’esame tossicologico ti avrebbero sospeso la terapia per tre-quattro giorni e non avresti potuto assumere più di 30mg di metadone».
Queste informazioni le raccolgo spesso anche tra gli psicoterapeuti, gli psicologi e gli assistenti sociali. Fatto, questo, che da un lato denota una buona preparazione trasversale, ma provocatoriamente potrei pensare che vi è una medicalizzazione del servizio anche laddove l’ultima cosa che interessa è la sostanza.
Guarda dottoressa che io sento un vuoto che neanche l’eroina colma più. Io vorrei svegliarmi solo per sapere quando morirò e vorrei essere utile ad altri perché per me stesso non posso fare più niente (C., utente del servizio).
Capisco, stando nelle strutture e leggendo e ascoltando, che la dipendenza non è un sintomo, ma sembra un velo su questo. La logica era (e in alcuni casi è) un tossicologico per “sorvegliare” e una riduzione del danno per “punire”, proprio come atteggiamento culturale diffuso. Un medico penitenziario mi dice che «questo sevizio è tra i primi (territoriali) a somministrare 40mg di metadone nonostante l’interruzione delle terapie in seguito a tossicologico positivo. Tale dato, apparentemente irrilevante, ha una sua portata rivoluzionaria». Me la descrive come una battaglia che ha portato ad affermare che non si può somministrare una quantità irrisoria di copertura per l’inibizione degli oppiacei. È un primo scarto da una logica punitiva.
L’adeguamento è stato progressivo. Un assistente sociale mi racconta che «nel servizio la popolazione delinque molto. Oggi è ancora più difficile perché ci sono nuovi fenomeni che avanzano, come chi sostituisce o inizia direttamente con l’iniettarsi il metadone anziché cocaina o eroina, per esempio». E prosegue: «Qua socialmente siamo tra un’area industriale e il nulla», caratterizzando la geografia esistenziale del luogo. Parlando con alcuni operatori che prestano servizio direttamente in strada mi spiegano che «quella del metadone in vena è una pratica che riguarda per lo più i migranti di varie aree europee, che giunti qui e insoddisfatti della qualità dell’eroina attaccano direttamente con il metadone. In prospettiva sarà diffusa fino a diventare un’emergenza in pochi anni. I tossicomani scambiano tra loro, oltreché le siringhe, anche le abitudini e, convivendo, si portano a conoscenza delle rispettive innovazioni in materia di consumo».
Ci si interroga nelle riunioni integrate tra più équipe sui possibili risvolti dei nuovi fenomeni. E si interrogano, per così dire, le “fonti” mediante focus group permanenti composti da utenti e operatori. Nella mancanza di una o più soluzioni, si può ragionare con gli utenti “navigati” che, in alcuni casi, sono disposti a riunirsi e dialogare con chi sta sul “loro” territorio da anni, uscendo dalle scrivanie.
Un elemento che accomuna operatori e utenti è che il Sert è la loro fonte di reddito. Chi percependo stipendio, chi vendendo il metadone che dovrebbe assumere. Una fonte che, nell’utenza, placa anche l’emergenza di delinquere per farsi. Diventa un bene da scambiare, sul quale capitalizzare. Un operatore “di strada” commenta: «L’invasione del metadone sul mercato delle droghe è relativamente recente. Si è spesso scambiato o venduto, ma oggi la soglia è emergenziale. Si rileva anche dall’abbassamento del consumo di acqua distillata per sciogliere la cocaina da iniettare, c’è il metadone e quindi come sostanze si alternano».
Al momento, nel servizio, il settanta per cento dell’utenza assume il metadone e il trenta il suboxone. Durante le riunioni ci si ferma a riflettere sul problema della cronicizzazione delle terapie. Un medico dice: «Io distinguo il tossicomane “veterano”, quello dopo il 1980, che ha un dosaggio di metadone medio-basso sennò non sente l’eroina, da quello che non la usa più e si assesta su un dosaggio di 25-30mg per tenersi a bada».
Mi chiedo se sia questo il lato “categorizzante” che rende più facile la sopravvivenza a chi opera in questi luoghi. Un giovane medico afferma che, nella sua esperienza, «è più facile uscire dalla dipendenza da stupefacenti che dalla dipendenza da alcol, anche perché il servizio pubblico ha un atteggiamento “piccolissimo” nei confronti dell’abuso di alcol. La percentuale di alcolisti della zona che si iscrivono al percorso di cura è infinitesimale».
La nuova frontiera delle dipendenze è il gioco d’azzardo patologico. «Tra poco ne saremo letteralmente assaliti, quello che oggi ci sembra dilagante può ancora peggiorare», mi dice un medico che si occupa della prevenzione attiva in questa zona. «Fin dai quindici anni, emulando anche i genitori, i ragazzi cominciano con la schedina, con “la bolletta”, giocando cifre alte che spesso non posseggono, almeno tre o quattro volte alla settimana. Si continua con tutto ciò su cui si può scommettere, a casa via internet o nei bar/tabacchi con le slot machine».
In questi anni, assistiamo anche all’uso dei sistemi di rilevazione che sostituiscono le cartelle cliniche. Informatizzano, monitorano. Lo strumento è di mandato ministeriale e prevede un progressivo adeguamento alla modalità digitale. Così alcuni medici annoiati si occupano di trascrivere tutto quanto è cartaceo. Aprendo il programma si trova la storia clinica del paziente, una scheda che comprende la biografia, lo status socio-economico, il “modus vivendi” (categorizzazione non chiara e discutibile). La scheda sociale non è ancora attiva nel servizio ed è di competenza dell’assistente sociale. C’è anche la scheda psicologica che vede quattro voci fondamentali: psicodiagnostica, test somministrati, colloqui, obiettivi di intervento e uno spazio per “varie”. Il criterio generale del programma si rifà ai Livelli Essenziali di Assistenza richiesti dallo stato e dalle regioni. Mentre mi confronto con questi programmi continuo a chiedermi l’essere umano in sé, dove sia.
IL CUORE NEGLI OCCHI
Un maestro mi ha ripetuto per anni
«stai tra le persone e mai nelle stanze».
E allora sono uscita. E per fortuna, sono ancora arrabbiata.
Bisogna sempre stare attenti a non cadere troppo negli occhi di chi arriva, di chi si incontra nei servizi “di strada”. Attenti a non mettersi dall’altra parte dei banconi e delle scrivanie, neanche con il pensiero. Intercettare un qualsiasi segnale ignorato è cosa malvista. Attenti a non lasciare neanche una sedia in giro, affinché il tossico si trattenga il meno possibile. Eppure, una operatrice mi dice: «La mia battaglia è contrastare il discostamento dell’utente dal servizio potenziando e recuperando la relazione delle persone con questo luogo». Forse per questo la battaglia è sempre in corso. Alle spalle di questi “operatori-monade” c’è una cultura di servizio evitante.
Maria un pomeriggio senza sole mi dirà:
io vorrei parlare con te dottoressa ma questi si finiscono tutto.
In una stanza semibuia dall’odore di urina rancida, sotto le abitazioni fatiscenti, un gruppo di quattro persone si prepara a fumare la dose di qualcosa che di lì a poco gli farà dimenticare di essere lì. Almeno per un momento. Arriva il quinto componente che mancava con un cartone di succo di frutta perché
dottore’, vuje ‘o sapite, si ‘nce piglia storta ‘o zucchero è ‘a primma cosa. (mai drogarsi senza avere bevande zuccherine alla mano).
Lucia,
dottore’, io non vi chiedo di favorire perché nun posso mai pensa’ che ‘na dottoressa se fa, ma se volete siamo tra amici (dottoressa io non le offro la sostanza perché mi stupirebbe che lei ne facesse uso, ma ove mai volesse si senta tra amici).
Quindi gli lascio del materiale pulito e me ne vado. Mi hanno insegnato che se non ti siedi alla tavola degli ospiti, restare a guardarli non è educato.
Alla rinfusa, le voci della giornata ti camminano dietro mentre torni a casa.
Mario, sessanta anni ne dimostra quaranta. Bellissimo. Barbiere. Un passato tra droghe e amanti, per lo più dell’est, la famiglia “gli ha voltato le spalle” e lui chiede se possiamo aiutarlo a non svegliarsi più.
Ma non c’è un modo per cui mi fate morire e poi diciamo che è stato un incidente, ja ve prego.
A. un giorno entra con un coltello. Dice che se non avrà i documenti per il figlio taglia la gola a tutti. Si dimena così tanto con quella lama che penso possa infilarsela da qualche parte. Alla fine, piange e si calma. Nessun arresto, nessuna denuncia.
Un bambino chiede dove può aspettare la madre. Ci mettiamo a disegnare e mi dice
tu lo sai perché mamma viene qua?
No – rispondo –, me lo spieghi tu?
Smette di disegnare.
Perché cadeva sempre, cadeva mentre faceva le cose o dopo che andava in bagno. Adesso il dottore gli ha dato una medicina che non la fa cadere più.
Un ragazzo che si buca in femorale sostiene che l’arto gli andrà in cancrena perché usa gli aghi da dieci (mm). Gli chiedo perché non usa un millimetraggio inferiore.
Dottore’, ma nun è bello moralmente togliere quelli da cinque a mammà, chella è diabetica. Na cosa so’ ‘e sorde da int’ ‘o borzellino ogni tanto, un’altra è levarle l’ago suo. Chella s’adda fa l’insulina! (le sembra moralmente accettabile sottrarre gli aghi dell’insulina a mia madre, che è diabetica, per bucarmi?).
Una donna che fa uso di sostanze ha il marito da poco inserito in una comunità
ecsalusso (extra-lusso) dottore’, una cosa esagerata, mai vista.
Però non lo va a trovare perché l’hanno cacciato quando li hanno trovati a fare l’amore durante un giorno in cui lei era andata a fargli visita, lì era vietato.
Perché io non sono scema che mi porto la roba là, però siamo comunque marito e moglie… Si nun ‘o faccio je, po’ chille se chiava a un’altra stesso lloc’ dint’. (Non sono così stupida da introdurre sostanze stupefacenti all’interno della comunità di recupero che lo ospita, però siamo pur sempre sposati. Finisce che, se non sta con me, si accompagna con un’altra residente della comunità).
Una madre, figlio detenuto al primo arresto.
Dottore’, ma poi se gli devono dare gli psicofarmaci nun era meglio ca se facev’ a casa, almeno stev’ cu’ mme. Io lo controllavo pure. Per esempio, isso mo ddev’ a mme e io ce governav’ ‘a robba, avite capito? (Ma se in carcere gli somministrano gli psicofarmaci, allora era meglio che stesse in casa con me perché io lo controllo. Lui mi cede le dosi e io gli amministro il quantitativo).
Un ragazzo di ventitré anni sa di aver fatto «cose che non si devono fare», ma forse era meglio se lo beccavano e andava in carcere, così la madre non l’avrebbe più trattato come uno stupido.
Dottore’, il carcere è formativo, mi avrei imparato la cazzimma.
L’ARIA CHE SI RESPIRA
Quando arrivano i “nuovi” una delle prassi è che te li affiancano perché così gli trasmetti quello che hai imparato. E così, sorridendo, sai già che nulla li “salverà” da quello contro cui andranno a sbattere.
Cosa dire a coloro che mi sono affiancati? (preferirei “di fianco”; “vicini”). Di stare in silenzio.
Lo impari, quel tipo di silenzio. Quello che resta quando cadono le illusioni. Si frantumano.
Di non curarsi della incuria altrui. Che un servizio può essere usurante con l’essere reazionari che dilaga.
A dire “grazie”. Di questo orrore. Poche cose possono insegnare di più.
I servizi possono essere “città invisibili”. Ognuno fa il minimo indispensabile e “scarica il barile” sul collega con tono sibillino, in modo da non arrivare mai al conflitto e continuare a logorarsi di rancore. Molti operatori hanno dimenticato perché stanno lì o forse non se lo sono mai chiesti o forse questa è una di quelle domande che per sopravvivere non devi farti. In questi servizi non c’è quasi nulla di trasformativo. Si procede, giorno per giorno, con inevitabile cinismo, dopo anni e anni ci si è dovuti abituare all’inenarrabile e così si va avanti fluttuando tra atteggiamento giudicante ed evitante, infastiditi dall’utenza. Nessuno sostiene gli operatori e gli operatori non possono sostenere nessuno.
L’aria è pesante. Alle volte superficialmente leggera. Comprendo che quando l’ennesimo utente arriva davanti a te strafatto e ridendo e pensa di poterti prendere in giro, rispondendo a domande che non gli hai fatto, dando giustificazioni che non gli hai chiesto, e dopo dieci minuti lo vedi a venderselo quel metadone però «dotto’, datemelo in bottigliette separate così rispetto il dosaggio».
Le domande sono poche e sempre le stesse. «Quanti mg prendi tu?», «ma perché già stai qua? È martedì, tu hai l’affido settimanale». E gli utenti: «L’ho perso, l’ho finito, mi è caduto, l’ho preso in una notte sola, me lo dai per tre settimane che ho preso un lavoro fuori».
Sudati, tremanti, ansimanti, occhi vuoti, consumati. Potresti trapassarli. Alcuni sono ologrammi.
E i bambini? Ma che ci fanno i bambini al Sert mi sono sempre chiesta. Ma perché ce li portano, ma perché li fanno entrare se fuori c’è il sole. Ho disegnato, giocato, parlato con più bambini al servizio che facendo la baby-sitter. Se qualcuno è in attesa perché c’è fila e metti una sedia per farlo accomodare, mentre piange e non sai se è vero, ma «siamo operatori e non indaghiamo la verità, stiamo sulla persona», e allora stai sul suo pianto vero e finto perché una disperazione può sempre dirti qualcosa, il medico di turno arriva e ti chiede di togliere la sedia perché «la stanza del metadone non è il luogo per parlare» e non devi intercettare utenti nel loro territorio perché «sono pallisti, sono sporchi, poi non se ne vanno più, ne ho altri dieci fuori, all’una me ne devo andare». I più sono prodighi a “insegnarti” qualcosa per reprimere in partenza qualsiasi iniziativa che possa modificare lo stato delle cose.
Si ride in modo amaro, per qualsiasi cosa, ma sorrisi sentiti nessuno ne fa a nessuno. Se un utente sta in piedi con la faccia bassa, se un parente, una madre, un figlio prendono una terapia per conto di qualcun altro con gli occhi lucidi dalla vergogna, spesso non gli si risponde né «buongiorno» né «prego». In quel frangente, qualcuno entra urlando i fatti suoi, parlando di cosa ha fatto o farà, chiedendo agli altri se il rigore c’era, rivolgendosi con domande inopportune o facendo battute che non fanno neanche piangere. E non li mandi a quel paese ma non li assecondi, per non diventare come loro. L’abilità principale del servizio è evitare di essere chiari, sottrarsi. Non farsi e non fare domande.
La tensione si taglia con il coltello e al minimo evento si scivola in discussioni infinite che sono il coacervo di sentimenti negativi trascinati per i corridoi e le stanze da anni. Ammassi di risentimento.
Durante i colloqui le porte si aprono, i telefonini squillano, «faccio presto, dove andiamo a mangiare?». Alle volte ci sono sedie comode o poltrone dietro la scrivania e l’utente deve stare su una sediolina di legno, di quelle da scuola elementare, tra due persone che gli parlano in una stanza bianca e spoglia. Bene che gli va lui è un faldone, una cartella. E se sei volontario… le attività le segui preferibilmente con il culo sui davanzali. Anche appendere una stampa al muro è un problema, però nessuno motiva il perché.
Usciamo. Nel complesso il servizio è scarno, se non fosse per qualche locandina qui e là (programma per le donne in gravidanza che fanno uso di sostanze, la più vistosa) e discutibili quadri di repertorio. Le mura esterne sono logore e la sua posizione è nascosta. Di fronte all’ingresso, un’edicola votiva. Di fianco, attività abbandonate. Ai lati, utenti di varia natura. Già dall’ingresso la struttura sembra un carcere con un cartello che dice “vieni a essere felice da noi”.
L’immaginazione corre, ogni volta che si entra in questo servizio. Potrebbe essere allestito in moltissimi modi, tranne quello esistente. I servizi prendono in carico? O tengono a bada la soglia dell’emergenza che potrebbe sfociare in qualcosa di più dannoso per il contesto? Il tutto avviene in silenzio, perché anche chi deve assistere è, a sua volta, spesso invisibile. Dunque, chi sono gli “utenti”? (lucia mondella)
[1] L’Unità operativa di salute mentale rappresenta la principale ripartizione territoriale del Dipartimento di salute mentale, competente sul bacino d’utenza di uno o più distretti sanitari.
[3] Legge 162: I Ser.T. dispongono di una propria dotazione organica comprendente diverse figure professionali qualificate e specializzate: medici, psicologi, assistenti sociali, educatori, infermieri, amministrativi e altro personale di supporto.




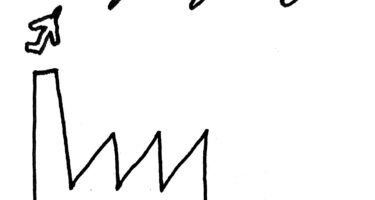
Leave a Reply